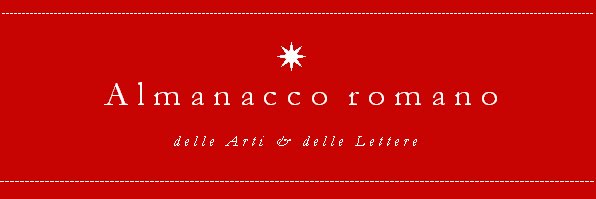minima / In hoc signo vinces
L'Europa vuole perdere.
martedì 3 novembre 2009
Etichette:
L'Europa e la croce
lunedì 2 novembre 2009
Rito romano
~ UN CATAFALCO NERO E ARGENTO, UN PALCO PER LA VITTORIA PROVVISORIA DELLA MORTE, VIENE INNALZATO OGGI NELLA CHIESA DELLA TRINITÀ DEI PELLEGRINI, E LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ASSUME TONI BAROCCHI. ~ MA PER TUTTO L’ANNO L’ANTICA LITURGIA CHE RIPRENDE VITA IN QUESTA CHIESA DI ROMA HA LE FORME SONTUOSE DI RUBENS, LE CADENZE DI PALESTRINA. ~
a D. P.
in memoriam
Nulla invecchia maggiormente delle opere estetiche moderniste. Basta guardare gli oggetti dell’avanguardia del dopoguerra, le piccole utopie ribelli seguite alle grandi ribellioni che produssero il disastro, i segni puerili della dissoluzione: che aria polverosa, d’altri tempi, di irrimediabile estraneità; realizzati negli anni della nostra infanzia, sono già bisognosi di perenni quanto ardui restauri; l’effimero, artificiosamente custodito oltre il suo giorno, si sbriciola, muore. E si metta a confronto simile paccottiglia ludica, e ormai assai malinconica, con le sculture dell’ellenismo o con la radiosa pittura del gotico senese: nonostante i molti secoli trascorsi, la vitalità dell’arte resiste. Chi invece fa del nuovo assoluto la sua bandiera crolla nel giro di una stagione, e appena passata la moda è dannato al marchio del «démodé». Anche la liturgia della messa uscita dal Vaticano II, volendo cancellare troppe pagine della tradizione, credendo di trovarsi all’incrocio decisivo della storia dell’umanità, finì per risentire terribilmente dell’arte e della cultura anni Sessanta, oggi in via di sparizione. Quei fragili esperimenti pretendevano, nei casi migliori, fare tabula rasa dei linguaggi che avevano reso possibili i grandi massacri, sperando con fede magica che la cancellazione delle parole portasse via anche gli incubi della storia. I corsi e ricorsi culturali potevano correggersi di generazione in generazione – in breve ci si accorse infatti della impossibilità di vivere nell’abrasione del passato e con un idioma inventato, del tutto artificiale –, mentre la messa novecentesca, troppo legata a tali mondani interessi, restò con le stigmate delle assemblee politiche e del teatro cosiddetto dell’assurdo (ossia di un mistero che non trova scioglimento, né parola finale di verità). L’influenza teatrale era evidente, a cominciare dalla scenografia spoglia; l’influenza politica trascinava al centro la plebs Dei, popolo non più genuflesso e orante ma assiso intorno al prete alla maniera delle assemblee operaie, dove alcuni fedeli andavano all’ambone come si sale alla tribuna per pronunciare un intervento. Del resto, ancora oggi, le nuove chiese sono l’ultima traccia dell’architettura industriale in via di sparizione, templi dell’ideologia pauperista quasi mai sfiorati dai vezzi e dai lussi del pur onnipotente post-moderno. La casa di Dio è diventata un fabbricone acromatico, uno spazio dell’angoscia sociale, in stretta continuità con le peggiori brutture del mondo. In quegli edifici che nulla mantenevano dunque della gaudiosa architettura cattolica, elastico divenne il cerimoniale, i silenzi si protraevano a piacere, sopraggiungevano contributi imprevisti dei presenti, canti aggiunti, preghiere inventate ex novo, si moltiplicavano insomma le varianti. Il tempo liturgico, che dovrebbe riflettere quello eterno, si trasformava in un fragile contenitore dove l’attualità poteva entrare a ogni istante con il suo strascico di miserie. Le asimmetrie dei candelieri, della croce, del tabernacolo, riecheggivano le tavole eleganti imbandite dalle dame alla moda in anni sghembi che introducevano la rivoluzione negli ambienti borghesi. Design di gusto adorniano, coltivato in quel Nord Europa già addestrato dalla severità protestante; architettura del Bauhaus che rinnegava l’arte per la comunicazione; rifiuto se non disgusto fisico per le forme mediterranee dove si ebbe la coltura del cattolicesimo («esiste un’affettività antiromana» sostenne Carl Schmitt con buon fiuto). In queste traversie estetiche fu approntata la liturgia del tardo Novecento. C’era però un grosso problema: le «arti» e i linguaggi nuovi sembravano indirizzati da un destino beffardo verso un unico approdo: l’ironia e la parodia. Poteva la cerimonia del divino ricorrere a simili forme espressive?
Con una punta di ingenuità, gli ideatori della nuova messa credettero nella trasparenza delle lingue volgari, come se bastasse ricorrere al «gergo della massaia al mercato», secondo la celebre indicazione del Lutero traduttore biblico, per rendere eloquente la parola divina. Né d’altra parte si vedevano schiere di geniali Lutero forgiare la parola moderna, anzi neanche mezzo luccicò, soltanto dei buoni studiosi che si arrovellavano ad aggiornare – termine fatale – l’arcaico lessico ebraico-aramaico-greco, non prevedendo la rapida usura che sarebbe sopraggiunta quando si fanno parlare i profeti come degli scrittori garbati piuttosto che con la sonorità dei poeti latini. Ma, al di là dei modelli letterari, la facile credenza nella parola trasparente portava alla conclusione che bastasse la traduzione per illuminare i fedeli: doveva essere alla portata di tutti quel succo difficile, che risultava incomprensibile anche ai sommi teologi e filosofi, in modo da ridurre il mistero alle semplificazioni del nostro tempo, al sapere democratico che mastica ogni cosa con noncuranza e guarda con timore e tremore soltanto alla scienza. Tale atteggiamento suscitava l’arguzia di un celeberrimo interprete, maestro nella resa in lingua italiana di alcuni capolavori ebraici e latini, Guido Ceronetti, che si chiedeva quanto la popolana, sempre tirata in ballo in simili controversie, capisse della risposta «e con il tuo spirito» rivolta al celebrante, la formula restando altrettanto ostica, in quanto ricchissima di significato, anche trasposta nel lessico quotidiano. Più in generale, Montaigne riteneva che le lingue moderne fossero troppo languide per trattare temi gravi, noi senza Dante, Montaigne, Lutero, Goethe, senza neppure i loro epigoni ottocenteschi, osammo ricostruire la lingua di Dio avendo nelle orecchie le dissonanti formule del Gruppe 47 o del nostrano Gruppo 63 se non il forzoso periodare e il fumosissimo lessico di saggi e articoli di una triste stagione, forse tra le più magre della storia letteraria europea.
L’uso del latino nei sacri riti non fu cancellato dal Concilio, come spesso viene creduto, si mise mano al novus ordo anzi quando i padri conciliari se ne erano tornati a casa. Procendendo da indicazioni generiche, si accantonò allora il «rito romano antico», per meglio dire lo si tolse proprio di mezzo, lo si proibì come un’eresia, senza sfumature, senza periodi di trapasso, senza il rispetto che il Concilio di Trento ebbe per i riti in vigore «da almeno duecento anni», senza aspettare che le generazioni di vecchi morissero con le formule di sempre. Furono privati delle loro preghiere i cristiani che ebbero la sventura di invecchiare in quel tempo. Erano abituati a distinguere il sacro dal profano, l’altare da tutto il resto, avevano nel cuore la segreta cortina che circonda il sancta sanctorum, la loggia degli angeli, dove accedevano reverenti solo privilegiati fedeli, di sesso maschile, in genere con apposite vesti; abbattute le balaustre, furono costretti a vedervi donne in pantaloni e uomini in magliettina che leggevano i sacri testi. Repressione dei sentimenti più semplici, delle passioni più tenere, educazione forzata, secondo l’uso rivoluzionario, che è l’opposto della carità cristiana, da parte di pretini saccenti. Piccole guerriglie iconoclaste sottrassero quadri di santi ai loro devoti, profanarono amate reliquie, vendettero agli antiquari sacre suppellettili, nascosero le antiche preghiere, sostituite con tante chiacchiere, riverbero della nevrosi assembleare, abolirono il canto gregoriano, la polifonia, il suono degli organi a canne, per strumenti elettronici chiesti in prestito al rock. I più incolti dei contadini avevano biascicato in chiesa il latino, mescolando sonorità, adattando ad sensum, spesso con strafalcioni, sempre rosicchiando le desinenze, proprio come avevano fatto gli antenati quando diedero vita alla lingua volgare. In nomine Domini, Dio parlava loro così, consolava così. I nostri padri e madri furono sepolti con parole corrive, sconsacrate, che sembravano non tenere a bada la morte, le forze dell’Inferno.
Per decenni, anche nell’urbe santa, il rito romano fu «imbavagliato» (Ceronetti). Più recentemente, i suoi fedeli erano costretti a radunarsi in una chiesina sconosciuta ai più, in una viuzza cieca, in una clandestinità da catacombe durante la persecuzione pagana. Ovviamente qui nessuno perseguitava nessuno, ci si limitava allo scherno per i nostalgici, gli ignoranti, i «fascisti» si disse pure. Un tedesco che si era distinto per intelligenza e sapere nel Concilio novecentesco, Joseph Ratzinger, si mostrerà colpito da tanta acrimonia: «Rimasi sbigottito per il divieto del messale antico, dal momento che una cosa simile non si era mai verificata in tutta la storia della liturgia». Già, perché il rito romano non risale al Concilio di Trento, come spesso si fa credere, condannandolo in questo modo al discredito che in certi ambienti clericali ancora avvolge la Controriforma, bensì al cristianesimo delle origini. Gregorio Magno lo codificò, gregoriano perciò dovrebbe esser chiamato prima che tridentino. San Pio V, nello spirito conciliare, con immenso scrupolo, anche filologico, redasse un messale che riordinava una tradizione più che millenaria.
Invano uno stuolo di letterati, artisti, musicisti, filosofi e cineasti chiese al papa di lasciare sopravvivere, magari in qualche tempio marginale, il segno della continuità con la Chiesa del genio cattolico. L’appello era promosso da Cristina Campo e firmato da Wynstan Hugh Auden, José Bergamìn, Robert Bresson, Benjamin Britten, Jorge Luis Borges, Cristina Campo, Pablo Casals, Elena Croce, Fedele D’Amico, Luigi Dallapiccola, Giorgio De Chirico, Tammaro De Marinis, Augusto Del Noce, Salvador De Madariaga, Carl Theodor Dreyer, Francesco Gabrieli, Julien Green, Jorge Guillén, Hélène Kazantzakis, Lanza Del Vasto, Gertrud von Le Fort, Gabriel Marcel, Jacques Maritain, François Mauriac, Eugenio Montale, Victoria Ocampo, Nino Perrotta, Goffredo Petrassi, Ildebrando Pizzetti, Salvatore Quasimodo, Elsa Respighi, Augusto Roncaglia, Wally Toscanini, Philip Toynbee, Evelyn Waugh, Marìa Zambrano, Elèmire Zolla. Quando mai si adunò un numero di tanti eletti personaggi d’ogni continente per una pubblica richiesta?
Un vero paradosso intanto si produceva: veniva riconosciuto il diritto all’esistenza in seno al cattolicesimo del rito ambrosiano, greco, armeno, melkita, copto, maronita, mozarabico (in un viaggio in Spagna, Giovanni Paolo II celebrò nel canone ‘visgotico’ come pure è chiamato) e vari altri, ma per il rito latino non c’era più posto. Tollerante e benigna verso gli arcaismi di tutte le culture, la Chiesa di Roma riservava per sé la modernità assoluta. Nonostante questa ‘clandestinità’ durata alcuni decenni, il rito romano rifulge ancor oggi, classico. A cominciare dalla sua lingua, il latino. Era parlato dai popoli che formavano l’Impero, era il simbolo dell’universalismo, l’esatto contrario del radicamento romantico del linguaggio nel suolo, resta la forma salda che cede meno di altre al corso dei tempi, «corazza d’oro della Chiesa» lo chiamò qualcuno.
Nella Roma rinascimentale, tra Campo de’ Fiori e il Tevere, un eroe della Controriforma, Filippo Neri, accoglieva e ospitava i derelitti nelle case private di suoi generosi amici, poi l’opera pia si trasformò in un immenso ospizio (ospedale, albergo, luogo di conforto) che da allora, per secoli, funzionò da dormitorio e mensa per le immense folle dei giubilei seicenteschi e per i viaggiatori di mezzo mondo che quotidianamente venivano a pregare sulla tomba di Pietro. La attigua chiesa della Trinità dei Pellegrini deve il nome a questa impresa di carità cristiana (nell’ospedale, il giovane Mameli, l’autore dell’inno d’Italia, venuto a combattere il papa tra i volontari della Repubblica romana, fu assistito nella sua agonia). In questa chiesa che si presenta con una facciata tardo-barocca disegnata da Francesco De Sanctis, l’autore della scalinata di Trinità dei Monti, si celebra tutti i giorni, finalmente alla luce del sole, la messa di «rito romano antico», naturalmente in latino. È un dono di Benedetto XVI alla sua diocesi. Lo sguardo profano lo considerà come il confinamento in una ‘riserva indiana’, quello metafisico vi intravede il polmone nascosto della Chiesa.
Ieri la festa d’Ognissanti era celebrata alla Trinità con un pontificale dalla maestosità rubensiana, oggi, nel giorno consacrato alla commemorazione dei defunti, una messa solenne esorcizza i trionfi della morte. I celebranti indossano i paramenti neri, al centro della chiesa, tra sei candelieri con i ceri accesi, si eleva un catafalco sormontato da un simbolico feretro. Il catafalco ormai è sconosciuto ai più. Un tempo, invece, soltanto le bare degli aristocratici, per estremo atto di umiltà dopo una vita sfarzosa, venivano deposte sulla nuda terra. Gli altri cristiani in morte erano innalzati: il corpo umano diventato cadavere saliva su questo barocco apparato, giustappunto un palco secondo una spiegazione etimologica, rivestito di drappi liturgici neri trapuntati d’oro o d’argento, circondato dai ceri. Riconsacrato ancora una volta, a segnare davanti alla comunità che lo accompagnava nell’ultimo viaggio il fatto, incontrovertibile per i cattolici, che mentre comincia il processo di decomposizione della carne si apre anche una glorificazione della medesima carne che troverà in Cielo il suo massimo splendore alla fine dei tempi. Nei funerali post-conciliari, il violetto sostituisce il troppo luttuoso nero, quasi si dovessero smorzare le tinte del dramma, la bara è abbandonata sul pavimento, lasciata sola fisicamente mentre le chiacchiere profane dei parenti e degli amici si mescolano alle parole liturgiche del sacerdote, in un rito che somiglia talvolta a quello civile tanto il sacro si ritira, appena rischiarato dal cero pasquale, in un timido accenno all’immortalità. Non c’è comunque il memento mori che discende da quel palco, il grande spettacolo della morte cristiana che grida il dolore di essere strappati a questo mondo e promette una vita ancor più bella nell’aldilà. Per un simile rituale cattolico, per le messe da requiem in rito romano, composero i massimi musicisti dell’Occidente, da Mozart a Verdi; a quei tempi i luterani provavano la mancanza di un culto che appariva insuperabile per alleviare il dolore umano e, nel tentativo di riecheggiarne i modi, Brahms scrisse Ein deutsche Requiem, un Requiem tedesco.
I gesti, gli inchini dell’antica liturgia: ogni atto conferma una gerarchia, nel rito romano. C’è un imperatore del mondo, dice la Chiesa delle origini, con una metafora certo appartenente a quell’epoca ma compresa o comunque intuita per secoli e a ogni latitudine. È arduo del resto immaginare un Dio presidente della repubblica, una partecipazione democratica della creatura alla volontà dell’Assoluto. La collaborazione di Adamo alla creazione divina, alla creazione della lingua umana (Genesi, 2,18-20), è una bellissima premessa alla nostra storia ma non ha nulla di ‘democratico’, e se proprio un riferimento storico va cercato, si potrebbe parlare di un investimento feudale. Sarà meglio evocare la lotta di Giacobbe, il tentativo di forzare il Creatore, una battaglia d’amore, un drammatico scontro padre e figlio su scala universale, conflitto riproposto da Cristo sulla croce. Un mistico scontro insomma piuttosto di una conta di voti, piuttosto di un’assemblea che dà mandato al suo Dio. Sarà pure un valoroso compito allora, nella confusione del moderno, stabilire una traduzione di quella traditio spesso oscura ai nostri occhi – e negli ultimi due secoli, con sofferenza e ingegno nobili figure del cattolicesimo si impegnarono in tal senso – ma ci deve essere un originale ben saldo e splendente, un testo netto e sempre rintracciabile da cui tradurre, per non esporci ai pericoli di ricollocare nelle origini l’idolatria del senso comune attuale. Inoltre, l’originale deve essere riconosciuto come un testo sacro, non soltanto storico, altrimenti si finisce in una letteraria querelle degli antichi e dei moderni.
C’è un apologo sorto nell’ebraismo chassidico, riportato da numerosi narratori jiddish, che potrebbe fungere da sentenza sulla soglia dell’opera non solo letteraria di Kafka, e che rischiara la parabola discendente della religione nello stentato compromesso con il moderno più devastante: «Quando il Baal-Schem si trovava di fronte a un compito difficile, andava in un certo luogo del bosco, accendeva un fuoco e meditava pregando, e sempre fu eseguito quel che egli aveva deciso. Una generazione dopo, quando il Magghid di Meseritz si trovò di fronte al medesimo compito, andò allo stesso posto del bosco e disse: “Accendere il fuoco noi non possiamo più, ma le preghiere possiamo ancora dirle”, e quel che desiderava divenne realtà. Ancora una generazione più tardi, Rabbi Moshé Leib di Sassov, di fronte a un analogo impegno, andò anche lui nel bosco e disse: “Non siamo più in grado di accendere il fuoco e non conosciamo più le meditazioni segrete che fan parte della preghiera, ma il posto del bosco dove tutto questo avvenne lo conosciamo, e questo dovrebbe bastare”. E infatti bastò. Ma quando un’altra generazione dopo, Rabbi Israel di Richine si trovò di fronte al medesimo dovere, si sedette sulla sua poltrona dorata nel suo castello e disse: “Il fuoco non siamo più in grado di accenderlo, le preghiere non sappiamo più dire e neppure conosciamo più il posto preciso, ma possiamo tuttavia raccontare il fatto come in realtà è avvenuto”…» (versione di Shmuel Yosef Agnon). Della tradizione non resterebbe che il racconto, la letteratura come religione dei nostri giorni, il rito sostituito dalle letture e dalle omelie. Il moderno, è vero, spezza la catena delle generazioni, rovescia la superiorità sapienziale dei vecchi sui giovani, del modello sulla copia, si inorgoglisce della sua potenza che svilisce la forza del passato, che rende incerte le antiche fedi e mette perciò a rischio l’ebraismo riformato come il protestantesimo; la tradizione cattolica, la continuità apostolica, prova a resistergli proprio in virtù del possesso del messale che conserva fedelmente i sacri testi e in virtù della pratica dei sacri riti che al messale del Vetus Ordo Missae si attengono.
Cristina Campo viene in soccorso di questo «Almanacco» per quanto lo riguarda più da vicino, la questione cioè dell’arte oggi, ricollegando il problema estetico con il discorso svolto fin qui: «L’odio moderno per i riti… Il rito per eccellenza questa esperienza di morte-rigenerazione. So di parlare di qualcosa che i più non sanno che cosa sia, che qualcuno appena ricorda, che sopravvive soltanto in pochissimi luoghi sconosciuti. Sono quelli, io credo, i veri modelli, gli archetipi della poesia, che è figlia della liturgia come Dante dimostra da un capo all’altro della Commedia». Infatti, una liturgia informe e un’eclisse dell’arte vanno di pari passo. Bernard Berenson sembrava offrire un appoggio alle parole della scrittrice, pur parlando della scultura tardo-romana: nelle periodiche crisi «l’artista rimane abbandonato a se stesso, senza un modello che gli sia di mèta: intaglia e gratta, spalma e imbratta, per un vago impulso che gli urge da dentro, ma senza ben sapere che cosa vuol fare e dove vuole arrivare. A caso, uno dei meno incapaci, dotato di naturale talento per il proprio mestiere, può produrre qualcosa che appaga la sua vanità. Comunica la propria soddisfazione agli amici letterari: costoro raramente non riescono a convincere colui che esercita un’arte manuale, che i suoi prodotti, scolpiti o dipinti, sono un esempio di meditata, deliberata, metafisicamente fondata, cosmicamente inestimabile – novità» (L’Arco di Costantino o della decadenza della forma, Electa 1951).
Se non vuole finire nel disorientamento tratteggiatto da Berenson, nella parodia del «cosmicamente fondato», l’artista, l’arte, ha bisogno della liturgia e prima ancora della teologia. Andò così fin dalle origini, dalla scultura greca che dalla concezione della divinità derivava la bellezza umana: l’unica forma dignitosa per gli dèi era quella umana, e la perfezione si impadroniva allora dell’antropomorfismo divino come del teomorfismo umano. Per la pittura medioevale, rinascimentale e barocca, è ancora più evidente che nella Commedia di Dante la dipendenza dalla liturgia.
Estraneo alla cultura greca, il danese Kierkegaard si sdegnava per la ricerca di una immagine di Dio, dovendo l’Assoluto restare soltanto un mistero. Questa però è la cupa religiosità luterana, il cattolicesimo sottolinea invece l’incarnazione, la ostensione di Dio, di cui l’arte vuole essere l’eco. Iconofilia è anche credere al volto visibile del Mistero. I piccoli Kierkegaard senza tormento del nostro tempo criticheranno come idolatrica l’antica liturgia, ripeteranno l’accusa di estetismo. Certo, si dovrebbe replicare, la liturgia si svolge in forme umane, esteriori, non è un delirio né una visione interiore, può essere accompagnata dal «Kitsch linguistico, musicale, pittorico…» di cui parla Martin Mosebach nel suo L’eresia dell’informe (edito in italiano da Cantagalli di Siena) – titolo che allude alle commistioni con i veleni estetici di oggi –, oppure essere sorretta dall’arte contrappuntistica di Palestrina e discepoli che mette in musica la parola divina. E si può avere come in questa chiesa romana, quale vigoroso sussidio per la vista, la pala d’altare di Guido Reni (del soave Guido, come fu sempre chiamato dai contemporanei pure abituati ai toni sublimi) o un inguacchio di un tardo transavanguardista, commissionato o meglio subìto in quel di San Giovanni Rotondo da frati incolti che orecchiano la voga.
È dunque la bellezza cattolica a fare scandalo tra i negatori della immagine fisica di Dio. La qualità della preghiera, del rito, che non cede alla credenza diffusa secondo cui l’espressività informe sarebbe più adatta all’incontro con il divino. La domenica, nella chiesa della Trinità, si può constatare la potenza nell’universo sacro dell’arte visiva e dell’arte musicale rigorosissimamente strutturate. Il cerimoniale rigido, che prevede genuflessioni e inchini, gesti e precedenze, ha la stessa disciplina ed esattezza di un’opera d’arte, disegna una forma che si fa speculare della corte celeste. Al momento in cui il Simbolo costantinopolitano, cantato polifonicamente, professa coralmente la fede nel visibilium et invisibilium, lo sguardo corre per l’abside, alla ricerca delle cose visibili che rinviano a quelle invisibili, ai segni che qui sono pitture come la Trinità di Guido Reni, la Trinità raffigurata nelle fattezze umane. Moltissime chiese romane, potrebbero esser definite «il santuario della bellezza del corpo umano», come dice George Weigl della Sistina. Questo è il sentire cattolico.
Credo, scandisce il coro, in «unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam» davvero fatta carne, in continuità fisica con gli apostoli attraverso la catena di papi, vescovi e sacerdoti che si snoda nei secoli. La promessa divina ad Abramo si svolge nel tempo mediante la continuità di sangue, la stirpe ebraica; quella cristiana va oltre la filiazione di sangue ma ricorre ugualmente a un contatto fisico, il battesimo, la consacrazione sacerdotale degli eredi di quel drappello apostolico con l’imposizione delle mani, con l’unzione.
«Et exspecto resurrectionem mortuorum» si canta con la massima solennità. Aspettano tutti la «vitam venturi sæculi», e nella speranza la cerimonia si illumina di Paradiso. Amen.
a D. P.
in memoriam
Nulla invecchia maggiormente delle opere estetiche moderniste. Basta guardare gli oggetti dell’avanguardia del dopoguerra, le piccole utopie ribelli seguite alle grandi ribellioni che produssero il disastro, i segni puerili della dissoluzione: che aria polverosa, d’altri tempi, di irrimediabile estraneità; realizzati negli anni della nostra infanzia, sono già bisognosi di perenni quanto ardui restauri; l’effimero, artificiosamente custodito oltre il suo giorno, si sbriciola, muore. E si metta a confronto simile paccottiglia ludica, e ormai assai malinconica, con le sculture dell’ellenismo o con la radiosa pittura del gotico senese: nonostante i molti secoli trascorsi, la vitalità dell’arte resiste. Chi invece fa del nuovo assoluto la sua bandiera crolla nel giro di una stagione, e appena passata la moda è dannato al marchio del «démodé». Anche la liturgia della messa uscita dal Vaticano II, volendo cancellare troppe pagine della tradizione, credendo di trovarsi all’incrocio decisivo della storia dell’umanità, finì per risentire terribilmente dell’arte e della cultura anni Sessanta, oggi in via di sparizione. Quei fragili esperimenti pretendevano, nei casi migliori, fare tabula rasa dei linguaggi che avevano reso possibili i grandi massacri, sperando con fede magica che la cancellazione delle parole portasse via anche gli incubi della storia. I corsi e ricorsi culturali potevano correggersi di generazione in generazione – in breve ci si accorse infatti della impossibilità di vivere nell’abrasione del passato e con un idioma inventato, del tutto artificiale –, mentre la messa novecentesca, troppo legata a tali mondani interessi, restò con le stigmate delle assemblee politiche e del teatro cosiddetto dell’assurdo (ossia di un mistero che non trova scioglimento, né parola finale di verità). L’influenza teatrale era evidente, a cominciare dalla scenografia spoglia; l’influenza politica trascinava al centro la plebs Dei, popolo non più genuflesso e orante ma assiso intorno al prete alla maniera delle assemblee operaie, dove alcuni fedeli andavano all’ambone come si sale alla tribuna per pronunciare un intervento. Del resto, ancora oggi, le nuove chiese sono l’ultima traccia dell’architettura industriale in via di sparizione, templi dell’ideologia pauperista quasi mai sfiorati dai vezzi e dai lussi del pur onnipotente post-moderno. La casa di Dio è diventata un fabbricone acromatico, uno spazio dell’angoscia sociale, in stretta continuità con le peggiori brutture del mondo. In quegli edifici che nulla mantenevano dunque della gaudiosa architettura cattolica, elastico divenne il cerimoniale, i silenzi si protraevano a piacere, sopraggiungevano contributi imprevisti dei presenti, canti aggiunti, preghiere inventate ex novo, si moltiplicavano insomma le varianti. Il tempo liturgico, che dovrebbe riflettere quello eterno, si trasformava in un fragile contenitore dove l’attualità poteva entrare a ogni istante con il suo strascico di miserie. Le asimmetrie dei candelieri, della croce, del tabernacolo, riecheggivano le tavole eleganti imbandite dalle dame alla moda in anni sghembi che introducevano la rivoluzione negli ambienti borghesi. Design di gusto adorniano, coltivato in quel Nord Europa già addestrato dalla severità protestante; architettura del Bauhaus che rinnegava l’arte per la comunicazione; rifiuto se non disgusto fisico per le forme mediterranee dove si ebbe la coltura del cattolicesimo («esiste un’affettività antiromana» sostenne Carl Schmitt con buon fiuto). In queste traversie estetiche fu approntata la liturgia del tardo Novecento. C’era però un grosso problema: le «arti» e i linguaggi nuovi sembravano indirizzati da un destino beffardo verso un unico approdo: l’ironia e la parodia. Poteva la cerimonia del divino ricorrere a simili forme espressive?
Con una punta di ingenuità, gli ideatori della nuova messa credettero nella trasparenza delle lingue volgari, come se bastasse ricorrere al «gergo della massaia al mercato», secondo la celebre indicazione del Lutero traduttore biblico, per rendere eloquente la parola divina. Né d’altra parte si vedevano schiere di geniali Lutero forgiare la parola moderna, anzi neanche mezzo luccicò, soltanto dei buoni studiosi che si arrovellavano ad aggiornare – termine fatale – l’arcaico lessico ebraico-aramaico-greco, non prevedendo la rapida usura che sarebbe sopraggiunta quando si fanno parlare i profeti come degli scrittori garbati piuttosto che con la sonorità dei poeti latini. Ma, al di là dei modelli letterari, la facile credenza nella parola trasparente portava alla conclusione che bastasse la traduzione per illuminare i fedeli: doveva essere alla portata di tutti quel succo difficile, che risultava incomprensibile anche ai sommi teologi e filosofi, in modo da ridurre il mistero alle semplificazioni del nostro tempo, al sapere democratico che mastica ogni cosa con noncuranza e guarda con timore e tremore soltanto alla scienza. Tale atteggiamento suscitava l’arguzia di un celeberrimo interprete, maestro nella resa in lingua italiana di alcuni capolavori ebraici e latini, Guido Ceronetti, che si chiedeva quanto la popolana, sempre tirata in ballo in simili controversie, capisse della risposta «e con il tuo spirito» rivolta al celebrante, la formula restando altrettanto ostica, in quanto ricchissima di significato, anche trasposta nel lessico quotidiano. Più in generale, Montaigne riteneva che le lingue moderne fossero troppo languide per trattare temi gravi, noi senza Dante, Montaigne, Lutero, Goethe, senza neppure i loro epigoni ottocenteschi, osammo ricostruire la lingua di Dio avendo nelle orecchie le dissonanti formule del Gruppe 47 o del nostrano Gruppo 63 se non il forzoso periodare e il fumosissimo lessico di saggi e articoli di una triste stagione, forse tra le più magre della storia letteraria europea.
L’uso del latino nei sacri riti non fu cancellato dal Concilio, come spesso viene creduto, si mise mano al novus ordo anzi quando i padri conciliari se ne erano tornati a casa. Procendendo da indicazioni generiche, si accantonò allora il «rito romano antico», per meglio dire lo si tolse proprio di mezzo, lo si proibì come un’eresia, senza sfumature, senza periodi di trapasso, senza il rispetto che il Concilio di Trento ebbe per i riti in vigore «da almeno duecento anni», senza aspettare che le generazioni di vecchi morissero con le formule di sempre. Furono privati delle loro preghiere i cristiani che ebbero la sventura di invecchiare in quel tempo. Erano abituati a distinguere il sacro dal profano, l’altare da tutto il resto, avevano nel cuore la segreta cortina che circonda il sancta sanctorum, la loggia degli angeli, dove accedevano reverenti solo privilegiati fedeli, di sesso maschile, in genere con apposite vesti; abbattute le balaustre, furono costretti a vedervi donne in pantaloni e uomini in magliettina che leggevano i sacri testi. Repressione dei sentimenti più semplici, delle passioni più tenere, educazione forzata, secondo l’uso rivoluzionario, che è l’opposto della carità cristiana, da parte di pretini saccenti. Piccole guerriglie iconoclaste sottrassero quadri di santi ai loro devoti, profanarono amate reliquie, vendettero agli antiquari sacre suppellettili, nascosero le antiche preghiere, sostituite con tante chiacchiere, riverbero della nevrosi assembleare, abolirono il canto gregoriano, la polifonia, il suono degli organi a canne, per strumenti elettronici chiesti in prestito al rock. I più incolti dei contadini avevano biascicato in chiesa il latino, mescolando sonorità, adattando ad sensum, spesso con strafalcioni, sempre rosicchiando le desinenze, proprio come avevano fatto gli antenati quando diedero vita alla lingua volgare. In nomine Domini, Dio parlava loro così, consolava così. I nostri padri e madri furono sepolti con parole corrive, sconsacrate, che sembravano non tenere a bada la morte, le forze dell’Inferno.
Per decenni, anche nell’urbe santa, il rito romano fu «imbavagliato» (Ceronetti). Più recentemente, i suoi fedeli erano costretti a radunarsi in una chiesina sconosciuta ai più, in una viuzza cieca, in una clandestinità da catacombe durante la persecuzione pagana. Ovviamente qui nessuno perseguitava nessuno, ci si limitava allo scherno per i nostalgici, gli ignoranti, i «fascisti» si disse pure. Un tedesco che si era distinto per intelligenza e sapere nel Concilio novecentesco, Joseph Ratzinger, si mostrerà colpito da tanta acrimonia: «Rimasi sbigottito per il divieto del messale antico, dal momento che una cosa simile non si era mai verificata in tutta la storia della liturgia». Già, perché il rito romano non risale al Concilio di Trento, come spesso si fa credere, condannandolo in questo modo al discredito che in certi ambienti clericali ancora avvolge la Controriforma, bensì al cristianesimo delle origini. Gregorio Magno lo codificò, gregoriano perciò dovrebbe esser chiamato prima che tridentino. San Pio V, nello spirito conciliare, con immenso scrupolo, anche filologico, redasse un messale che riordinava una tradizione più che millenaria.
Invano uno stuolo di letterati, artisti, musicisti, filosofi e cineasti chiese al papa di lasciare sopravvivere, magari in qualche tempio marginale, il segno della continuità con la Chiesa del genio cattolico. L’appello era promosso da Cristina Campo e firmato da Wynstan Hugh Auden, José Bergamìn, Robert Bresson, Benjamin Britten, Jorge Luis Borges, Cristina Campo, Pablo Casals, Elena Croce, Fedele D’Amico, Luigi Dallapiccola, Giorgio De Chirico, Tammaro De Marinis, Augusto Del Noce, Salvador De Madariaga, Carl Theodor Dreyer, Francesco Gabrieli, Julien Green, Jorge Guillén, Hélène Kazantzakis, Lanza Del Vasto, Gertrud von Le Fort, Gabriel Marcel, Jacques Maritain, François Mauriac, Eugenio Montale, Victoria Ocampo, Nino Perrotta, Goffredo Petrassi, Ildebrando Pizzetti, Salvatore Quasimodo, Elsa Respighi, Augusto Roncaglia, Wally Toscanini, Philip Toynbee, Evelyn Waugh, Marìa Zambrano, Elèmire Zolla. Quando mai si adunò un numero di tanti eletti personaggi d’ogni continente per una pubblica richiesta?
Un vero paradosso intanto si produceva: veniva riconosciuto il diritto all’esistenza in seno al cattolicesimo del rito ambrosiano, greco, armeno, melkita, copto, maronita, mozarabico (in un viaggio in Spagna, Giovanni Paolo II celebrò nel canone ‘visgotico’ come pure è chiamato) e vari altri, ma per il rito latino non c’era più posto. Tollerante e benigna verso gli arcaismi di tutte le culture, la Chiesa di Roma riservava per sé la modernità assoluta. Nonostante questa ‘clandestinità’ durata alcuni decenni, il rito romano rifulge ancor oggi, classico. A cominciare dalla sua lingua, il latino. Era parlato dai popoli che formavano l’Impero, era il simbolo dell’universalismo, l’esatto contrario del radicamento romantico del linguaggio nel suolo, resta la forma salda che cede meno di altre al corso dei tempi, «corazza d’oro della Chiesa» lo chiamò qualcuno.
Nella Roma rinascimentale, tra Campo de’ Fiori e il Tevere, un eroe della Controriforma, Filippo Neri, accoglieva e ospitava i derelitti nelle case private di suoi generosi amici, poi l’opera pia si trasformò in un immenso ospizio (ospedale, albergo, luogo di conforto) che da allora, per secoli, funzionò da dormitorio e mensa per le immense folle dei giubilei seicenteschi e per i viaggiatori di mezzo mondo che quotidianamente venivano a pregare sulla tomba di Pietro. La attigua chiesa della Trinità dei Pellegrini deve il nome a questa impresa di carità cristiana (nell’ospedale, il giovane Mameli, l’autore dell’inno d’Italia, venuto a combattere il papa tra i volontari della Repubblica romana, fu assistito nella sua agonia). In questa chiesa che si presenta con una facciata tardo-barocca disegnata da Francesco De Sanctis, l’autore della scalinata di Trinità dei Monti, si celebra tutti i giorni, finalmente alla luce del sole, la messa di «rito romano antico», naturalmente in latino. È un dono di Benedetto XVI alla sua diocesi. Lo sguardo profano lo considerà come il confinamento in una ‘riserva indiana’, quello metafisico vi intravede il polmone nascosto della Chiesa.
Ieri la festa d’Ognissanti era celebrata alla Trinità con un pontificale dalla maestosità rubensiana, oggi, nel giorno consacrato alla commemorazione dei defunti, una messa solenne esorcizza i trionfi della morte. I celebranti indossano i paramenti neri, al centro della chiesa, tra sei candelieri con i ceri accesi, si eleva un catafalco sormontato da un simbolico feretro. Il catafalco ormai è sconosciuto ai più. Un tempo, invece, soltanto le bare degli aristocratici, per estremo atto di umiltà dopo una vita sfarzosa, venivano deposte sulla nuda terra. Gli altri cristiani in morte erano innalzati: il corpo umano diventato cadavere saliva su questo barocco apparato, giustappunto un palco secondo una spiegazione etimologica, rivestito di drappi liturgici neri trapuntati d’oro o d’argento, circondato dai ceri. Riconsacrato ancora una volta, a segnare davanti alla comunità che lo accompagnava nell’ultimo viaggio il fatto, incontrovertibile per i cattolici, che mentre comincia il processo di decomposizione della carne si apre anche una glorificazione della medesima carne che troverà in Cielo il suo massimo splendore alla fine dei tempi. Nei funerali post-conciliari, il violetto sostituisce il troppo luttuoso nero, quasi si dovessero smorzare le tinte del dramma, la bara è abbandonata sul pavimento, lasciata sola fisicamente mentre le chiacchiere profane dei parenti e degli amici si mescolano alle parole liturgiche del sacerdote, in un rito che somiglia talvolta a quello civile tanto il sacro si ritira, appena rischiarato dal cero pasquale, in un timido accenno all’immortalità. Non c’è comunque il memento mori che discende da quel palco, il grande spettacolo della morte cristiana che grida il dolore di essere strappati a questo mondo e promette una vita ancor più bella nell’aldilà. Per un simile rituale cattolico, per le messe da requiem in rito romano, composero i massimi musicisti dell’Occidente, da Mozart a Verdi; a quei tempi i luterani provavano la mancanza di un culto che appariva insuperabile per alleviare il dolore umano e, nel tentativo di riecheggiarne i modi, Brahms scrisse Ein deutsche Requiem, un Requiem tedesco.
I gesti, gli inchini dell’antica liturgia: ogni atto conferma una gerarchia, nel rito romano. C’è un imperatore del mondo, dice la Chiesa delle origini, con una metafora certo appartenente a quell’epoca ma compresa o comunque intuita per secoli e a ogni latitudine. È arduo del resto immaginare un Dio presidente della repubblica, una partecipazione democratica della creatura alla volontà dell’Assoluto. La collaborazione di Adamo alla creazione divina, alla creazione della lingua umana (Genesi, 2,18-20), è una bellissima premessa alla nostra storia ma non ha nulla di ‘democratico’, e se proprio un riferimento storico va cercato, si potrebbe parlare di un investimento feudale. Sarà meglio evocare la lotta di Giacobbe, il tentativo di forzare il Creatore, una battaglia d’amore, un drammatico scontro padre e figlio su scala universale, conflitto riproposto da Cristo sulla croce. Un mistico scontro insomma piuttosto di una conta di voti, piuttosto di un’assemblea che dà mandato al suo Dio. Sarà pure un valoroso compito allora, nella confusione del moderno, stabilire una traduzione di quella traditio spesso oscura ai nostri occhi – e negli ultimi due secoli, con sofferenza e ingegno nobili figure del cattolicesimo si impegnarono in tal senso – ma ci deve essere un originale ben saldo e splendente, un testo netto e sempre rintracciabile da cui tradurre, per non esporci ai pericoli di ricollocare nelle origini l’idolatria del senso comune attuale. Inoltre, l’originale deve essere riconosciuto come un testo sacro, non soltanto storico, altrimenti si finisce in una letteraria querelle degli antichi e dei moderni.
C’è un apologo sorto nell’ebraismo chassidico, riportato da numerosi narratori jiddish, che potrebbe fungere da sentenza sulla soglia dell’opera non solo letteraria di Kafka, e che rischiara la parabola discendente della religione nello stentato compromesso con il moderno più devastante: «Quando il Baal-Schem si trovava di fronte a un compito difficile, andava in un certo luogo del bosco, accendeva un fuoco e meditava pregando, e sempre fu eseguito quel che egli aveva deciso. Una generazione dopo, quando il Magghid di Meseritz si trovò di fronte al medesimo compito, andò allo stesso posto del bosco e disse: “Accendere il fuoco noi non possiamo più, ma le preghiere possiamo ancora dirle”, e quel che desiderava divenne realtà. Ancora una generazione più tardi, Rabbi Moshé Leib di Sassov, di fronte a un analogo impegno, andò anche lui nel bosco e disse: “Non siamo più in grado di accendere il fuoco e non conosciamo più le meditazioni segrete che fan parte della preghiera, ma il posto del bosco dove tutto questo avvenne lo conosciamo, e questo dovrebbe bastare”. E infatti bastò. Ma quando un’altra generazione dopo, Rabbi Israel di Richine si trovò di fronte al medesimo dovere, si sedette sulla sua poltrona dorata nel suo castello e disse: “Il fuoco non siamo più in grado di accenderlo, le preghiere non sappiamo più dire e neppure conosciamo più il posto preciso, ma possiamo tuttavia raccontare il fatto come in realtà è avvenuto”…» (versione di Shmuel Yosef Agnon). Della tradizione non resterebbe che il racconto, la letteratura come religione dei nostri giorni, il rito sostituito dalle letture e dalle omelie. Il moderno, è vero, spezza la catena delle generazioni, rovescia la superiorità sapienziale dei vecchi sui giovani, del modello sulla copia, si inorgoglisce della sua potenza che svilisce la forza del passato, che rende incerte le antiche fedi e mette perciò a rischio l’ebraismo riformato come il protestantesimo; la tradizione cattolica, la continuità apostolica, prova a resistergli proprio in virtù del possesso del messale che conserva fedelmente i sacri testi e in virtù della pratica dei sacri riti che al messale del Vetus Ordo Missae si attengono.
Cristina Campo viene in soccorso di questo «Almanacco» per quanto lo riguarda più da vicino, la questione cioè dell’arte oggi, ricollegando il problema estetico con il discorso svolto fin qui: «L’odio moderno per i riti… Il rito per eccellenza questa esperienza di morte-rigenerazione. So di parlare di qualcosa che i più non sanno che cosa sia, che qualcuno appena ricorda, che sopravvive soltanto in pochissimi luoghi sconosciuti. Sono quelli, io credo, i veri modelli, gli archetipi della poesia, che è figlia della liturgia come Dante dimostra da un capo all’altro della Commedia». Infatti, una liturgia informe e un’eclisse dell’arte vanno di pari passo. Bernard Berenson sembrava offrire un appoggio alle parole della scrittrice, pur parlando della scultura tardo-romana: nelle periodiche crisi «l’artista rimane abbandonato a se stesso, senza un modello che gli sia di mèta: intaglia e gratta, spalma e imbratta, per un vago impulso che gli urge da dentro, ma senza ben sapere che cosa vuol fare e dove vuole arrivare. A caso, uno dei meno incapaci, dotato di naturale talento per il proprio mestiere, può produrre qualcosa che appaga la sua vanità. Comunica la propria soddisfazione agli amici letterari: costoro raramente non riescono a convincere colui che esercita un’arte manuale, che i suoi prodotti, scolpiti o dipinti, sono un esempio di meditata, deliberata, metafisicamente fondata, cosmicamente inestimabile – novità» (L’Arco di Costantino o della decadenza della forma, Electa 1951).
Se non vuole finire nel disorientamento tratteggiatto da Berenson, nella parodia del «cosmicamente fondato», l’artista, l’arte, ha bisogno della liturgia e prima ancora della teologia. Andò così fin dalle origini, dalla scultura greca che dalla concezione della divinità derivava la bellezza umana: l’unica forma dignitosa per gli dèi era quella umana, e la perfezione si impadroniva allora dell’antropomorfismo divino come del teomorfismo umano. Per la pittura medioevale, rinascimentale e barocca, è ancora più evidente che nella Commedia di Dante la dipendenza dalla liturgia.
Estraneo alla cultura greca, il danese Kierkegaard si sdegnava per la ricerca di una immagine di Dio, dovendo l’Assoluto restare soltanto un mistero. Questa però è la cupa religiosità luterana, il cattolicesimo sottolinea invece l’incarnazione, la ostensione di Dio, di cui l’arte vuole essere l’eco. Iconofilia è anche credere al volto visibile del Mistero. I piccoli Kierkegaard senza tormento del nostro tempo criticheranno come idolatrica l’antica liturgia, ripeteranno l’accusa di estetismo. Certo, si dovrebbe replicare, la liturgia si svolge in forme umane, esteriori, non è un delirio né una visione interiore, può essere accompagnata dal «Kitsch linguistico, musicale, pittorico…» di cui parla Martin Mosebach nel suo L’eresia dell’informe (edito in italiano da Cantagalli di Siena) – titolo che allude alle commistioni con i veleni estetici di oggi –, oppure essere sorretta dall’arte contrappuntistica di Palestrina e discepoli che mette in musica la parola divina. E si può avere come in questa chiesa romana, quale vigoroso sussidio per la vista, la pala d’altare di Guido Reni (del soave Guido, come fu sempre chiamato dai contemporanei pure abituati ai toni sublimi) o un inguacchio di un tardo transavanguardista, commissionato o meglio subìto in quel di San Giovanni Rotondo da frati incolti che orecchiano la voga.
È dunque la bellezza cattolica a fare scandalo tra i negatori della immagine fisica di Dio. La qualità della preghiera, del rito, che non cede alla credenza diffusa secondo cui l’espressività informe sarebbe più adatta all’incontro con il divino. La domenica, nella chiesa della Trinità, si può constatare la potenza nell’universo sacro dell’arte visiva e dell’arte musicale rigorosissimamente strutturate. Il cerimoniale rigido, che prevede genuflessioni e inchini, gesti e precedenze, ha la stessa disciplina ed esattezza di un’opera d’arte, disegna una forma che si fa speculare della corte celeste. Al momento in cui il Simbolo costantinopolitano, cantato polifonicamente, professa coralmente la fede nel visibilium et invisibilium, lo sguardo corre per l’abside, alla ricerca delle cose visibili che rinviano a quelle invisibili, ai segni che qui sono pitture come la Trinità di Guido Reni, la Trinità raffigurata nelle fattezze umane. Moltissime chiese romane, potrebbero esser definite «il santuario della bellezza del corpo umano», come dice George Weigl della Sistina. Questo è il sentire cattolico.
Credo, scandisce il coro, in «unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam» davvero fatta carne, in continuità fisica con gli apostoli attraverso la catena di papi, vescovi e sacerdoti che si snoda nei secoli. La promessa divina ad Abramo si svolge nel tempo mediante la continuità di sangue, la stirpe ebraica; quella cristiana va oltre la filiazione di sangue ma ricorre ugualmente a un contatto fisico, il battesimo, la consacrazione sacerdotale degli eredi di quel drappello apostolico con l’imposizione delle mani, con l’unzione.
«Et exspecto resurrectionem mortuorum» si canta con la massima solennità. Aspettano tutti la «vitam venturi sæculi», e nella speranza la cerimonia si illumina di Paradiso. Amen.
Etichette:
Il rito romano alla Trinità dei Pellegini
domenica 25 ottobre 2009
minima / The Great Swindle
Fa freddo, un ottobre così invernale non si vedeva da tempo; sembrano un ricordo le ‘ottobrate romane’ che incantavano i viaggiatori stranieri. In una pagina celebre, Stendhal raccontava di come uscisse presto di casa per non soffrire lungo la via il caldo di mezzo ottobre e, una volta raggiunto il Gianicolo, si affacciasse per contemplare la città sotto un «sole magnifico» e sentire nel corpo un «delizioso tepore», accarezzando la felicità.
A Boston la settimana scorsa nevicava, in mezzo mondo c’è un’ondata di gelo. Per carità, niente di strano, sono capricci di stagione. Sennonché su questi capricci si è costruita una impresa ecologica di miliardi di dollari che potrebbe cambiare l’economia dell’Occidente. Ma nonostante gli immensi interessi in gioco, la stampa internazionale comincia a smentire timidamente la crociata di un Nobel in catastrofismo (quello degli svedesi è ormai un vero e proprio premio al contrario). D’altronde è duro annunciare le temperature tropicali quando si tirano fuori in anticipo i cappotti dagli armadi. L’altro giorno, sotto la sferza del freddo, «Le Monde» informava a tutta pagina e con un certo candore che il surriscaldamento progressivo della Terra «segna una pausa». Comicissimo titolo, come dire: l’Apocalisse interrompe per qualche anno i suoi lavori. Forse non mancano più novantanove mesi alla fine del mondo, così come forse non moriremo a causa della pandemia influenzale prevista per questo autunno. A lungo andare, la fede in queste simulazioni scarseggerà. Chi crederà più al «grande caldo»?E al ruolo antropico?«Post-umani», diceva il linguaggio in voga, ma poi si gonfiavano i petti, convinti di mutare il corso delle stagioni, quasi si fosse tutti dei demiurghi.
C’è aria di immiserimento in giro. Non si dice miseria, il pane non manca ma lo spettacolo dei negozi senza clienti turba il mancato acquirente, non funziona più bene il sistema del consumo. Così anche l’arricchimento progressivo del mondo sembra rimandato. Serpeggia qualche paura nei branchi dei modaioli. Anche in questo caso, la simulazione, quella estetica, perde i suoi fedeli. L’economia della cultura in tempi di vacche magre fa la figura di un norcino in un paese di vegetariani. Mondadori arriva in ritardo e pubblica il libro di un certo Donald Thompson, divulgatore di segreti economici, che si fa forte delle iperboli e spara nel titolo Uno squalo da 12 milioni di dollari. Ma ormai l’attrazione per il mondo degli affari anni Ottanta è in declino, i banchieri sono i nuovi orchi e il pubblico sempliciotto di tali traffici si allontana disgustato. Restano manuali effimeri, scritti senza vita. Uno li guarda in libreria, dà un’occhiata al risvolto e li rimette subito nello scaffale con la mano un po’ schifata.
Dei ragazzotti pieni di droga e di soldi, i Sex Pistols, fecero un film negli anni Settanta, The Great Rock’ n’ Roll Swindle. La trama, condita con l’autoironia dei piccoli cinici, era semplicissima: storia di un successo strepitoso arriso a una band che non sapeva suonare; di loro stessi, cioè, la fabula narrava. L’astuzia consisteva nel conquistare il pubblico denunciando le manipolazioni dell’industria del successo. Si sentivano furbissimi. Stupidi, quanta boria! Il rock’n’roll era un imbroglio di poco conto in confronto alla grande truffa planetaria. «Global warming», «Contemporary Art», secondo il latinorum da call center, sono ben più portentose invenzioni per muovere capitali. La prima usa il terrore come arma di ricatto fantascientifico, la seconda usa il terrore come arma per immobilizzare e deprimere. Il mondo sarà bruttissimo, pagate per salvarlo – così il messaggio ambientale; il mondo è bruttissimo, questa non-arte è il segno del «tempo della fine», pagate per goderne – così il messaggio estetico. Piccole crepe però si aprono in tali credenze coatte.
Fa freddo, un ottobre così invernale non si vedeva da tempo; sembrano un ricordo le ‘ottobrate romane’ che incantavano i viaggiatori stranieri. In una pagina celebre, Stendhal raccontava di come uscisse presto di casa per non soffrire lungo la via il caldo di mezzo ottobre e, una volta raggiunto il Gianicolo, si affacciasse per contemplare la città sotto un «sole magnifico» e sentire nel corpo un «delizioso tepore», accarezzando la felicità.
A Boston la settimana scorsa nevicava, in mezzo mondo c’è un’ondata di gelo. Per carità, niente di strano, sono capricci di stagione. Sennonché su questi capricci si è costruita una impresa ecologica di miliardi di dollari che potrebbe cambiare l’economia dell’Occidente. Ma nonostante gli immensi interessi in gioco, la stampa internazionale comincia a smentire timidamente la crociata di un Nobel in catastrofismo (quello degli svedesi è ormai un vero e proprio premio al contrario). D’altronde è duro annunciare le temperature tropicali quando si tirano fuori in anticipo i cappotti dagli armadi. L’altro giorno, sotto la sferza del freddo, «Le Monde» informava a tutta pagina e con un certo candore che il surriscaldamento progressivo della Terra «segna una pausa». Comicissimo titolo, come dire: l’Apocalisse interrompe per qualche anno i suoi lavori. Forse non mancano più novantanove mesi alla fine del mondo, così come forse non moriremo a causa della pandemia influenzale prevista per questo autunno. A lungo andare, la fede in queste simulazioni scarseggerà. Chi crederà più al «grande caldo»?E al ruolo antropico?«Post-umani», diceva il linguaggio in voga, ma poi si gonfiavano i petti, convinti di mutare il corso delle stagioni, quasi si fosse tutti dei demiurghi.
C’è aria di immiserimento in giro. Non si dice miseria, il pane non manca ma lo spettacolo dei negozi senza clienti turba il mancato acquirente, non funziona più bene il sistema del consumo. Così anche l’arricchimento progressivo del mondo sembra rimandato. Serpeggia qualche paura nei branchi dei modaioli. Anche in questo caso, la simulazione, quella estetica, perde i suoi fedeli. L’economia della cultura in tempi di vacche magre fa la figura di un norcino in un paese di vegetariani. Mondadori arriva in ritardo e pubblica il libro di un certo Donald Thompson, divulgatore di segreti economici, che si fa forte delle iperboli e spara nel titolo Uno squalo da 12 milioni di dollari. Ma ormai l’attrazione per il mondo degli affari anni Ottanta è in declino, i banchieri sono i nuovi orchi e il pubblico sempliciotto di tali traffici si allontana disgustato. Restano manuali effimeri, scritti senza vita. Uno li guarda in libreria, dà un’occhiata al risvolto e li rimette subito nello scaffale con la mano un po’ schifata.
Dei ragazzotti pieni di droga e di soldi, i Sex Pistols, fecero un film negli anni Settanta, The Great Rock’ n’ Roll Swindle. La trama, condita con l’autoironia dei piccoli cinici, era semplicissima: storia di un successo strepitoso arriso a una band che non sapeva suonare; di loro stessi, cioè, la fabula narrava. L’astuzia consisteva nel conquistare il pubblico denunciando le manipolazioni dell’industria del successo. Si sentivano furbissimi. Stupidi, quanta boria! Il rock’n’roll era un imbroglio di poco conto in confronto alla grande truffa planetaria. «Global warming», «Contemporary Art», secondo il latinorum da call center, sono ben più portentose invenzioni per muovere capitali. La prima usa il terrore come arma di ricatto fantascientifico, la seconda usa il terrore come arma per immobilizzare e deprimere. Il mondo sarà bruttissimo, pagate per salvarlo – così il messaggio ambientale; il mondo è bruttissimo, questa non-arte è il segno del «tempo della fine», pagate per goderne – così il messaggio estetico. Piccole crepe però si aprono in tali credenze coatte.
mercoledì 21 ottobre 2009
minima / Quelle finestre su un’altra vita
.
Sconfitto dal corso della storia, battuto dalle armi nemiche, il protagonista del romanzo di Roger Nimier, Les Épées (1948), raccontava di una sua evasione: «Mi sono visto di colpo nel grande museo deserto, davanti all’Angelo triste di Filippino Lippi. Il ragazzino senza età, coi capelli che gli cadono sul capo, la fronte sciupata, l’aria d’aver sprecato tutto dall’inizio, la sua grande fedeltà alla sventura, la nobiltà degli angeli vinti, tanti segni che mi hanno preso alla gola. Mi è sembrato di non poter vivere senza quelle amicizie segrete, e gli sguardi che ti aspettano dietro quelle finestre che si chiamano quadri – finestre su un’altra vita dove l’aria stessa è colorata, dove i bambini diventano di colpo angeli di Botticelli, con le narici frementi, le labbra cariche di un bacio che non scocca mai… Unico mondo carnale, mondo della nobiltà – e del dolore che non grida – mondo in cui io respiro». Per contenere il dolore che si fa fisico, che «prende alla gola», strozza le viscere, paralizza le gambe, c’è bisogno di un mondo carnale nell’arte; le astrazioni, gli estetismi essendo un prurito snervante intorno alla piaga.
.
Per sopportare il dolore dell’esistenza c’è bisogno della luce dell’altra vita intravista da quelle finestre. Altrettanto fisica. Giorni fa, su un supplemento letterario, Gianfranco Ravasi – càpita all’«Almanacco» di citarlo in due scrittarelli consecutivi – commentava la cosiddetta «Terza lettera ai Corinzi» e aggiungeva una preziosa sentenza di Verlaine che faceva poi risplendere di sostanza teologica. Ne riportiamo un passo.
.
Sconfitto dal corso della storia, battuto dalle armi nemiche, il protagonista del romanzo di Roger Nimier, Les Épées (1948), raccontava di una sua evasione: «Mi sono visto di colpo nel grande museo deserto, davanti all’Angelo triste di Filippino Lippi. Il ragazzino senza età, coi capelli che gli cadono sul capo, la fronte sciupata, l’aria d’aver sprecato tutto dall’inizio, la sua grande fedeltà alla sventura, la nobiltà degli angeli vinti, tanti segni che mi hanno preso alla gola. Mi è sembrato di non poter vivere senza quelle amicizie segrete, e gli sguardi che ti aspettano dietro quelle finestre che si chiamano quadri – finestre su un’altra vita dove l’aria stessa è colorata, dove i bambini diventano di colpo angeli di Botticelli, con le narici frementi, le labbra cariche di un bacio che non scocca mai… Unico mondo carnale, mondo della nobiltà – e del dolore che non grida – mondo in cui io respiro». Per contenere il dolore che si fa fisico, che «prende alla gola», strozza le viscere, paralizza le gambe, c’è bisogno di un mondo carnale nell’arte; le astrazioni, gli estetismi essendo un prurito snervante intorno alla piaga.
.
Per sopportare il dolore dell’esistenza c’è bisogno della luce dell’altra vita intravista da quelle finestre. Altrettanto fisica. Giorni fa, su un supplemento letterario, Gianfranco Ravasi – càpita all’«Almanacco» di citarlo in due scrittarelli consecutivi – commentava la cosiddetta «Terza lettera ai Corinzi» e aggiungeva una preziosa sentenza di Verlaine che faceva poi risplendere di sostanza teologica. Ne riportiamo un passo.
«… Sulla scia della dottrina dell’incarnazione (‘il Logos divenne sarx, carne’ secondo Giovanni 1,14), per il cristianesimo potremmo ripetere – naturalmente con le varianti interpretative del caso – la celebre proclamazione di Verlaine in Jadis et naguère (Allora e ora): La chair est sainte! Il faut qu’on la vénère. La carne è santificata dall’incarnazione di Cristo, dev’essere venerata e ha come destino non la dissoluzione ma la redenzione in una creazione nuova».
.
Due scrittori maledetti, Nimier e Verlaine, riecheggiano le promesse cattoliche.
.
Due scrittori maledetti, Nimier e Verlaine, riecheggiano le promesse cattoliche.
mercoledì 14 ottobre 2009
minima / L’arte con l’aura
.
.
«Poc’anzi, mentre attraversavo il boulevard in gran fretta, e saltellavo nella mota, in mezzo a questo mobile caos, dove la morte arriva al galoppo da tutte le parti, la mia aureola, a un movimento brusco che ho fatto, m’è scivolata giù dalla testa nel fango del selciato. Non ho avuto il coraggio di raccoglierla. Ho giudicato meno sgradevole il perdere la mia insegna che non farmi fracassare le ossa. (…) E poi penso con gioia che qualche poetastro la raccatterà e se la metterà in testa impudentemente». Così parlò Baudelaire del poeta – di se stesso – che aveva abbandonato l’aureola nella metropoli moderna. Un colpo tirato alla «religione dell’arte» e ai suoi massimi rappresentanti. La misteriosa luce diffusa dietro al volto tornava a essere una esclusiva delle creature celesti.
.
C’è sì una affinità tra santi e artisti, ma non nel senso della vulgata ricorrente, che striscia genuflessa davanti a chiunque traffichi con l’estetico e lo consacra; è l’ascesi piuttosto che accomuna chi è salito alla gloria degli altari e chi pena negli ateliers: una parola greca, àskesis, che non significa ‘rinuncia’ ma ‘esercizio’, ‘pratica’. Gianfranco Ravasi ne ricorda l’etimologia nel catalogo di una mostra romana sui santi, appena inaugurata a Palazzo Venezia.
.
Si intitola «Il Potere e la Grazia» e narra di due forze contrapposte. Avevamo accennato alla Croce che tempera la libertà sfrenata del Potere («Almanacco» del 26 novembre 2008): il simbolo della vittima diventa il limite per eccellenza alle possibilità dell’egoismo umano. Anche i santi sono un baluardo con il quale la Chiesa cerca di frenare l’autonomia del politico. Lo Stato, i Regni, i Poteri laici furono cristianizzati, battezzati, attraverso queste figure di mediatori con il Cielo e con i sudditi, i sofferenti, i bisognosi. Talvolta la Grazia restò ferita atrocemente dal Potere, e si ebbero i martiri; talaltra il Potere quasi coincise con la Grazia, e fu l’epoca dei sovrani santi.
.
Agiografia europea. Dopo il tentativo di unificazione carolingia, andata presto in frantumi, per secoli cadde l’oblio sull’idea di Europa, salvo tra i poeti e i pittori colti di mitologie che la tennero viva, preda di Zeus. Allora fu il termine ‘cristianità’ a coprire quell’immenso territorio dall’Atlantico agli Urali. «La cultura europea – si interrogava anni fa il cardinal Ratzinger – è la civiltà della tecnica e del commercio diffusa vittoriosamente per il mondo intero? O non è questa forse piuttosto nata in maniera post-europea dalla fine delle antiche culture europee?». Le antiche culture si nutrivano tutte della santità, la mostra va dunque al cuore dell’Europa, ci salva da quella comunità del burro e dell’acciaio, delle ‘quote latte’ e della ‘sessualità senza peccato’, che è una pacchianeria burocratica eretta a patria.
.
Per fare i santi c’è bisogno della grazia, del dono divino. Sull’Europa, nonostante i costumi barbari e le stragi, si diffuse copiosamente il dono della santità. Anche il talento artistico è un dono del Cielo e sul Vecchio Continente discese come la manna; a dire il vero, soprattutto sul versante occidentale, nel mondo slavo imponendosi il pregiudizio iconoclasta bizantino che lasciò un forte segno negativo nella storia dell’arte, fino a oggi.
.
Il curatore della mostra, un sacerdote, spiega con il tono omiletico del buon parroco i suoi intenti: il visitatore può vedere i martiri, gli asceti, i mistici, i santi re e le sante regine… Non a caso abbiamo scritto che questa esposizione «narra», si propone come una epopea. Insomma, vi si chiede di fissare lo sguardo sul ‘contenuto’ dei quadri, di lasciare da parte le schede tecniche. A furia di scartabellare i pedanti cataloghi delle mostre, ci si è disabituati a vedere quello che raffigura la tela o la tavola, distratti dai problemi della forma. Il buio pesto escogitato dagli allestitori, una volta tanto, potrebbe avere una giustificazione: seguiamo un racconto oscuro che si snoda nei millenni, segnato da improvvise apparizioni luminose.
.
La mostra raccoglie i santi protettori degli Stati europei, ritratti dai grandi pittori europei. Una breve storia della cultura cattolica, con testimoni prestigiosi, endorsements, quali Caravaggio, van Dyck, van Eyck, El Greco, Guercino, Holbein, Ambrogio Lorenzetti, Mantegna, Memling, Murillo, Tiepolo, Velàzquez (tra gli eccelsi, nessuno menziona negli articoli e nei comunicati Pietro da Cortona, qui con il suo strepitoso San Michele). Soltanto il cattolicesimo può mobilitare una così eletta schiera e vantare la diffusione – attraverso la propria teologia – di una cultura delle immagini che non ha confronti sulla terra.
.
Su questo stuolo di aureolati si abbatté la repressione luterana e poi calvinista, cancellazione dell’idea di santità, cancellazione dei santi dal calendario, cancellazione delle reliquie dalle chiese, cancellazioni delle immagini dei santi da ogni dove. Eppure, la storia della santità continua nonostante le censure protestanti. A cinque secoli di distanza dalla rivolta di Lutero, san Pio da Pietrelcina richiama le folle del nostro tempo. Altra questione è perché le stigmate di Francesco furono cantate dai massimi artisti, Dante e Giotto in primis, e quelle del frate del Gargano sono affidate ai pittori naïfs e al folclore.
.
Una mega-mostra sui nostri mallevadori per trasformare le fantasie degli eurocrati e nutrire quelle dei popoli avrebbe richiesto maggiore audacia, dimensioni più imponenti, contributi più corali (si sono dati da fare solo gli italiani), in modo da realizzare un evento miracoloso con la collaborazione di tutti i musei, di tutti gli specialisti, di tutti i governi anche. Ci sarebbe piaciuto seguire il santorale di Jacopo da Varagine, con centinaia di nomi che prendono forma nelle immagini dimenticate, e magari la ostensione di tutti i 1400 codici manoscritti che riecheggiarono nei secoli la Legenda Aurea, straordinario successo librario della storia antica. Con i santi chiamati a raccolta nella città santa per antonomasia, luogo della terra che rispecchia la gloria paradisiaca – questo il sogno degli artisti barocchi – con il racconto dei prodigi compiuti, delle intercessioni dall’alto e delle avventure quaggiù, delle battaglie con i diavoli, delle persecuzioni feroci, degli eroismi sublimi, dei portenti fiabeschi.
.
La luce elettronica di film agiografici, su schermi collocati davanti alle tele dei pittori, fa l’effetto di una forchetta che graffia un piatto. Se proprio si volevano inserire questi documenti, per gusto smodato dei mix o per celebrare la transmedialità, c’era spazio in sale limitrofe. Quando mai una accorta padrona di casa collocherebbe sulla stessa tavola dei bicchieri di cristallo e delle posate di plastica sia pure ben disegnate? Però, nell’insieme, una bella idea. Che si formino le file di visitatori profani, che si mettano in processione.
C’è sì una affinità tra santi e artisti, ma non nel senso della vulgata ricorrente, che striscia genuflessa davanti a chiunque traffichi con l’estetico e lo consacra; è l’ascesi piuttosto che accomuna chi è salito alla gloria degli altari e chi pena negli ateliers: una parola greca, àskesis, che non significa ‘rinuncia’ ma ‘esercizio’, ‘pratica’. Gianfranco Ravasi ne ricorda l’etimologia nel catalogo di una mostra romana sui santi, appena inaugurata a Palazzo Venezia.
.
Si intitola «Il Potere e la Grazia» e narra di due forze contrapposte. Avevamo accennato alla Croce che tempera la libertà sfrenata del Potere («Almanacco» del 26 novembre 2008): il simbolo della vittima diventa il limite per eccellenza alle possibilità dell’egoismo umano. Anche i santi sono un baluardo con il quale la Chiesa cerca di frenare l’autonomia del politico. Lo Stato, i Regni, i Poteri laici furono cristianizzati, battezzati, attraverso queste figure di mediatori con il Cielo e con i sudditi, i sofferenti, i bisognosi. Talvolta la Grazia restò ferita atrocemente dal Potere, e si ebbero i martiri; talaltra il Potere quasi coincise con la Grazia, e fu l’epoca dei sovrani santi.
.
Agiografia europea. Dopo il tentativo di unificazione carolingia, andata presto in frantumi, per secoli cadde l’oblio sull’idea di Europa, salvo tra i poeti e i pittori colti di mitologie che la tennero viva, preda di Zeus. Allora fu il termine ‘cristianità’ a coprire quell’immenso territorio dall’Atlantico agli Urali. «La cultura europea – si interrogava anni fa il cardinal Ratzinger – è la civiltà della tecnica e del commercio diffusa vittoriosamente per il mondo intero? O non è questa forse piuttosto nata in maniera post-europea dalla fine delle antiche culture europee?». Le antiche culture si nutrivano tutte della santità, la mostra va dunque al cuore dell’Europa, ci salva da quella comunità del burro e dell’acciaio, delle ‘quote latte’ e della ‘sessualità senza peccato’, che è una pacchianeria burocratica eretta a patria.
.
Per fare i santi c’è bisogno della grazia, del dono divino. Sull’Europa, nonostante i costumi barbari e le stragi, si diffuse copiosamente il dono della santità. Anche il talento artistico è un dono del Cielo e sul Vecchio Continente discese come la manna; a dire il vero, soprattutto sul versante occidentale, nel mondo slavo imponendosi il pregiudizio iconoclasta bizantino che lasciò un forte segno negativo nella storia dell’arte, fino a oggi.
.
Il curatore della mostra, un sacerdote, spiega con il tono omiletico del buon parroco i suoi intenti: il visitatore può vedere i martiri, gli asceti, i mistici, i santi re e le sante regine… Non a caso abbiamo scritto che questa esposizione «narra», si propone come una epopea. Insomma, vi si chiede di fissare lo sguardo sul ‘contenuto’ dei quadri, di lasciare da parte le schede tecniche. A furia di scartabellare i pedanti cataloghi delle mostre, ci si è disabituati a vedere quello che raffigura la tela o la tavola, distratti dai problemi della forma. Il buio pesto escogitato dagli allestitori, una volta tanto, potrebbe avere una giustificazione: seguiamo un racconto oscuro che si snoda nei millenni, segnato da improvvise apparizioni luminose.
.
La mostra raccoglie i santi protettori degli Stati europei, ritratti dai grandi pittori europei. Una breve storia della cultura cattolica, con testimoni prestigiosi, endorsements, quali Caravaggio, van Dyck, van Eyck, El Greco, Guercino, Holbein, Ambrogio Lorenzetti, Mantegna, Memling, Murillo, Tiepolo, Velàzquez (tra gli eccelsi, nessuno menziona negli articoli e nei comunicati Pietro da Cortona, qui con il suo strepitoso San Michele). Soltanto il cattolicesimo può mobilitare una così eletta schiera e vantare la diffusione – attraverso la propria teologia – di una cultura delle immagini che non ha confronti sulla terra.
.
Su questo stuolo di aureolati si abbatté la repressione luterana e poi calvinista, cancellazione dell’idea di santità, cancellazione dei santi dal calendario, cancellazione delle reliquie dalle chiese, cancellazioni delle immagini dei santi da ogni dove. Eppure, la storia della santità continua nonostante le censure protestanti. A cinque secoli di distanza dalla rivolta di Lutero, san Pio da Pietrelcina richiama le folle del nostro tempo. Altra questione è perché le stigmate di Francesco furono cantate dai massimi artisti, Dante e Giotto in primis, e quelle del frate del Gargano sono affidate ai pittori naïfs e al folclore.
.
Una mega-mostra sui nostri mallevadori per trasformare le fantasie degli eurocrati e nutrire quelle dei popoli avrebbe richiesto maggiore audacia, dimensioni più imponenti, contributi più corali (si sono dati da fare solo gli italiani), in modo da realizzare un evento miracoloso con la collaborazione di tutti i musei, di tutti gli specialisti, di tutti i governi anche. Ci sarebbe piaciuto seguire il santorale di Jacopo da Varagine, con centinaia di nomi che prendono forma nelle immagini dimenticate, e magari la ostensione di tutti i 1400 codici manoscritti che riecheggiarono nei secoli la Legenda Aurea, straordinario successo librario della storia antica. Con i santi chiamati a raccolta nella città santa per antonomasia, luogo della terra che rispecchia la gloria paradisiaca – questo il sogno degli artisti barocchi – con il racconto dei prodigi compiuti, delle intercessioni dall’alto e delle avventure quaggiù, delle battaglie con i diavoli, delle persecuzioni feroci, degli eroismi sublimi, dei portenti fiabeschi.
.
La luce elettronica di film agiografici, su schermi collocati davanti alle tele dei pittori, fa l’effetto di una forchetta che graffia un piatto. Se proprio si volevano inserire questi documenti, per gusto smodato dei mix o per celebrare la transmedialità, c’era spazio in sale limitrofe. Quando mai una accorta padrona di casa collocherebbe sulla stessa tavola dei bicchieri di cristallo e delle posate di plastica sia pure ben disegnate? Però, nell’insieme, una bella idea. Che si formino le file di visitatori profani, che si mettano in processione.
sabato 3 ottobre 2009
minima / Caravaggio ignora Bacon. E viceversa
.
Francis Bacon, prima decoratore e arredatore, folgorato poi dalla pittura di Velàzquez e di altri grandi della tradizione, pittore a sua volta, ultimo sigillo insieme a Lucien Freud della breve storia dell’arte britannica moderna inaugurata da Hogarth, ma già pencolante nella postmodernità, l’unico ancora accettato dai cultori del «contemporaneo» che ne fanno anzi un santo patrono degli «Young British Artists», Bacon – dicevamo – nelle numerose interviste concesse si lasciò andare a compilazioni di lunghe liste di artisti che lo stimolarono, magari solo in riproduzione fotografica (visto che, pur passando per Roma, mai volle entrare alla Pamphilj per osservare de visu il suo eccelso ispiratore spagnolo), ma tra i tanti citati si guardò bene dal pronunciare il nome di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio; a quei tempi del resto non era ancora un personaggio mediatico di fama mondiale, le apologie di Longhi restando magnificamente intraducibili.
.
Forse ispirata dal dialogo organizzato al Metropolitan di New York tra un quadro di Bacon e il pescecane di Hirst (l’originalità difetta sempre tra i passionisti dell’originalità), la direttrice della Galleria Borghese ha collocato nelle auree stanze dei principi e dei porporati romani i quadri del desolato inglese, accompagnandoli con dei capolavori di Caravaggio che abbondano nel museo e nelle chiese di Roma, spogliate per l’occasione mondana. Il sospetto è che quello passava il suo convento e per inventarsi una mostra, per animare il museo, ovvero per far cassa, bisognava associarlo a una star di oggi, anche se la star in questione non aveva mai mostrato il benché minimo interesse per il partner fornitogli post mortem dalla signora. Del resto vanno assai di moda le sacre conversazioni imbarazzate tra i maestri della tradizione e i caricaturisti del «contemporaneo», ma non è questo il caso, non si tratta di ludi sacrileghi, di baffetti alle gioconde di turno, bensì di una flagrante estraneità. Si voleva un accoppiamento strano e invece, perfino nei ritratti schierati sulla medesima parete, ciascuno se ne sta casto, chiuso in sé, in intransitabili frontiere.
.
Nella sala dove il berniniano Enea trascina il vecchio Anchise accendendo cerebralisssime spirali nell’aria ferma, delle grandi macchie violente di una tela di Bacon sembrano turbare l’atmosfera senza tempo, ma le statue altere guardano altrove, sprezzando simili esperimenti moderni per dire con pochi e patetici mezzi della umana angoscia. Altrettanto fa la Paulette di Canova che torce il volto insensibile alle miserie estetiche britanniche. Accanto all’iconoclasta feroce, al «boia della sua stessa immagine», Caravaggio appare un nostalgico quattrocentesco – come diceva malignamente di lui Berenson –, evocando addirittura giorgionesche composizioni. Sì, c’è l’interesse ossessivo per il corpo umano, comune ai due, ma benché emergente da «un confuso abisso di tenebre», sosteneva ancora il Lituano, la figura caravaggesca risulta «cristallina come nel Mantegna». Nonostante le dure accuse di Bellori, la sua pittura risplende della migliore tradizione, conserva erotico velo alle verità della Controriforma. Bacon visse in un’epoca dei capricci elevati a dogma, di individualismi selvaggiamente disperati; nei suoi molti discorsi che accompagnavano le opere tornava insistente l’assunto, mai dimostrato, dell’uomo come assoluta futilità. Pur amandolo, Anthony Burgess parlava a questo proposito di «agonia individuale e collettiva». Subito dopo, l’autore dell’Arancia meccanica era preso dal dubbio: «Forse non è vera arte quella che ci rinvia l’orrore dell’esistenza: molti critici sostengono che l’arte è compiuta realizzazione di una bellezza statica in forme adeguate. Invece i quadri di Bacon ci aggrediscono come manifesti di propaganda…». Il visitatore della mostra romana ne ricava pertanto una lezione sulla faglia che si è ormai aperta tra antichi e moderni. I gialli squillanti di Bacon però violentano lo sguardo, al punto che tutti i quadri stanziali della Galleria sembrano spegnersi nei loro timbri aulici, anche l’Amor sacro e Amor profano si ombra, quasi si nascondesse a occhi malati.
.
Ma dove è l’intuizione acclamata nelle chiacchiere dell’inaugurazione, dove l’affinità elettiva tra i due protagonisti? Nel Lombardo scorrono languidi giovinetti e bambinelli divini, qui mancando per lo più il getto di luce che caratterizza gli altri suoi quadri, si espongono dunque corpi incerti ma erotici, frutta e fiori, delizie del creato: questa soprattutto la carnalità di cui si parla nella mostra. In quell’altro raccogliamo crittografie del dolore, tenebre e luce a neon, crocefissi anonimi battuti da flagellazioni surrealiste: con Grünewald dovrebbero confrontarsi. A meno di non volerli far confluire in un ‘barocco’ che nei due casi è aggettivo scontato quanto inconcludente, temiamo che le magiche corrispondenze si riducano al picaresco, a fenomeni secondari cioè, a letteratura scadente; a furia di emotività sparsa dappertutto si arriva al melodramma, addirittura ai segreti o ai sospetti della sessualità degli autori: associare due pittori con il cartiglio dell’omofilia è cosa cheap. Ma oggi la vita privata sembra suscitare il massimo interesse in ogni campo, ecco il frutto avvelentato di un mezzo secolo di politicizzazione forzata, di oblio dell’intimità.
.
Proust fa morire beato il suo Bergotte al cospetto di un’opera di Vermeer; da ogni parete della Galleria romana, anche dai quadri più noiosi e mediocri, viene un accenno di consolazione, ma chi mai vorrebbe esalare l’ultimo respiro davanti agli scaltri contorcimenti del dandy inglese? La consapevolezza propagata dalle sue opere di essere in quanto umano una futilità metafisica non conforta granché. E a vederli in fila i feti di Bacon mostrano anzi una ‘maniera’ che tradisce l'immediatezza dell’‘urlo’, che rinvia alla serialità e alle assonanze che questa comporta con la produzione delle merci. Quei bitorzoli per esempio che caratterizzano tutti i volti ritratti, come segno di una malattia che si contagia, rivelano una certa affettazione fastidiosa. Maschere mostruosette che dovrebbero nascondere un’anima negata in partenza.
.
Il quartetto cosiddetto delle dissonanze di Mozart e un quartetto di Schoenberg che fa a meno della tonalità possono essere intrecciati soltanto dai filologi in cerca di un prima e un dopo nella storia. Negli esiti restano immensamente distanti, radicalmente diversi, estranei l’uno all’altro. Così delle opere di due violenti pittori.
.
Francis Bacon, prima decoratore e arredatore, folgorato poi dalla pittura di Velàzquez e di altri grandi della tradizione, pittore a sua volta, ultimo sigillo insieme a Lucien Freud della breve storia dell’arte britannica moderna inaugurata da Hogarth, ma già pencolante nella postmodernità, l’unico ancora accettato dai cultori del «contemporaneo» che ne fanno anzi un santo patrono degli «Young British Artists», Bacon – dicevamo – nelle numerose interviste concesse si lasciò andare a compilazioni di lunghe liste di artisti che lo stimolarono, magari solo in riproduzione fotografica (visto che, pur passando per Roma, mai volle entrare alla Pamphilj per osservare de visu il suo eccelso ispiratore spagnolo), ma tra i tanti citati si guardò bene dal pronunciare il nome di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio; a quei tempi del resto non era ancora un personaggio mediatico di fama mondiale, le apologie di Longhi restando magnificamente intraducibili.
.
Forse ispirata dal dialogo organizzato al Metropolitan di New York tra un quadro di Bacon e il pescecane di Hirst (l’originalità difetta sempre tra i passionisti dell’originalità), la direttrice della Galleria Borghese ha collocato nelle auree stanze dei principi e dei porporati romani i quadri del desolato inglese, accompagnandoli con dei capolavori di Caravaggio che abbondano nel museo e nelle chiese di Roma, spogliate per l’occasione mondana. Il sospetto è che quello passava il suo convento e per inventarsi una mostra, per animare il museo, ovvero per far cassa, bisognava associarlo a una star di oggi, anche se la star in questione non aveva mai mostrato il benché minimo interesse per il partner fornitogli post mortem dalla signora. Del resto vanno assai di moda le sacre conversazioni imbarazzate tra i maestri della tradizione e i caricaturisti del «contemporaneo», ma non è questo il caso, non si tratta di ludi sacrileghi, di baffetti alle gioconde di turno, bensì di una flagrante estraneità. Si voleva un accoppiamento strano e invece, perfino nei ritratti schierati sulla medesima parete, ciascuno se ne sta casto, chiuso in sé, in intransitabili frontiere.
.
Nella sala dove il berniniano Enea trascina il vecchio Anchise accendendo cerebralisssime spirali nell’aria ferma, delle grandi macchie violente di una tela di Bacon sembrano turbare l’atmosfera senza tempo, ma le statue altere guardano altrove, sprezzando simili esperimenti moderni per dire con pochi e patetici mezzi della umana angoscia. Altrettanto fa la Paulette di Canova che torce il volto insensibile alle miserie estetiche britanniche. Accanto all’iconoclasta feroce, al «boia della sua stessa immagine», Caravaggio appare un nostalgico quattrocentesco – come diceva malignamente di lui Berenson –, evocando addirittura giorgionesche composizioni. Sì, c’è l’interesse ossessivo per il corpo umano, comune ai due, ma benché emergente da «un confuso abisso di tenebre», sosteneva ancora il Lituano, la figura caravaggesca risulta «cristallina come nel Mantegna». Nonostante le dure accuse di Bellori, la sua pittura risplende della migliore tradizione, conserva erotico velo alle verità della Controriforma. Bacon visse in un’epoca dei capricci elevati a dogma, di individualismi selvaggiamente disperati; nei suoi molti discorsi che accompagnavano le opere tornava insistente l’assunto, mai dimostrato, dell’uomo come assoluta futilità. Pur amandolo, Anthony Burgess parlava a questo proposito di «agonia individuale e collettiva». Subito dopo, l’autore dell’Arancia meccanica era preso dal dubbio: «Forse non è vera arte quella che ci rinvia l’orrore dell’esistenza: molti critici sostengono che l’arte è compiuta realizzazione di una bellezza statica in forme adeguate. Invece i quadri di Bacon ci aggrediscono come manifesti di propaganda…». Il visitatore della mostra romana ne ricava pertanto una lezione sulla faglia che si è ormai aperta tra antichi e moderni. I gialli squillanti di Bacon però violentano lo sguardo, al punto che tutti i quadri stanziali della Galleria sembrano spegnersi nei loro timbri aulici, anche l’Amor sacro e Amor profano si ombra, quasi si nascondesse a occhi malati.
.
Ma dove è l’intuizione acclamata nelle chiacchiere dell’inaugurazione, dove l’affinità elettiva tra i due protagonisti? Nel Lombardo scorrono languidi giovinetti e bambinelli divini, qui mancando per lo più il getto di luce che caratterizza gli altri suoi quadri, si espongono dunque corpi incerti ma erotici, frutta e fiori, delizie del creato: questa soprattutto la carnalità di cui si parla nella mostra. In quell’altro raccogliamo crittografie del dolore, tenebre e luce a neon, crocefissi anonimi battuti da flagellazioni surrealiste: con Grünewald dovrebbero confrontarsi. A meno di non volerli far confluire in un ‘barocco’ che nei due casi è aggettivo scontato quanto inconcludente, temiamo che le magiche corrispondenze si riducano al picaresco, a fenomeni secondari cioè, a letteratura scadente; a furia di emotività sparsa dappertutto si arriva al melodramma, addirittura ai segreti o ai sospetti della sessualità degli autori: associare due pittori con il cartiglio dell’omofilia è cosa cheap. Ma oggi la vita privata sembra suscitare il massimo interesse in ogni campo, ecco il frutto avvelentato di un mezzo secolo di politicizzazione forzata, di oblio dell’intimità.
.
Proust fa morire beato il suo Bergotte al cospetto di un’opera di Vermeer; da ogni parete della Galleria romana, anche dai quadri più noiosi e mediocri, viene un accenno di consolazione, ma chi mai vorrebbe esalare l’ultimo respiro davanti agli scaltri contorcimenti del dandy inglese? La consapevolezza propagata dalle sue opere di essere in quanto umano una futilità metafisica non conforta granché. E a vederli in fila i feti di Bacon mostrano anzi una ‘maniera’ che tradisce l'immediatezza dell’‘urlo’, che rinvia alla serialità e alle assonanze che questa comporta con la produzione delle merci. Quei bitorzoli per esempio che caratterizzano tutti i volti ritratti, come segno di una malattia che si contagia, rivelano una certa affettazione fastidiosa. Maschere mostruosette che dovrebbero nascondere un’anima negata in partenza.
.
Il quartetto cosiddetto delle dissonanze di Mozart e un quartetto di Schoenberg che fa a meno della tonalità possono essere intrecciati soltanto dai filologi in cerca di un prima e un dopo nella storia. Negli esiti restano immensamente distanti, radicalmente diversi, estranei l’uno all’altro. Così delle opere di due violenti pittori.
giovedì 17 settembre 2009
In origine fu il Museo Barnum
~ IL VIAGGIO DI MARC FUMAROLI NEL MONDO DELLE IMMAGINI. ~ SEICENTO PAGINE IN FORMA DI DIARIO DOVE LO STORICO DELLA CULTURA EUROPEA SFIORA CON MAESTRIA TUTTI I TEMI TRATTATI IN QUESTO «ALMANACCO» . ~
.
Il Bello e lo Choc - Due eserghi stanno di guardia come fiammeggianti cherubini all’ultimo volume di Marc Fumaroli, uscito in Francia poco prima dell’estate: Paris-New York et retour. Voyage dans les arts et les images (Fayard). Il primo, giocoso, di Giuseppe Verdi, risuona direttamente in italiano: «Torniamo all’antico, sarà un progresso». Il secondo, una lunga citazione di Baudelaire, nume tutelare del libro, chissà quante volte capitata sotto gli occhi, è tratta dalla raccolta dedicata ai Salons, ma così isolata risulta impressionante, forse la migliore diagnosi sull’estetica occidentale dell’ultimo secolo. Ne riprendiamo l’incipit che traccia una distinzione troppo spesso dimenticata: «Il desiderio di stupire e di essere stupito è del tutto legittimo. It is a happiness to wonder, ‘è una felicità essere stupiti’; ma anche, it is a happiness to dream, ‘sognare è una felicità’. La questione è di sapere, se pretendete che vi conferisca il titolo di artista o di amante delle Belle Arti, attraverso quali procedimenti voi vogliate creare o provare lo stupore. Perché il Bello è sempre stupefacente, ma sarebbe assurdo supporre che tutto quel che è stupefacente sia sempre bello. Il nostro pubblico, che è singolarmente impotente a provare la felicità del sogno o dell’ammirazione (segno della piccolezza d’animo), vuole essere sorpreso attraverso dei mezzi estranei all’arte, e i suoi artisti, obbedienti, si conformano al suo gusto; essi vogliono colpirlo, sorprenderlo, stupefarlo con degli stratagemmi indegni, dal momento che lo sanno incapace di estasiarsi davanti alla tattica naturale dell’autentica arte. In questi deplorevoli giorni, nasce una industria nuova, che contribuisce non poco a confermare la stupidità nella sua fede e a distruggere quel che restava di divino nello spirito francese. Questa folla idolatra…» (Salon del 1859).
.
Monsieur Fumaroli va in America - La «società immonda» che si specchia nella sua «immagine triviale», il «fanatismo straordinario» dei «nuovi adoratori» delle immagini che solo un ridicolo equivoco può fare credere artistiche, l’effetto sorpresa che di per sé stabilisce l’importanza di un’opera: Baudelaire sembra parlare del nostro mondo. Annuncia che «si produrranno degli abomini», un carnevale di sghignazzamenti, di smorfie, con scrittorelli democratici pronti a commettere sacrilegio parlando con leggerezza di arte e «insultando la divina pittura». Si prepara l’evo della «Fatuità moderna», con i suoi sofismi, mentre «l’industria facendo irruzione nell’arte ne diventa la sua più mortale nemica». Il poeta anticipa anche qualche obiezione: «so bene che molti mi diranno: ‘La malattia che state spiegando è quella degli imbecilli. Quale uomo degno del nome di artista e quale autentico cultore ha mai confuso l’arte con l’industria?’. Lo so, e tuttavia chiedo a mia volta se essi credono al contagio del bene con il male, all’azione delle folle sugli individui, e all’obbedienza inconsapevole, forzata, dell’individuo alla folla». Con simili giudizi di Baudelaire nella valigia, Monsieur Fumaroli parte per l’America e vi scrive una parte del suo Diario 2007-2008, seicento pagine fitte per interrogarsi sugli idoli del «contemporaneo», dove sorprendentemente tocca con maestria pressoché tutti i temi trattati in questo «Almanacco»: dall’‘invenzione’ romana di un’arte cattolica e dalla teologia dell’incarnazione che vi è sottesa alla iconoclastia oggi dominante, passando per la religione dell’arte, la fine di un’arte profana, i laici paladini dello «spirituale nell’arte», gli spiritismi delle avanguardie, la consacrazione di ogni segno, che trova la sua apoteosi nella mostra sul sacro al Pompidou, lo scorso anno, ma anche liturgia e industria estetica, funzione dei musei, pubblicità… Una apologetica dell’arte cattolica, anzitutto, come non capitava di leggere da tempo, da quando cioè teologi e storici dell’arte pur fedeli alla religione di Roma ci hanno abituato a elemosinare briciole di spiritualismo nei balbettii estetici in voga. Ciascun titolo di un anno di «Almanacco Romano» trova almeno un paragrafo nel libro di uno dei maggiori studiosi della cultura europea. Un motivo in più per consigliarlo ai nostri rari lettori.
.
Alla fermata dell’autobus - L’affaire del «contemporaneo», dice senza mezzi termini Fumaroli, sostanzia una impresa economica colossale, ultimamente gestita anche da mafiosi cinesi e russi, il cinismo è la sua principale caratteristica, il nascondimento dietro la parola «cultura» la sua arma migliore (allora si parli piuttosto e semplicemente di marketing e entertainment, come del resto, negli ultimi tempi, cominciano a fare anche i suoi avvocati, perdendo i residui pudori). Il Diario di Fumaroli parte dalle sue attese del bus a Parigi, dove i baracchini delle fermate presentano ogni settimana immagini diverse sotto plexiglas, pubblicità aggressiva per frustrare i desideri (i giochi ironici vanno bene casomai per le gallerie), «strategia di intimidazione»: questi sono i micro musei del «contemporaneo» scoperti dal maestro del sapere retorico, i musei diffusi nel nostro quotidiano che i piccoli sociologi del fatto compiuto non avrebbero mai saputo scorgere. La catena di montaggio del divertimento forzato, del libertinaggio di massa senza senso del peccato, passa anche di qui. Basta osservare le foto fosche della réclame più high tech per capire senza tante elucubrazioni le strategie dell’industria del «contemporaneo» che ormai «giocano sul registro del sinistro, del funereo, dello scatologico, del sacro bestemmiato, come su quello della farsa e del giocattolo per adulti». Glamour che nasconde neppure più tanto la faccia dura, ancor più violenta perché ottusa, l’ideologia da crociata: affermare la propria ciarlataneria, senza che alcuno osi metterne in dubbio la legittimità, o finire affondata. Guai perciò a chi pone il bastone tra le ruote, a chi non si piega al ricatto del fato attuale.
.
Non c’è arte senza otium - Paul Valéry, che in questo libro accompagna Baudelaire nel suo ruolo di Virgilio per aiutare Marc Fumaroli ad attraversare l’Inferno, scriveva come un’eco dei commenti al Salon del 1859: «La novità, la intensità, la estraneità, in una parola tutti i valori di choc hanno soppiantato la bellezza. L’eccitazione assai brutale è la maîtresse che signoreggia le anime moderne, e le opere non hanno altro scopo attuale che strapparci dallo stato contemplativo, dalla felicità statica per cui un tempo l’immagine era intimamente legata all’idea generale di Bello». Già, lo stato contemplativo, che Fumaroli rintraccia in ogni manifestazione estetica della tradizione, legata a quell’otium coltivato in particolar modo nell’italica penisola, e che torna insistente nel suo Journal, sembra essere finito insieme all’arte nel cono d’ombra. L’urlo, il pugno in faccia, la dissonanza sono tutti mezzi per scuotere l’uomo della folla che corre, irritanti e inutili appaiono invece a chi nelle sue stanze si permette la delectatio. L’arte richiede dolce sciupio di tempo come un’amante esigente, lusso, calma, voluttà insegue ancora Matisse.
.
Chi ha inventato il museo «contemporaneo»? - Per capire meglio questa faccenda dello choc Fumaroli vola a New York, tiene i suoi corsi alla Columbia, chiude provvisoriamente le pagine di Baudelaire, cerca ausilio nei libri di Edgard Allan Poe, gira per le strade della metropoli, si lascia andare allo spleen d’oltreoceano, osserva musei e gallerie, fa affiorare come in un contrappunto le immagini dell’arte di vari secoli della storia europea, dall’epoca pompeiana a quella del secolo XVII che ha così splendidamente ricostruito. E finalmente trova un nome che in pochi conoscono nella storia dell’estetica, si tratta dell’inventore del museo «contemporaneo» e della sua «arte»: Phineas Taylor Barnum, il padrone del circo famoso. Ma fama maggiore dovrebbe possedere per il suo American Museum, che istituì nel 1842, a trentadue anni. Ricordano le enciclopedie: «Barnum è entrato nella storia soprattutto per la capacità di attrarre spettatori… grazie ad un’intensa pubblicità murale e giornalistica, diffondendo però un buon numero di notizie fasulle. La sua carriera fu costellata da polemiche e processi, che suscitarono ancora più interesse… che raggiunsero l’apice quando Barnum denunciò se stesso come mistificatore…». Basterebbero tali parole per far sospettare che si stia parlando dell’arte della mistificazione contemporanea e della associata arte di far soldi. Giustamente sospettoso, Fumaroli è andato a vedere gli oggetti esposti in quel museo che richiamò, in venticinque anni, ben trentotto milioni di visitatori, fino all’incendio del 1865 che lo distrusse per sempre (altro che le fiere nostrane ancora iniziatiche). Si potrebbe dire dunque che l’affollatissimo American Museum rappresentava una traduzione democratica della Wunderkammer, però mancavano le meraviglie, c’erano soltanto le curiosità. Per gli americani, le immagini artistiche sapevano troppo di Chiesa cattolica, di monarchia, di aristocratiche dimore, di Europa insomma. Invece di quadri e statue allora, Barnum espose il «mai visto», così chiamava questi incunaboli delle installazioni. Oggetti anfibi, persone umane mostrate come attrazioni, un uomo pelosissimo, anello di congiunzione tra l’animalità e l’umanità, diceva la scritta, una sirena mezza scimmia e mezzo pesce, orsi ballerini, fratelli siamesi, diorami e cosmorami, strumenti scientifici, un circo di mosche, invenzioni varie, un’orchestra dei peggiori musicisti degli States affinché con la loro cacofonia attirassero le folle incuriosite alla cassa. Un museo del bluff, un po’ Disneyland, un po’ circo, molto imbroglio. Più tardi, Duchamp approdato in quella terra di avventurieri, dichiarerà alla televisione americana, per il piacere dello scandalo: «Sì, l’arte moderna è un imbroglio, il valore estetico si trasforma in valore monetario».
.
Barnum e Schopenhauer - Barnum inventò un sistema industriale di «showroom del nulla», della sorpresa in sé. Assoldava comitati di esperti che si pronunciavano a favore o contro le sue imprese e faceva circolare tali pronunciamenti, provocando in tal modo dibattiti, sapeva che era proprio il gran parlare ad accrescere l’audience, a produrre l’evento. Il genio del marketing andava dicendo quel che ripetono gli autori d’ogni truffa mediatica colti sul fatto, e cioè che «la gente ama essere imbrogliata», «ama le ciarlatanerie». «Barnumizzazione» significò l’arte di far credere qualunque cosa a ogni pubblico. Quel che è finito nella storia della psicologia con il nome di Effetto Barnum. Ogni individuo – recita il principio che sarà poi messo a punto da Bertram Forer nel Novecento – posto di fronte a un profilo psicologico che crede a lui riferito, tende a immedesimarsi in esso ritenendolo preciso, senza accorgersi che quel profilo è invece abbastanza vago e generico da adattarsi a un numero molto ampio di persone. L’effetto Barnum/Forer fornirebbe così una parziale spiegazione della grande diffusione di alcune pseudoscienze come l’astrologia e di molti test di personalità; ma il meccanismo messo a punto da Barnum può rivelarsi una ottima spiegazione dei progressi del «contemporaneo» tra i suoi compratori come tra i visitatori delle Biennali. Nel regno della soggettività selvaggia, che si presenta come tale, ogni oggetto è in realtà predisposto perché si adatti al maggior numero di persone. Tornano in mente le osservazioni di Baudelaire citate all’inizio, «la società immonda» che si specchia nelle sue «immagini triviali». Più o meno in quel tempo Arthur Schopenhauer scriveva con forse maggior cinismo dei propagandisti americani, che in fondo esibiscono spesso un certo qual grado di idealismo: «Non c’è alcuna opinione, per quanto assurda, che gli uomini non abbiano esitato a far propria, non appena si è arrivati a convincerli che è universalmente accettata». Nel Diario di Fumaroli torna spesso la parola ‘cinismo’ e il suo autore, benché avvezzo alla crudezza rinascimentale, sembra assai colpito dalla brutalizzazione dell’arte, ricorda con sgomento chi si ostina a dipingere nella nostra epoca ed è per questo cancellato dalla storia dai bodyguard del «contemporaneo», dai discendenti di Barnum. Post-umani, si dice ormai in quegli ambienti, non si capisce bene se perché adepti della dottrina di Foucault o piuttosto eredi teorici degli stermini maoisti.
.
Se l’Europa diventa l’America -In fondo, la cultura americana religiosa si nutre di poche immagini e di molto melodramma, di musica emotiva, di danze collettive, di prediche profetiche, di numeri da record, di sentimenti apocalittici. Da quel folclore pescò il signor Barnum. L’arte delle «immagini sante» era bandita dalle chiese protestanti e sempre più sostituita dallo show, dalle personalità carismatiche, dalla réclame cui si ricorreva anche per catturare fedeli. Tali inclinazioni religiose finiranno a modo loro nell’American Museum. Gli spettatori di Barnum come delle immagini pop sono anzitutto americani che ritrovano le loro radici antropologiche. L’aspetto balordo comincia quando in Europa si interrompe la tradizione delle belle arti per coltivare le eccentricità del baraccone. Una violenza che cambia i connotati del nostro mondo. Le cose senza prezzo non esistono più. Ora tutto ha un prezzo preciso nell’emporio popular.
.
Rovesciamenti da Saturnali – Solo un provinciale dai gusti esterofili può farsi sostenitore in Europa di quella Contemporary Art inventata in America. «Siete una caricatura, siete ridicoli» dice un interlocutore statunitense di Fumaroli. «Anche se affermiamo il contrario, noi americani sappiamo benissimo la differenza che separa l’highbrow dal lowbrow». La cultura pop, il «contemporary» sono lowbrow, quella europea, la sua arte sono highbrow. «Voi europei vi rovinate imitandoci in quel che abbiamo di grossolano, mentre lasciate deperire quel che ha sempre fatto la vostra superiorità: la raffinatezza». Conclude l’autore: sarebbe impossibile un concerto di Madonna al Metropolitan Opera di New York, perché allora una esposizione di Jeff Koons a Versailles?
Eccesso di zelo europeo - «La valorizzazione del nulla attraverso la chiacchiera» della stampa e dei cataloghi è una industria americana, in Europa dovrebbe sembrare fuori posto, apparire come minimo assai risibile. Dove manca la bellezza, nel deserto americano, «pullulano i concetti e la morale», ma perché importare simili merci in un territorio che passa dai monti alle pianure e dalle pianure al mare a ogni svolta della strada, sempre aprendosi su nuove bellezze?
Duchamp, un equivoco - Secondo il nostro diarista, quando Marcel Duchamp andò a svernare negli Usa si produsse un equivoco. Il suo ozio libertino venne frainteso, in terra americana il taylorismo del sesso restava dentro lo schema dell’ideologia puritana (adesso anche da noi, giornali che quotidianamente riducono la sessualità a consumo coatto si fanno paladini di crociate puritane). Ma sicuramente l’America intuì che dietro i gesti da dandy del francese c’era un enorme potenziale economico. La Borsa aprì un settore che ricalcava quello dello show business, almeno all’inizio dunque una branca dell’industria del divertimento, poi sempre più dai risvolti sinistri. Forse, è il limite di questo Diario, Fumaroli esagera nel considerare tutta la storia moderna come una faccenda francese o di francesi, certo è che le pose distratte di Duchamp cambiarono le sorti dell’avanguardismo internazionale. Man mano, alla ingenua credenza in un Rinascimento americano da parte degli espressionisti astratti, subentrò l’indifferenza efferata del pop. Nasceva lì, complice o meno la noia di Duchamp, il «contemporaneo» senza storia.
La buona sorpresa - Il macabro da Barnum – la morte senza il velo dell’allegoria e della litote, la morgue priva di eros, la «tautologia cadaverica» – è, insieme al cinismo, quello che sembra maggiormente colpire l’autore di questo Diario. Il saggista marsigliese si trova molto a disagio dentro una feroce macelleria. Di nuovo Valéry viene in soccorso, Fumaroli ha scoperto un’altra sua glossa indiretta al discorso di Baudelaire sullo choc: «Non dimentichiamo che una cosa molto bella ci rende muti d’ammirazione. […] Ma questo non va confuso con il mutismo dello stupore, la grande ossessione di molti moderni. Esso non distingue i generi di sorpresa. Uno soltanto si rinnova a ogni sguardo e diventa tanto più indefinibile e sensibile quanto più profondamente si esamina l’opera e ci si familiarizza. Si tratta della buona sorpresa. L’altro invece è semplicemente lo choc, capace di rompere una convenzione o un’abitudine, riducendosi appunto a un urto». Chi scrive al soldo del bluff estetico altro non fa che segnalare quel vile choc, la rottura di una convenzione o di un’abitudine anche visiva. Penoso compito.
.
Religione del libro o dell’immagine? - Avevamo scritto il 29 giugno scorso che d’ora in poi avremmo evitato in questo «Almanacco» di occuparci a lungo della fenomenologia del «contemporaneo», onde non lasciarsi mesmerizzare da simili pratiche. Ma Fumaroli partendo dal Barnum delle installazioni ci riconduce alla storia delle immagini e alla cultura cattolica dell’incarnazione che ne produsse le più divine. Al punto che ci si chiede se si possa parlare del cattolicesimo come religione del libro alla pari di fedi ‘auditive’ come l’ebraismo e l’islamismo. A Roma, l’astrattezza del monoteismo ‘platonico’ si fa concreto nell’immagine del Figlio incarnato. Non si abbia paura a dire che l’arte di derivazione cattolica discende direttamente dall’Eucarestia, dall’ostia che racchiude e nasconde corpo e sangue (non a caso la liturgia modernista vuole privilegiare la ‘parola’ nei confronti del mistero eucaristico). Anche il culto delle reliquie – i resti del corpo umano venerati dai cattolici e che provocano imbarazzo nelle altre fedi – discende dalla medesima fede nell’ostia. Nel mistero eucaristico, il divino è «ascoso nei mistici veli», nell’arte le velature trattengono il creato, il mondo redento. Il cristianesimo romano afferma che Dio ha lasciato l’empireo dei cieli ed è sceso in mezzo al vulgus delle parentele di sangue, dell’etnia ebraica, dei corpi umani troppo umani, delle donne e dei bambini che lo hanno frequentato, della giustizia umana che lo ha condannato, del gruppo di discepoli poveri di spirito. Le sue fattezze avranno suscitato già nei contemporanei l’aguzzamento del senso della vista: le folle si accalcavano per vederlo. Ma in tutto ciò i nostri parroci più candidi intravedono una pericolosa idolatria. Il professor Fumaroli invece ci ricorda che gustus è parola del latino tardo, del vocabolario cristiano, per indicare il desiderio di conoscere attraverso i sensi il Salvatore. Ed ora, quattro eretici che trafficano da oltre un secolo con le teorie spiritistiche ci vogliono convincere di un’arte puramente spirituale, o meglio del lugubre «spirituale nell’arte».
.
L’arte della incarnazione - «Il Logos vivente di Platone – scrive Fumaroli – si è lasciato vedere e toccare, amare e odiare sotto dei tratti umani. Ci vollero tredici secoli perché questo ossimoro vivente narrato dagli evangelisti, ravvivato dal culto paradossale delle reliquie e delle icone, rievocato dalle visioni, le estasi e le rivelazioni dei santi mistici, rivissuto dal ‘quinto Vangelo’ di Francesco di Assisi, cominciasse a trovare, nella contrarietà dei colti, la sua traduzione visiva nell’arte occidentale». Ecco l’arte della incarnazione, dove non è più disdicevole esaltare l’aspetto fisico dell’umano perché quel corpo è divenuto lo strumento della salvezza cosmica. Gli storici dell’arte ottocenteschi, imbevuti di cultura protestante, riproposero lo scandalo provato a Roma da Lutero e presero a parlare di « ritorno al paganesimo» per la riappropriazione italiana, tra il XII e il XV secolo, della statuaria antica e della «rappresentazione eroica della forma umana». Si trattava davvero di un ritorno alla fede negli dèi? Assolutamente no, piuttosto la mitologia pagana era un linguaggio simbolico, ben spendibile dentro il quadro cristiano, se ne usavano le immagini, cioè le metafore, la grammatica, ecc., per narrare la redenzione del mondo e della carne. Così come per rappresentare la passione di Cristo, gli artisti si interrogarono sul corpo e sui misteri del dolore, andarono a scuola dai chirurghi, sfogliarono attenti i volumi di anatomia, studiarono l’ottica, fissarono nello spazio le ‘finzioni’ prospettiche: volevano «mostrare, in tutta la sua bellezza eroica, il corpo di Cristo vincitore» della morte. Finché alle soglie del moderno, questo «ammirabile compromesso tra scienza ottica e visione simbolica» fu progressivamente condannato, quasi fossero i pittori umanisti i precursori della fotografia. Si ebbe lo strano caso di congreghe di laici che censuravano ogni attacco allo «spirituale nell’arte» e provavano orrore, disgusto morale, per ogni riferimento della pittura alla concretezza del corpo. Oggi sono i cultori dei video arte, o di quel pompierismo attuale che va sotto il nome di iperrealismo, a mostrare maggiore imbarazzo per l’arte ‘fisica’ della tradizione, a proclamarsi iconoclasti pur celebrando la riproduzione fotografica.
.
L’eterno ritorno della bellezza - Finalmente qui Fumaroli, con la grande erudizione che possiede nel campo della retorica antica, può liberarci dalle banalità sul Rinascimento molto pagano e poco cristiano. Ora è proprio con l’avvento dell’umanesimo che Roma, autonoma ormai dalle imposizioni bizantine come da quelle romano-imperiali, può mettere a punto la sua arte: il mondo ne sarà sbalordito.
.
Lo splendore del vero visibile - Il direttore dei musei pontifici sembrava riprendere queste riflessioni scrivendo qualche giorno fa sul giornale ufficiale della Santa Sede: «Chi, come me, dall’osservatorio privilegiato dei Musei Vaticani considera la storia delle arti sotto il segno della Chiesa di Roma non può non provare sentimenti di stupore e di gratitudine. Gratitudine, naturalmente, per i capolavori di bellezza e di sapienza che il messaggio cristiano ci ha regalato ma anche, e soprattutto, stupore e ammirazione di fronte ai meravigliosi azzardi che, nei secoli, la nostra Chiesa ha saputo giocare. Come quando, per esempio, fra quarto e quinto secolo, ha scelto come sua lingua figurativa l’arte greco-romana, l’ellenismo naturalistico e illusionistico. Azzardo immenso e carico di futuro è stato quello se si pensa che il cristianesimo veniva dall’ebraismo, la più ferocemente aniconica fra le culture del Mediterraneo e che senza quella scelta, il destino dell’arte in Occidente – Michelangelo e Rembrandt, Velasquez e Goya, Monet e Picasso – rischiava di identificarsi con la cifra e col segno, di diventare ‘ieroscrittura’, come nell’islam. Oppure quando – è l’epoca che i manuali chiamano del rinascimento – la Chiesa riconobbe nello splendore del vero visibile, l’epifania dell’Altissimo, l’ombra di Dio sulla terra. Non avremmo avuto, altrimenti, le nuvole di Giovanni Bellini, i riflessi nello specchio di Jan Van Eyck, la Stanza della Segnatura di Raffaello, la Canestra di frutta di Caravaggio, la Zattera di Medusa di Géricault».
.
La vista, il senso più cattolico - Walter Benjamin cercò di rendere visibile l’«esperienza accecante» di chi era costretto a vivere nell’«epoca della grande industria». Aveva capito che proprio la vista era la prima ad essere colpita dalla cultura industrializzata. Baudelaire, ancora una volta lui, aveva così tanta familiarità con la cultura cattolica delle immagini da esibire una intransigenza rigorosa verso le raffigurazioni deboli, compromesse con i luoghi comuni del presente. Fumaroli arriva a paragonare l’attenzione per le immagini delle gerarchie cattoliche della Controriforma, dei cardinali Borromeo e Paleotti, con l’inflessibile attività critica dei Baudelaire e degli Huysmans nell’Ottocento, quando i porporati non si prendevano più cura delle opere pittoriche. «Questo cattolico ama troppo l’arte di incarnare l’infinito nel finito per non mostrarsi impietoso nei confronti delle copie servili […]. Il ‘culto’ che pratica per le opere d’arte visuale non si rivolge a qualsiasi immagine. Egli ha uno sguardo d’aquila per distinguere quelle che blandiscono la vista per fare schermo all’anima da quelle che appagano la vista quanto più parlano all’anima. […] La sua iconofilia, come in Chateaubriand, è quella di un cattolico laico per il quale la grande arte è la sola reliquia degna e autentica, insieme alla grande poesia, che abbia lasciato dietro di sé la Chiesa che si allontana». A questo punto Fumaroli avrebbe potuto aggiungere una considerazione di Hofmannsthal che attribuiva alla Chiesa romana l’ultimo e concreto legame con il mondo classico. L’arte e la poesia, secondo il poeta francese, sarebbero le eredi della liturgia e dei grandi inni ecclesiastici. «La poetica e la critica d’arte di Baudelaire non derivano in nulla dall’estetismo e tutto dalla teologia».
I tre moschettieri - Tre moschettieri francesi combattono con scienza, bonomia e buonsenso contro i segni allucinati del «contemporaneo» e la loro comicità nera e involontaria: Alain Besançon, Jean Clair, Marc Fumaroli (schierandoli in ordine alfabetico). Tutti e tre sottolineano la radicale differenza con l’arte della tradizione cui si accostano richiamandosi con grande cognizione di causa alla cultura cattolica, anzi a quella che un tempo si sarebbe chiamata la civiltà cattolica, che almeno da un certo punto in poi coincise con la civiltà delle immagini. Besançon e Fumaroli ne hanno tentato anche una spiegazione teologica. In una pagina di questo Diario appena uscito ci si rifà addirittura all’insegnamento del prof. Ratzinger. Inimmaginabile una cosa del genere negli scritti dei nostri accademici. Loro sono ancora convinti che sia più chic magnificare lo choc.
.
Monsieur Fumaroli va in America - La «società immonda» che si specchia nella sua «immagine triviale», il «fanatismo straordinario» dei «nuovi adoratori» delle immagini che solo un ridicolo equivoco può fare credere artistiche, l’effetto sorpresa che di per sé stabilisce l’importanza di un’opera: Baudelaire sembra parlare del nostro mondo. Annuncia che «si produrranno degli abomini», un carnevale di sghignazzamenti, di smorfie, con scrittorelli democratici pronti a commettere sacrilegio parlando con leggerezza di arte e «insultando la divina pittura». Si prepara l’evo della «Fatuità moderna», con i suoi sofismi, mentre «l’industria facendo irruzione nell’arte ne diventa la sua più mortale nemica». Il poeta anticipa anche qualche obiezione: «so bene che molti mi diranno: ‘La malattia che state spiegando è quella degli imbecilli. Quale uomo degno del nome di artista e quale autentico cultore ha mai confuso l’arte con l’industria?’. Lo so, e tuttavia chiedo a mia volta se essi credono al contagio del bene con il male, all’azione delle folle sugli individui, e all’obbedienza inconsapevole, forzata, dell’individuo alla folla». Con simili giudizi di Baudelaire nella valigia, Monsieur Fumaroli parte per l’America e vi scrive una parte del suo Diario 2007-2008, seicento pagine fitte per interrogarsi sugli idoli del «contemporaneo», dove sorprendentemente tocca con maestria pressoché tutti i temi trattati in questo «Almanacco»: dall’‘invenzione’ romana di un’arte cattolica e dalla teologia dell’incarnazione che vi è sottesa alla iconoclastia oggi dominante, passando per la religione dell’arte, la fine di un’arte profana, i laici paladini dello «spirituale nell’arte», gli spiritismi delle avanguardie, la consacrazione di ogni segno, che trova la sua apoteosi nella mostra sul sacro al Pompidou, lo scorso anno, ma anche liturgia e industria estetica, funzione dei musei, pubblicità… Una apologetica dell’arte cattolica, anzitutto, come non capitava di leggere da tempo, da quando cioè teologi e storici dell’arte pur fedeli alla religione di Roma ci hanno abituato a elemosinare briciole di spiritualismo nei balbettii estetici in voga. Ciascun titolo di un anno di «Almanacco Romano» trova almeno un paragrafo nel libro di uno dei maggiori studiosi della cultura europea. Un motivo in più per consigliarlo ai nostri rari lettori.
.
Alla fermata dell’autobus - L’affaire del «contemporaneo», dice senza mezzi termini Fumaroli, sostanzia una impresa economica colossale, ultimamente gestita anche da mafiosi cinesi e russi, il cinismo è la sua principale caratteristica, il nascondimento dietro la parola «cultura» la sua arma migliore (allora si parli piuttosto e semplicemente di marketing e entertainment, come del resto, negli ultimi tempi, cominciano a fare anche i suoi avvocati, perdendo i residui pudori). Il Diario di Fumaroli parte dalle sue attese del bus a Parigi, dove i baracchini delle fermate presentano ogni settimana immagini diverse sotto plexiglas, pubblicità aggressiva per frustrare i desideri (i giochi ironici vanno bene casomai per le gallerie), «strategia di intimidazione»: questi sono i micro musei del «contemporaneo» scoperti dal maestro del sapere retorico, i musei diffusi nel nostro quotidiano che i piccoli sociologi del fatto compiuto non avrebbero mai saputo scorgere. La catena di montaggio del divertimento forzato, del libertinaggio di massa senza senso del peccato, passa anche di qui. Basta osservare le foto fosche della réclame più high tech per capire senza tante elucubrazioni le strategie dell’industria del «contemporaneo» che ormai «giocano sul registro del sinistro, del funereo, dello scatologico, del sacro bestemmiato, come su quello della farsa e del giocattolo per adulti». Glamour che nasconde neppure più tanto la faccia dura, ancor più violenta perché ottusa, l’ideologia da crociata: affermare la propria ciarlataneria, senza che alcuno osi metterne in dubbio la legittimità, o finire affondata. Guai perciò a chi pone il bastone tra le ruote, a chi non si piega al ricatto del fato attuale.
.
Non c’è arte senza otium - Paul Valéry, che in questo libro accompagna Baudelaire nel suo ruolo di Virgilio per aiutare Marc Fumaroli ad attraversare l’Inferno, scriveva come un’eco dei commenti al Salon del 1859: «La novità, la intensità, la estraneità, in una parola tutti i valori di choc hanno soppiantato la bellezza. L’eccitazione assai brutale è la maîtresse che signoreggia le anime moderne, e le opere non hanno altro scopo attuale che strapparci dallo stato contemplativo, dalla felicità statica per cui un tempo l’immagine era intimamente legata all’idea generale di Bello». Già, lo stato contemplativo, che Fumaroli rintraccia in ogni manifestazione estetica della tradizione, legata a quell’otium coltivato in particolar modo nell’italica penisola, e che torna insistente nel suo Journal, sembra essere finito insieme all’arte nel cono d’ombra. L’urlo, il pugno in faccia, la dissonanza sono tutti mezzi per scuotere l’uomo della folla che corre, irritanti e inutili appaiono invece a chi nelle sue stanze si permette la delectatio. L’arte richiede dolce sciupio di tempo come un’amante esigente, lusso, calma, voluttà insegue ancora Matisse.
.
Chi ha inventato il museo «contemporaneo»? - Per capire meglio questa faccenda dello choc Fumaroli vola a New York, tiene i suoi corsi alla Columbia, chiude provvisoriamente le pagine di Baudelaire, cerca ausilio nei libri di Edgard Allan Poe, gira per le strade della metropoli, si lascia andare allo spleen d’oltreoceano, osserva musei e gallerie, fa affiorare come in un contrappunto le immagini dell’arte di vari secoli della storia europea, dall’epoca pompeiana a quella del secolo XVII che ha così splendidamente ricostruito. E finalmente trova un nome che in pochi conoscono nella storia dell’estetica, si tratta dell’inventore del museo «contemporaneo» e della sua «arte»: Phineas Taylor Barnum, il padrone del circo famoso. Ma fama maggiore dovrebbe possedere per il suo American Museum, che istituì nel 1842, a trentadue anni. Ricordano le enciclopedie: «Barnum è entrato nella storia soprattutto per la capacità di attrarre spettatori… grazie ad un’intensa pubblicità murale e giornalistica, diffondendo però un buon numero di notizie fasulle. La sua carriera fu costellata da polemiche e processi, che suscitarono ancora più interesse… che raggiunsero l’apice quando Barnum denunciò se stesso come mistificatore…». Basterebbero tali parole per far sospettare che si stia parlando dell’arte della mistificazione contemporanea e della associata arte di far soldi. Giustamente sospettoso, Fumaroli è andato a vedere gli oggetti esposti in quel museo che richiamò, in venticinque anni, ben trentotto milioni di visitatori, fino all’incendio del 1865 che lo distrusse per sempre (altro che le fiere nostrane ancora iniziatiche). Si potrebbe dire dunque che l’affollatissimo American Museum rappresentava una traduzione democratica della Wunderkammer, però mancavano le meraviglie, c’erano soltanto le curiosità. Per gli americani, le immagini artistiche sapevano troppo di Chiesa cattolica, di monarchia, di aristocratiche dimore, di Europa insomma. Invece di quadri e statue allora, Barnum espose il «mai visto», così chiamava questi incunaboli delle installazioni. Oggetti anfibi, persone umane mostrate come attrazioni, un uomo pelosissimo, anello di congiunzione tra l’animalità e l’umanità, diceva la scritta, una sirena mezza scimmia e mezzo pesce, orsi ballerini, fratelli siamesi, diorami e cosmorami, strumenti scientifici, un circo di mosche, invenzioni varie, un’orchestra dei peggiori musicisti degli States affinché con la loro cacofonia attirassero le folle incuriosite alla cassa. Un museo del bluff, un po’ Disneyland, un po’ circo, molto imbroglio. Più tardi, Duchamp approdato in quella terra di avventurieri, dichiarerà alla televisione americana, per il piacere dello scandalo: «Sì, l’arte moderna è un imbroglio, il valore estetico si trasforma in valore monetario».
.
Barnum e Schopenhauer - Barnum inventò un sistema industriale di «showroom del nulla», della sorpresa in sé. Assoldava comitati di esperti che si pronunciavano a favore o contro le sue imprese e faceva circolare tali pronunciamenti, provocando in tal modo dibattiti, sapeva che era proprio il gran parlare ad accrescere l’audience, a produrre l’evento. Il genio del marketing andava dicendo quel che ripetono gli autori d’ogni truffa mediatica colti sul fatto, e cioè che «la gente ama essere imbrogliata», «ama le ciarlatanerie». «Barnumizzazione» significò l’arte di far credere qualunque cosa a ogni pubblico. Quel che è finito nella storia della psicologia con il nome di Effetto Barnum. Ogni individuo – recita il principio che sarà poi messo a punto da Bertram Forer nel Novecento – posto di fronte a un profilo psicologico che crede a lui riferito, tende a immedesimarsi in esso ritenendolo preciso, senza accorgersi che quel profilo è invece abbastanza vago e generico da adattarsi a un numero molto ampio di persone. L’effetto Barnum/Forer fornirebbe così una parziale spiegazione della grande diffusione di alcune pseudoscienze come l’astrologia e di molti test di personalità; ma il meccanismo messo a punto da Barnum può rivelarsi una ottima spiegazione dei progressi del «contemporaneo» tra i suoi compratori come tra i visitatori delle Biennali. Nel regno della soggettività selvaggia, che si presenta come tale, ogni oggetto è in realtà predisposto perché si adatti al maggior numero di persone. Tornano in mente le osservazioni di Baudelaire citate all’inizio, «la società immonda» che si specchia nelle sue «immagini triviali». Più o meno in quel tempo Arthur Schopenhauer scriveva con forse maggior cinismo dei propagandisti americani, che in fondo esibiscono spesso un certo qual grado di idealismo: «Non c’è alcuna opinione, per quanto assurda, che gli uomini non abbiano esitato a far propria, non appena si è arrivati a convincerli che è universalmente accettata». Nel Diario di Fumaroli torna spesso la parola ‘cinismo’ e il suo autore, benché avvezzo alla crudezza rinascimentale, sembra assai colpito dalla brutalizzazione dell’arte, ricorda con sgomento chi si ostina a dipingere nella nostra epoca ed è per questo cancellato dalla storia dai bodyguard del «contemporaneo», dai discendenti di Barnum. Post-umani, si dice ormai in quegli ambienti, non si capisce bene se perché adepti della dottrina di Foucault o piuttosto eredi teorici degli stermini maoisti.
.
Se l’Europa diventa l’America -In fondo, la cultura americana religiosa si nutre di poche immagini e di molto melodramma, di musica emotiva, di danze collettive, di prediche profetiche, di numeri da record, di sentimenti apocalittici. Da quel folclore pescò il signor Barnum. L’arte delle «immagini sante» era bandita dalle chiese protestanti e sempre più sostituita dallo show, dalle personalità carismatiche, dalla réclame cui si ricorreva anche per catturare fedeli. Tali inclinazioni religiose finiranno a modo loro nell’American Museum. Gli spettatori di Barnum come delle immagini pop sono anzitutto americani che ritrovano le loro radici antropologiche. L’aspetto balordo comincia quando in Europa si interrompe la tradizione delle belle arti per coltivare le eccentricità del baraccone. Una violenza che cambia i connotati del nostro mondo. Le cose senza prezzo non esistono più. Ora tutto ha un prezzo preciso nell’emporio popular.
.
Rovesciamenti da Saturnali – Solo un provinciale dai gusti esterofili può farsi sostenitore in Europa di quella Contemporary Art inventata in America. «Siete una caricatura, siete ridicoli» dice un interlocutore statunitense di Fumaroli. «Anche se affermiamo il contrario, noi americani sappiamo benissimo la differenza che separa l’highbrow dal lowbrow». La cultura pop, il «contemporary» sono lowbrow, quella europea, la sua arte sono highbrow. «Voi europei vi rovinate imitandoci in quel che abbiamo di grossolano, mentre lasciate deperire quel che ha sempre fatto la vostra superiorità: la raffinatezza». Conclude l’autore: sarebbe impossibile un concerto di Madonna al Metropolitan Opera di New York, perché allora una esposizione di Jeff Koons a Versailles?
Eccesso di zelo europeo - «La valorizzazione del nulla attraverso la chiacchiera» della stampa e dei cataloghi è una industria americana, in Europa dovrebbe sembrare fuori posto, apparire come minimo assai risibile. Dove manca la bellezza, nel deserto americano, «pullulano i concetti e la morale», ma perché importare simili merci in un territorio che passa dai monti alle pianure e dalle pianure al mare a ogni svolta della strada, sempre aprendosi su nuove bellezze?
Duchamp, un equivoco - Secondo il nostro diarista, quando Marcel Duchamp andò a svernare negli Usa si produsse un equivoco. Il suo ozio libertino venne frainteso, in terra americana il taylorismo del sesso restava dentro lo schema dell’ideologia puritana (adesso anche da noi, giornali che quotidianamente riducono la sessualità a consumo coatto si fanno paladini di crociate puritane). Ma sicuramente l’America intuì che dietro i gesti da dandy del francese c’era un enorme potenziale economico. La Borsa aprì un settore che ricalcava quello dello show business, almeno all’inizio dunque una branca dell’industria del divertimento, poi sempre più dai risvolti sinistri. Forse, è il limite di questo Diario, Fumaroli esagera nel considerare tutta la storia moderna come una faccenda francese o di francesi, certo è che le pose distratte di Duchamp cambiarono le sorti dell’avanguardismo internazionale. Man mano, alla ingenua credenza in un Rinascimento americano da parte degli espressionisti astratti, subentrò l’indifferenza efferata del pop. Nasceva lì, complice o meno la noia di Duchamp, il «contemporaneo» senza storia.
La buona sorpresa - Il macabro da Barnum – la morte senza il velo dell’allegoria e della litote, la morgue priva di eros, la «tautologia cadaverica» – è, insieme al cinismo, quello che sembra maggiormente colpire l’autore di questo Diario. Il saggista marsigliese si trova molto a disagio dentro una feroce macelleria. Di nuovo Valéry viene in soccorso, Fumaroli ha scoperto un’altra sua glossa indiretta al discorso di Baudelaire sullo choc: «Non dimentichiamo che una cosa molto bella ci rende muti d’ammirazione. […] Ma questo non va confuso con il mutismo dello stupore, la grande ossessione di molti moderni. Esso non distingue i generi di sorpresa. Uno soltanto si rinnova a ogni sguardo e diventa tanto più indefinibile e sensibile quanto più profondamente si esamina l’opera e ci si familiarizza. Si tratta della buona sorpresa. L’altro invece è semplicemente lo choc, capace di rompere una convenzione o un’abitudine, riducendosi appunto a un urto». Chi scrive al soldo del bluff estetico altro non fa che segnalare quel vile choc, la rottura di una convenzione o di un’abitudine anche visiva. Penoso compito.
.
Religione del libro o dell’immagine? - Avevamo scritto il 29 giugno scorso che d’ora in poi avremmo evitato in questo «Almanacco» di occuparci a lungo della fenomenologia del «contemporaneo», onde non lasciarsi mesmerizzare da simili pratiche. Ma Fumaroli partendo dal Barnum delle installazioni ci riconduce alla storia delle immagini e alla cultura cattolica dell’incarnazione che ne produsse le più divine. Al punto che ci si chiede se si possa parlare del cattolicesimo come religione del libro alla pari di fedi ‘auditive’ come l’ebraismo e l’islamismo. A Roma, l’astrattezza del monoteismo ‘platonico’ si fa concreto nell’immagine del Figlio incarnato. Non si abbia paura a dire che l’arte di derivazione cattolica discende direttamente dall’Eucarestia, dall’ostia che racchiude e nasconde corpo e sangue (non a caso la liturgia modernista vuole privilegiare la ‘parola’ nei confronti del mistero eucaristico). Anche il culto delle reliquie – i resti del corpo umano venerati dai cattolici e che provocano imbarazzo nelle altre fedi – discende dalla medesima fede nell’ostia. Nel mistero eucaristico, il divino è «ascoso nei mistici veli», nell’arte le velature trattengono il creato, il mondo redento. Il cristianesimo romano afferma che Dio ha lasciato l’empireo dei cieli ed è sceso in mezzo al vulgus delle parentele di sangue, dell’etnia ebraica, dei corpi umani troppo umani, delle donne e dei bambini che lo hanno frequentato, della giustizia umana che lo ha condannato, del gruppo di discepoli poveri di spirito. Le sue fattezze avranno suscitato già nei contemporanei l’aguzzamento del senso della vista: le folle si accalcavano per vederlo. Ma in tutto ciò i nostri parroci più candidi intravedono una pericolosa idolatria. Il professor Fumaroli invece ci ricorda che gustus è parola del latino tardo, del vocabolario cristiano, per indicare il desiderio di conoscere attraverso i sensi il Salvatore. Ed ora, quattro eretici che trafficano da oltre un secolo con le teorie spiritistiche ci vogliono convincere di un’arte puramente spirituale, o meglio del lugubre «spirituale nell’arte».
.
L’arte della incarnazione - «Il Logos vivente di Platone – scrive Fumaroli – si è lasciato vedere e toccare, amare e odiare sotto dei tratti umani. Ci vollero tredici secoli perché questo ossimoro vivente narrato dagli evangelisti, ravvivato dal culto paradossale delle reliquie e delle icone, rievocato dalle visioni, le estasi e le rivelazioni dei santi mistici, rivissuto dal ‘quinto Vangelo’ di Francesco di Assisi, cominciasse a trovare, nella contrarietà dei colti, la sua traduzione visiva nell’arte occidentale». Ecco l’arte della incarnazione, dove non è più disdicevole esaltare l’aspetto fisico dell’umano perché quel corpo è divenuto lo strumento della salvezza cosmica. Gli storici dell’arte ottocenteschi, imbevuti di cultura protestante, riproposero lo scandalo provato a Roma da Lutero e presero a parlare di « ritorno al paganesimo» per la riappropriazione italiana, tra il XII e il XV secolo, della statuaria antica e della «rappresentazione eroica della forma umana». Si trattava davvero di un ritorno alla fede negli dèi? Assolutamente no, piuttosto la mitologia pagana era un linguaggio simbolico, ben spendibile dentro il quadro cristiano, se ne usavano le immagini, cioè le metafore, la grammatica, ecc., per narrare la redenzione del mondo e della carne. Così come per rappresentare la passione di Cristo, gli artisti si interrogarono sul corpo e sui misteri del dolore, andarono a scuola dai chirurghi, sfogliarono attenti i volumi di anatomia, studiarono l’ottica, fissarono nello spazio le ‘finzioni’ prospettiche: volevano «mostrare, in tutta la sua bellezza eroica, il corpo di Cristo vincitore» della morte. Finché alle soglie del moderno, questo «ammirabile compromesso tra scienza ottica e visione simbolica» fu progressivamente condannato, quasi fossero i pittori umanisti i precursori della fotografia. Si ebbe lo strano caso di congreghe di laici che censuravano ogni attacco allo «spirituale nell’arte» e provavano orrore, disgusto morale, per ogni riferimento della pittura alla concretezza del corpo. Oggi sono i cultori dei video arte, o di quel pompierismo attuale che va sotto il nome di iperrealismo, a mostrare maggiore imbarazzo per l’arte ‘fisica’ della tradizione, a proclamarsi iconoclasti pur celebrando la riproduzione fotografica.
.
L’eterno ritorno della bellezza - Finalmente qui Fumaroli, con la grande erudizione che possiede nel campo della retorica antica, può liberarci dalle banalità sul Rinascimento molto pagano e poco cristiano. Ora è proprio con l’avvento dell’umanesimo che Roma, autonoma ormai dalle imposizioni bizantine come da quelle romano-imperiali, può mettere a punto la sua arte: il mondo ne sarà sbalordito.
.
Lo splendore del vero visibile - Il direttore dei musei pontifici sembrava riprendere queste riflessioni scrivendo qualche giorno fa sul giornale ufficiale della Santa Sede: «Chi, come me, dall’osservatorio privilegiato dei Musei Vaticani considera la storia delle arti sotto il segno della Chiesa di Roma non può non provare sentimenti di stupore e di gratitudine. Gratitudine, naturalmente, per i capolavori di bellezza e di sapienza che il messaggio cristiano ci ha regalato ma anche, e soprattutto, stupore e ammirazione di fronte ai meravigliosi azzardi che, nei secoli, la nostra Chiesa ha saputo giocare. Come quando, per esempio, fra quarto e quinto secolo, ha scelto come sua lingua figurativa l’arte greco-romana, l’ellenismo naturalistico e illusionistico. Azzardo immenso e carico di futuro è stato quello se si pensa che il cristianesimo veniva dall’ebraismo, la più ferocemente aniconica fra le culture del Mediterraneo e che senza quella scelta, il destino dell’arte in Occidente – Michelangelo e Rembrandt, Velasquez e Goya, Monet e Picasso – rischiava di identificarsi con la cifra e col segno, di diventare ‘ieroscrittura’, come nell’islam. Oppure quando – è l’epoca che i manuali chiamano del rinascimento – la Chiesa riconobbe nello splendore del vero visibile, l’epifania dell’Altissimo, l’ombra di Dio sulla terra. Non avremmo avuto, altrimenti, le nuvole di Giovanni Bellini, i riflessi nello specchio di Jan Van Eyck, la Stanza della Segnatura di Raffaello, la Canestra di frutta di Caravaggio, la Zattera di Medusa di Géricault».
.
La vista, il senso più cattolico - Walter Benjamin cercò di rendere visibile l’«esperienza accecante» di chi era costretto a vivere nell’«epoca della grande industria». Aveva capito che proprio la vista era la prima ad essere colpita dalla cultura industrializzata. Baudelaire, ancora una volta lui, aveva così tanta familiarità con la cultura cattolica delle immagini da esibire una intransigenza rigorosa verso le raffigurazioni deboli, compromesse con i luoghi comuni del presente. Fumaroli arriva a paragonare l’attenzione per le immagini delle gerarchie cattoliche della Controriforma, dei cardinali Borromeo e Paleotti, con l’inflessibile attività critica dei Baudelaire e degli Huysmans nell’Ottocento, quando i porporati non si prendevano più cura delle opere pittoriche. «Questo cattolico ama troppo l’arte di incarnare l’infinito nel finito per non mostrarsi impietoso nei confronti delle copie servili […]. Il ‘culto’ che pratica per le opere d’arte visuale non si rivolge a qualsiasi immagine. Egli ha uno sguardo d’aquila per distinguere quelle che blandiscono la vista per fare schermo all’anima da quelle che appagano la vista quanto più parlano all’anima. […] La sua iconofilia, come in Chateaubriand, è quella di un cattolico laico per il quale la grande arte è la sola reliquia degna e autentica, insieme alla grande poesia, che abbia lasciato dietro di sé la Chiesa che si allontana». A questo punto Fumaroli avrebbe potuto aggiungere una considerazione di Hofmannsthal che attribuiva alla Chiesa romana l’ultimo e concreto legame con il mondo classico. L’arte e la poesia, secondo il poeta francese, sarebbero le eredi della liturgia e dei grandi inni ecclesiastici. «La poetica e la critica d’arte di Baudelaire non derivano in nulla dall’estetismo e tutto dalla teologia».
I tre moschettieri - Tre moschettieri francesi combattono con scienza, bonomia e buonsenso contro i segni allucinati del «contemporaneo» e la loro comicità nera e involontaria: Alain Besançon, Jean Clair, Marc Fumaroli (schierandoli in ordine alfabetico). Tutti e tre sottolineano la radicale differenza con l’arte della tradizione cui si accostano richiamandosi con grande cognizione di causa alla cultura cattolica, anzi a quella che un tempo si sarebbe chiamata la civiltà cattolica, che almeno da un certo punto in poi coincise con la civiltà delle immagini. Besançon e Fumaroli ne hanno tentato anche una spiegazione teologica. In una pagina di questo Diario appena uscito ci si rifà addirittura all’insegnamento del prof. Ratzinger. Inimmaginabile una cosa del genere negli scritti dei nostri accademici. Loro sono ancora convinti che sia più chic magnificare lo choc.
sabato 29 agosto 2009
Totenlandschaft
~ PAESAGGIO DI MORTI, UN MONDO DI GHIACCIO TRASFORMATO IN CIMITERO: ALLE ORIGINI NORDICHE DELLA STORIA DELL’ARTE MODERNA, OVVERO COME PASSARE DALLA RAPPRESENTAZIONE DELLA NATURA DEI ROMANTICI AL VUOTO SPINTO DEL NICHILISMO ESTETICO. ~ SU UN VECCHIO LIBRO DI ROBERT ROSENBLUM ~
.
Avendo dedicato qualche puntata al decisivo passaggio tra Neoclassicismo e Romanticismo, là dove il paesaggio prende il posto del crocifisso e in quello scorcio cupo si gioca la suprema scommessa metafisica, ci piace a questo punto rammemorare e discutere uno storico dell’arte statunitense, Robert Rosenblum (1927-2006) che, qualche decennio fa, deviò dalla strada affollata che conduceva tutta l’arte moderna a Parigi e andò a indagare nei mondi gelidi del Nord Europa, tra gli antenati degli espressionisti, luoghi parecchio periferici rispetto alla capitale francese, addirittura agli antipodi di Roma, Siena, Firenze, Venezia, cuore della tradizione, mondi a lungo sconosciuti che ambirono poi nel Novecento a egemonizzare l’umanità, compiacendosi dunque di misurarsi con i tesori classici conservati agli Uffizi o al Louvre, opere tanto disprezzate, e in modo rozzamente moralistico, al momento della loro affermazione. A questi sentieri che si perdono nel bosco, agli Holzwege della storia dell’arte dedicò una serie di conferenze che risalgono all’inizio dei Settanta, poi raccolte in un volume: Modern Painting and the Northern Romantic Tradition: Friedrich to Rothko, tradotto in italiano dalle edizioni 5 Continents di Milano nel 2005, La pittura moderna e la tradizione romantica del Nord. Da Friedrich a Rothko. Spiace l’accostamento tra l’artista della Pomerania e l’ebreo-lituano suicida: se si deve mostrare una genealogia, rintracciare le cause della svolta, ossia dello svuotamento del quadro, dell’annichilimento della scena, della negazione dell’immagine, è giustissimo ritrovare nei deserti bianchi di Caspar David Friedrich, il pittore che voleva rompere con la tradizione artistica, la causa prima della degenerazione dei nostri tempi, ma risulta urticante vedere sul medesimo piano il solitario artista protestante e i nostri esteti senza opere. La degenerazione dell’arte, prima ancora che una trovata propagandistica dei nazisti, era evidente agli occhi dei più severi: così per esempio veniva bollata dall’apostolo del sionismo, Max Nordau, che già sul finire dell’Ottocento parlava di Entartung.
.
Su queste origini romantiche del Nord, sul ritorno dei tedeschi a dettar legge nel campo dell’arte alle soglie del moderno, dopo una eclisse di secoli, dissero esemplarmente, fuori dei confini germanici, Marcel Brion e il nostro Mittner soprattutto delle Ambivalenze romantiche, più recentemente in terra tedesca Werner Hofmann, ma Rosenblum colse nel segno quando scorse anzitutto un fenomeno religioso. Nel primo capitolo del suo volume scrisse della «resurrezione di Dio» (naturalmente contrapposta a quella «morte» annunciata da Nietzsche) per opera di alcuni pittori nordici, non tutti di area germanica. Da questa ‘resurrezione’, da questo Dio alquanto astratto, snodò il filo rosso dello spiritualismo che addirittura, all’inizio del Novecento, si pervertì in spiritismo, nei circoli di Madame Blakatskj che attrassero i Kandinskij e i Mondrian. Se è condivisibile allora la collocazione dell’origine di quella che abbiamo chiamato la religione dell’arte nelle speculazioni pittoriche di Friedrich come di Turner, nelle cosmogonie di Asmus Jacob Carstens, di William Blake e di Runge (su quest’ultimo v. «Almanacco Romano» del 18 luglio 2009), sembra azzardato tuttavia considerare ancora dei sacerdoti del culto estetico i protagonisti della deriva americana nella metà del Novecento, piuttosto rappresentanti delle loro personali nevrosi, adoratori dei loro modesti capricci.
.
Il fatto è che i primi, benché spingano al massimo il soggettivismo nell’atto di rappresentare, mantengono poi il legame con l’oggetto rappresentato, ne cercano anzi una fedeltà più sottile, condannando il manierismo degli inganni, dei trompe-l’oeils. I novecenteschi, invece negano la rappresentazione stessa, sostituita dall’espressione: un animalesco trasmettere delle emozioni. Ove Friedrich lavorerà niente di meno che sulla pittura di genere, appena torcendo in chiave introspettiva i paesaggi sinistri che si rifacevano, già in un cliché secolare, agli scenari aspri e severi di Salvator Rosa, con le figurine che vi si perdono. In luogo delle rocce che si immergono nelle marine capresi, quelle che scivolano nel Baltico, gli abeti invece dei pini ombrelliferi, cieli bianchi turbolenti al posto del sempiterno azzurro d’Italia, considerato ormai stucchevole.
Nel Monaco in riva al mare, opera cui Rosenblum dedica parecchie pagine, le radiografie hanno rivelato che inizialmente Friedrich dipinse diverse barche, poi via via le cancellò, così come uno scrittore procede togliendo personaggi e aggettivi in un racconto, ma senza per questo rinunciare al racconto, senza trasformarlo in un lirico delirio. Turner calcò la mano sull’aspetto soggettivo della rappresentazione, scarnificò come Friedrich l’episodio narrativo al suo significato più essenziale, eppure tutto ciò non intaccava il fatto che il quadro rappresentava appunto una scena spoglia, un episodio scabro, niente a che vedere, cioè, con le tautologie di Rothsko.
L’ascesi di Friedrich, le voluttuose percezioni di Turner non rovesciano il senso della pittura. Magari – a causa del sublime innalzato da Kant a nuova fede, diremmo noi – per gli spettatori moderni il dipinto del Monaco evoca una esperienza religiosa, «come se i misteri della religione avessero abbandonato i rituali delle chiese e delle sinagoghe e si fossero trasferiti nel mondo della natura», però è piuttosto negli occhi del pubblico che si è già consumata l’esperienza romantica del sacro e si è pienamente abbracciata la religione dell’arte. Nella pittura di Friedrich, ha ragione Rosenblum, si può rinvenire il cristianesimo di Schleiermacher, che Barth esalterà come un moderno riformatore della teologia protestante. Ma mentre Lutero voleva contrapporre il crocifisso agli splendori romani, i suoi seguaci, dopo appena due secoli, rimuovono anche il crocifisso e si fissano su un triste paesaggio panteista («nulla di più triste», notò subito Kleist a proposito del Monaco friedrichiano), una contemplazione della natura che surroga il Dio torturato nel corpo. «Nuove religioni prendono il posto del cristianesimo», osserva Rosenblum, nuovi martiri sono celebrati: «quando l’ateismo vorrà dei martiri, non ha che da dirlo: il mio sangue è qui pronto», fa dire alla sua libertina il marchese de Sade nella Nouvelle Justine. Sia pure esulando allora apparentemente dal tema, bisognerebbe riflettere su questi riformatori protestanti che non sono mai in grado di reagire adeguatamente all’anticristianesimo che marca il moderno, al massimo offrendo una via malinconica e dolorosa alla rassegnazione, una accettazione luttuosa dell’attualità che fa a meno di Cristo…
..
Il problema è che – come si accorge Rosenblum – «nei paesi cattolici e protestanti la trasposizione dell’esperienza cristiana si fonda inevitabilmente sulla corporeità ereditata dall’iconografia religiosa». Ma «nel Nord protestante, assai più che nel Sud cattolico, avvenne un altro genere di passaggio dal religioso al secolare durante il quale ci accorgiamo che i poteri divini hanno abbandonato i drammi di carne e ossa dell’arte cristiana per penetrare nel regno del paesaggio». Cristina Campo parlava di «meravigliosa carnalità della vita divina» ferita dalla Riforma e dall'Illuminismo.
..
L’Inchiesta filosofica sul Bello e sul Sublime di Edmund Burke dimostra che anche un conservatore tanto equilibrato da non lasciarsi irretire dall’ondata rivoluzionaria che viene dalla Francia, si fa ammaliare dalla natura selvaggia e prova languore e tremore nei confronti di questo sacro vegetale. Figlio di una cattolica e di un protestante, il Cicerone britannico sembra ondeggiare tra i due poli, tra realismo politico e mistica estetica. Il culto della natura nell’isola britannica si diffonde al di là delle confessioni religiose. Il «landscape painting» si tramuterà nell’inscape, paesaggio interiore, neologismo inventato da Hopkins, il gesuita poeta delle nuvole. Chateaubriand, romantico latino, conosceva bene questa mania del sublime per aver abitato la Gran Bretagna negli anni dell’esilio, e la criticò con forza nella Lettera sul paesaggio in pittura, datata Londra 1795. In nome del pittoresco se la prendeva con le «folli» dismisure del sublime, invitando a «rettificare l’immaginazione», a ridimensionare le montagne che toccano il cielo, i flutti che si alzano nei nostri pensieri, i venti e i tuoni, «Un million de choses incohérentes presque ridicules». Che il pittore insomma guardi attentamente l’oggetto della rappresentazione, lo studi, lo conosca, prima di fantasticare tanto.
.
Il Werther dolorante, una specie di Cristo dei pittori irresoluti con la sua passione e morte, scrive nel diario: «mi sentivo esaltato da questa pienezza traboccante fino a percepire la divinità […]. Montagne stupende mi circondavano, abissi si spalancavano ai miei piedi…». Il saggio Goethe sa che questo suo giovanotto sentimentale si inebria di sensazioni che lo condurranno alla triste fine. Allora, fa meditare il fatto che la «pienezza» dello spirituale, il sublime del paesaggio, trascini all’autodistruzione, nascondendo la morte ancora più subdolamente dell’Arcadia di Guercino e di Poussin. A furia di sentirsi – come scriveva Carl Gustav Carus nelle sue Lettere sul paesaggio – «insignificanti» rispetto alla immensità della natura, ci si convince della propria nullità. Tutto il contrario della cultura cattolica che dà autentica pienezza all’individuo, a cominciare dal corpo, a sua immagine, come viene raffigurato nella stagione aurea del Rinascimento.
.
Nel 1907 apparve la tesi di dottorato di Wilhelm Worringer, Abstraktion und Einfühlung: l’astrazione si rifaceva all’arte islamica ma doveva incrociarsi con le sperimentazioni del Cavaliere Azzurro; l’Einfühulung era invece quell’empatia, quell’espandersi nel mondo, quel fondersi in un oggetto esterno che rompeva i ponti con la logica e la razionalità della rappresentazione. Il termine proveniva da Friedrich Schlegel e da uno stuolo di altri romantici. «La storia dell’arte – commenta Jean Clair – diviene così la storia delle pulsioni primitive, dei bisogni primordiali di esprimersi, come se creare e gridare, per esempio, come se cantare e comunicare, come se ‘esprimersi’ e ‘dire’ fossero una sola e identica cosa». Il passaggio segreto tra romantici del Nord ed espressionisti di tutte le risme risiede qui. L’importante è aver sempre presente le differenze che pure si mantengono tra i due movimenti.
Friedrichs Totenlandschaft, un paesaggio di morti di Friedrich, secondo un verso di Karl Theodor Körner: vi si raffigura esclusivamente la morte. Rosenblum lo paragona a Die Winterreise di Schubert, «un mondo gelato trasformato in cimitero». Un viaggio di morte infatti scrisse il musicista trentenne prima di concludere la vita terrena, una via crucis laica di ventiquattro stazioni – o della medesima religiosità di Friedrich, appunto –, un viaggio interiore sicuramente, allucinato anche, una estrema metafisica dell’assiderazione, ma c’è il canto che si dispiega – come nei quadri di Friedrich si raffigura ancora –, Lieder dolcissimi mitigano il cammino sotto l’egida di Saturno, melodie che gareggiano con l’infinito dolore del pittore del Nord, lacrime ghiacciate, marmoree scene, che riecheggiano i paesaggi del pittore, l’algido mondo della bianca luce, mentre gli epigoni sapranno solo trafficare con la morte come necrofori, senza più produrre alcunché di buono.
.
Magistrale era stato l’intervento del giovane Rudolf Borchardt sulla natura nordica e in specie tedesca, spiegata a contrasto con quella italiana, e in specie toscana, cui lo scrittore aveva dedicato il prezioso saggio «Villa» (1907). Riassumendo la lezione di Goethe e il tourbillon romantico, Borchardt scriveva: «nella religione del Sud si è sempre santificata la natura, già resa domestica e ferace di beni utili, mentre in quella del Nord ci si abbandona a una natura selvaggia, senza impronta di sé e a se stessa bastante. […] L’uomo di questa religione ama andare errando a inerpicarsi dovunque, calzato e attrezzato, su per rocce, neve e ghiacciai, ‘incontro alla tempesta, alla pioggia e al vento’; gli piace sostare in solitudine, anzi anela di trovarsi solo e di avere intorno a sé le foreste, sopra di sé le montagne, terre colte e case ai suoi piedi, distanti; quello dell’altra vuole abitare in un qualche posto. L’uno è insofferente a qualunque dimora; l’altro sta di casa in antichissime, bianche masserie, tra campi e armenti, pensoso dei suoi morti, e dalle mani delle divine stagioni compiacenti riceve i simboli della campagna: bianca farina e pani d’oro per i campi in piano, olio dorato per le ulivete, vino bianco o nero per le vigne, castagne per i boschi montani, una cornucopia di frutta per i frutteti – tributi della terra, ieri nemica, oggi suddita soave…». Schematizzando le parole del Giardiniere appassionato – come si autoritrarrà in un titolo – , del signore che abita la villa della Lucchesia, dell’ebreo che idealizza i regni tirrenici e sulle rive di questo mare incontra i suoi eletti amici, a cominciare da Hofmannsthal, da una parte la cultura cattolica, dall’altra non tanto quella luterana bensì la più evanescente religiosità dei Friedrich, dei Novalis, dei Jean Paul. «La sofferenza degli antichi arii – proseguiva Borchardt – per l’individuo, l’angoscia per la sua insana inquietudine, le contraddizioni che fanno ressa nell’anima sua, risvegliano nell’uomo del Nord il ricordo di un’esistenza più elementare, ormai perduta, e lo spingono verso una misteriosa fratellanza con ogni albero o fiume o roccia, verso ciò che vive come Dio ha stabilito e non conosce contraddizioni; la sua è nostalgia dei puri istinti […]; egli fugge se stesso e può chiamare Dio quello che cerca: anche lui è un fiume e cerca la sua foce». Eterno annaspare verso le origini, ritorni a quell’arcaico che nel Novecento si affermò nella pittura espressionista e nella poesia ‘dorica’ di Benn, mentre l’animo meridionale «non può risalire verso una primigenia condizione che già più non esisteva quando i latini si affacciarono alla storia, anzi era anteriore ai loro stessi miti. In fondo, il latino torna col desiderio a un’epoca intermedia…». Per il resto, si pasce dell’eternità divina. Ecco perché «il suo doloroso contrario – la condizione nel tempo opposta a quella eternità, la maledizione opposta a quel paradiso – egli non potrà mai sentirlo col mistico dissidio dell’anima del cui paradiso, il mondo selvaggio e smemorato, egli ha ormai perduto ogni ricordo» (da «Villa» in Città italiane, Adelphi, 1989, pp. 46-50 passim). All’inizio del Novecento, ancora lontani dalla generalizzazione del «globetto», come lo chiamava già Leopardi, gli italici rappresentati da Borchardt non potevano deliziarsi di una pittura tanto estranea e senza garbo, o meglio di una religione tanto selvatica come quella messa in scena da Friedrich.
..
L’aspetto antropologico che ancora nei coevi pittori francesi sapeva affermarsi, tra i nuovi mistici tedeschi è travolto dal «dominio della natura in cui l’uomo svolge il ruolo di un intruso malvagio e sfortunato». Lo stesso che si affermerà nei nostri tempi, nei quali l’uomo che attraversa una spiaggia o una foresta è visto come un profanatore, quasi la terra non fosse più ai suoi piedi. Il culto di Gea è la nuova religione pagana e oscura, che prese le mosse con il conte di Shaftesbury, con i giardini devotamente selvaggi all’inglese, che consacra la natura. Oggi più che mai il confuso pensiero neopagano sacralizza terra e ambiente, le si prostra devoto. Già ai tempi di Friedrich comunque sembrano attribuirsi sentimenti umani agli elementi del paesaggio.
.
L’Europa cristiana presenta paesaggi che contengono campanili, cupole, croci, città turrite, rovine classiche, «macerie gotiche» (Chateaubriand), ma ormai nei quadri di questi monaci dell’interiorità sono appena uno spettacolo, un pretesto pittoresco, un punto d’appoggio per spiccare il volo spirituale. Uno po’ come nel nostro tempo diventano sfondo per offrire valore aggiunto di suggestione a concerti e recital di poesie che evidentemente ne sono privi. Spiritualità spicciola a paragone con quella degli antichi credenti. Runge si sentiva ormai «al margine di tutte le religioni che sono nate dalla religione cattolica». Ed era convinto che ogni residuo religioso, ogni eclettismo estetico, «tutto cerca il paesaggio». Si passa «dai tradizionali temi cristiani ai loro surrogati» dice Rosenblum.
(È curioso che in una paradossale ed eccentrica scrittura di un post-moderno come Derrida si scopra come il filosofo ebreo francese ideando una mostra per ciechi, che produce a sua volta un testo, Memorie di cieco, ricorra a svariati esempi della tradizione – la Guarigione del cieco, i Ciechi di Gerico, Tobia e l’Angelo, Omero con gli occhi spenti, gli occhiali di Chardin o quelli che si scorgono in un disegno di Pisanello, allegorie sacre e profane – mai utilizzando gli occhi interiori della pittura romantica nordica e men che mai quelli dei contemporanei.)
Dalla «sopravvivenza e rinascita del romanticismo nel tardo ottocento» Rosenblum trae un altro capitolo. Il romanticismo come «potere originale di evocare il divino e il misterioso». Visioni e atmosfere di santità si placano nella metà dell’Ottocento mentre si afferma il Biedermeier e il realismo di marca francese. Si alterna pertanto l’addomesticamento della natura e l’addomesticamento dell’uomo.
Al contrario di quel che pensa Rosenblum, l’arte e la letteratura protestanti non traggono dalla natura una «umanizzazione del divino», bensì il divino perde così il più sottile tratto personificante e perfino il panteismo dimentica l’aspetto provvidenziale, riducendosi tutto a meccanismo cieco e oppressivo. «Se ci si allontana da Parigi», comunque, si scopre che questa ricerca religiosa nel naturale, volgendo le spalle all’Art pour l’art, prosegue il suo cammino eretico per l’intero secolo diciannovesimo. «L’opera di Vincent van Gogh – sostiene l’autore del libro – è il migliore esempio di questa sopravvivenza, o forse rinascita, nel diciannovesimo secolo postimpressionista, delle questioni sollevate dai romantici del Nord». Riesce l’accostamento tra i paesaggi desolanti con rovine gotiche, talvolta con figurine angosciose, di certi dipinti di van Gogh, e i paesaggi di Friedrich. Così come è accattivante il confronto tra alcuni ritratti di van Gogh e quelli di Runge: in ambedue le opere i bambini appaiono impressionanti «per dimensione e vitalità», «costringendo la madre a un ruolo subordinato, quello dell’albero vecchio e debole…». Segno ancora più eloquente di una tendenza spirituale dell’epoca, va detto che nulla ci autorizza a sospettare che il pittore olandese abbia mai visto anche una sola opera dei due artisti tedeschi.
Scendendo verso altri epigoni del pittore di Greifswald, l’autore dedica un capitolo a Munch. Il norvegese voleva dipingere immagini che costringessero gli uomini «a togliersi il cappello come se fossero in chiesa». Compose opere che piuttosto provocavano la compassione come in un ospedale psichiatrico. Anche nei quadri di Munch ci sono figure solitarie in tensione con la natura. In essi la contrapposizione degli umani-lillipuziani alla potenza della natura diviene contrasto violento tra le figure umane (femminili spesso) e la terrificante (agli occhi del pittore) potenza sessuale. Un magnetismo che si diffonde, un erotismo che però sembra voler fare a meno dei sensi e si trasforma in religione dei fantasmi. Paesaggi psicologici che denunciano delle patologie; geografie dell’anima inquieta. Questo il moderno che si distacca dalla religione di Roma. Ecco allora un trionfo della morte affidato a scarabocchi ossessivi, a caricature, a mostriciattoli, a visioni di adolescenti truci che riempiono i quaderni di segni sinistri, allusioni suicidarie, di morte e sesso sognati, di curiosità insoddisfatte per i misteri della vita.
C’era chi si immedesimava negli alberi e chi negli animali. Franz Marc fu uno di questi. I temi perciò restavano romantici, magari aggrovigliandosi maggiormente, ma le forme si immiserivano. I paesaggi non presentavano soltanto nero e morte, bensì puro niente. Lo aveva preannunciato Basilius von Ramdohr, politico conservatore, diplomatico prussiano, critico d’arte che aveva visto Napoli e Roma, vivendo nelle città mediterranee e studiando l’arte di quaggiù, quando partì all’attacco di Friedrich, in particolare della sua Croce in montagna e, in base a quest’opera, profetizzò sconvolto: «la sfortunata cova del periodo presente è l’orrendo presagio di una barbarie che velocemente si avvicina». E in un articolo per la «Zeitung für die elegante Welt» del gennaio 1809: «Quel misticismo che ora si insinua ovunque e che, dall’arte come dalla scienza,dalla filosofia come dalla religione, esala verso di noi come un fumo narcotizzante! Quel misticismo che spaccia simboli e fantasie per immagini pittoriche e poetiche, che vorrebbe scambiare l’antichità; classica con l’intaglio gotico, con rigide calcografie e con leggende! Quel misticismo che, al posto dei concetti vende giochi di parole…».
Strada facendo infatti – ma questo Rosenblum non lo dice –, man mano che i quadri diventavano verbosi, predicatorî, oracolari e sintomatici dell’estremo male esistenziale, le immagini si impoverivano. Ridotte all’essenziale nei romantici e post-romantici di fine Ottocento, sfiorando la naïveté figurativa dell’infanzia, finiranno per rinnegare se stesse, per diventare iconoclaste, segni iconoclasti; si bloccheranno (e baloccheranno) in una contraddizione mortale che è quella presente. Rosenblum invece vi cerca ancora una fertile discendenza.
Da parte di certi pittori, insomma, c’era il rifiuto del loro ruolo di decoratori del mondo, che non era cosa di poco conto: completare l’opera della creazione, rendere più evidente la bellezza dell’universo, un affare divino; considerando questa attività millenaria come un’opera servile, si inventarono una nuova missione, presero a vantarsi di scoprire i misteri, di rivelare le cose nascoste (o quantomeno di costruire un clima misterioso e segreto senza risolvere alcunché), di promuovere riti di incantesimo, di suscitare magie facili, di agitare simboli scontati. C’era dunque, e non solo in Munch, «l’ambizione romantica di ideare nuovi sistemi iconografici». Mancava loro però l’Iconologia di Ripa e mancava un qualche personaggio che, alla sua altezza, sapesse redigere un codice della simbologia moderna. Più che altro, sembravano rifarsi alla teosofia di moda nei salotti mediocri.
Invece di meditare sui tormenti umani del Dio incarnato o di sbizzarrirsi sui piaceri del Cielo, dando una direzione alla mistica anche estrema, un luogo figurato, un recinto concettuale, una silhouette individuale, una linea di contorno che permetta di distinguere, ci si immerge in una pittura di allusioni vaghe, di percezioni incerte, di pretese somme, di emotività senza alcun controllo. È la forma a essere sacrificata insieme ai sensi repressi. Giardini senza profumi, alberi carichi di simboli; non spira da queste parti la brezza sensuale.
Le opere di tali artisti dimostrano come la più profonda laicizzazione dell’arte religiosa sia avvenuta per opera dei romantici, proprio distruggendo l’antica separazione tra arte sacra e profana, sacralizzandola tutta in chiave che potremmo definire gnostica. Sbagliava il pur acuto Florenskij quando, con i sospetti russo-ortodossi per la tecnica della prospettiva che credevano d’ordine satanico, accusava il Rinascimento italiano di aver annientato l’arte sacra: era proprio quella armonia tra il cielo e la terra, tra lo spirito e la carne, che rispecchiava al meglio il cristianesimo romano e metteva in fuga le visioni eretiche. Quella eccelsa pittura latina era la gloria cattolica. E i più duri colpi le furono inferti dal romanticismo tedesco.
L’onnipotenza della natura diverrà una forza apocalittica che tutto distrugge: una natura sottratta alla lezione biblica e una morte sottratta al conforto cristiano si trasformano in un’unica, mostruosa, potenza. Una forza catastrofica. Talvolta anche la guerra parteciperà di questa energia annientatrice. La visione degli artisti volontari nel primo conflitto mondiale può così ricordare il sublime della fine Settecento, «un sermone religioso volto a ispirare terrore», dice Rosenblum. Questa la religione che annienta il creato.
Una religione che rifiuta il mondo sensibile e si libra nell’astratto è però ancora più spaventevole. Bisogna proprio averci fatto l’abitudine per non essere più sconvolti da certi titoli e affermazioni che costellano il libro: distruzione apocalittica, fine del mondo, mondo subumano, ritorno al primitivo, all’arcaico…
Rosenblum ricorda che soltanto perché orientati all’Art pour l’art di parigina origine possiamo considerare l’astrattismo come mosso da impulsi di carattere estetico. Piuttosto un terremoto spirituale, misticismo senza religione, cosmogonie personali, rivelazioni prêt-à-porter. I sogni romantici, ancora dentro una forma, divengono adesso informi conati di assoluto. Se si vuole capire quant’è lungo il cammino e triste la parabola: Runge si ispirava alle teorie di Goethe, Mondrian a quelle miserabili di Rudolf Steiner.
Gli eredi moderni del romanticismo del Nord abbandonavano il mondo secolare per manifestare – si dice – un sentimento religioso. Ma questo non era più, appunto, il sentimento cristiano che crede nel mondo creato da Dio e ne gioisce, bensì un’impressione dualistica che separa il corpo dall’anima, che proclama la propria estraneità al cosmo, che denigra la realtà materiale a frutto di un cattivo demiurgo, da respingere e da fuggire.
L’iconoclastia protestante costrinse quasi gli artisti romantici a una nuova iconografia. I loro seguaci, dal protestantesimo ben più tiepido o del tutto assopito, privi anche della cultura dei maestri, ripiegarono sulla negazione dell’immagine. Perché non considerare allora la Cappella di Rothko soltanto come una parodia delle concezioni di Runge? Sì, l’angoscia potrebbe essere comune ma la forma da darle si è persa per strada.
.
Avendo dedicato qualche puntata al decisivo passaggio tra Neoclassicismo e Romanticismo, là dove il paesaggio prende il posto del crocifisso e in quello scorcio cupo si gioca la suprema scommessa metafisica, ci piace a questo punto rammemorare e discutere uno storico dell’arte statunitense, Robert Rosenblum (1927-2006) che, qualche decennio fa, deviò dalla strada affollata che conduceva tutta l’arte moderna a Parigi e andò a indagare nei mondi gelidi del Nord Europa, tra gli antenati degli espressionisti, luoghi parecchio periferici rispetto alla capitale francese, addirittura agli antipodi di Roma, Siena, Firenze, Venezia, cuore della tradizione, mondi a lungo sconosciuti che ambirono poi nel Novecento a egemonizzare l’umanità, compiacendosi dunque di misurarsi con i tesori classici conservati agli Uffizi o al Louvre, opere tanto disprezzate, e in modo rozzamente moralistico, al momento della loro affermazione. A questi sentieri che si perdono nel bosco, agli Holzwege della storia dell’arte dedicò una serie di conferenze che risalgono all’inizio dei Settanta, poi raccolte in un volume: Modern Painting and the Northern Romantic Tradition: Friedrich to Rothko, tradotto in italiano dalle edizioni 5 Continents di Milano nel 2005, La pittura moderna e la tradizione romantica del Nord. Da Friedrich a Rothko. Spiace l’accostamento tra l’artista della Pomerania e l’ebreo-lituano suicida: se si deve mostrare una genealogia, rintracciare le cause della svolta, ossia dello svuotamento del quadro, dell’annichilimento della scena, della negazione dell’immagine, è giustissimo ritrovare nei deserti bianchi di Caspar David Friedrich, il pittore che voleva rompere con la tradizione artistica, la causa prima della degenerazione dei nostri tempi, ma risulta urticante vedere sul medesimo piano il solitario artista protestante e i nostri esteti senza opere. La degenerazione dell’arte, prima ancora che una trovata propagandistica dei nazisti, era evidente agli occhi dei più severi: così per esempio veniva bollata dall’apostolo del sionismo, Max Nordau, che già sul finire dell’Ottocento parlava di Entartung.
.
Su queste origini romantiche del Nord, sul ritorno dei tedeschi a dettar legge nel campo dell’arte alle soglie del moderno, dopo una eclisse di secoli, dissero esemplarmente, fuori dei confini germanici, Marcel Brion e il nostro Mittner soprattutto delle Ambivalenze romantiche, più recentemente in terra tedesca Werner Hofmann, ma Rosenblum colse nel segno quando scorse anzitutto un fenomeno religioso. Nel primo capitolo del suo volume scrisse della «resurrezione di Dio» (naturalmente contrapposta a quella «morte» annunciata da Nietzsche) per opera di alcuni pittori nordici, non tutti di area germanica. Da questa ‘resurrezione’, da questo Dio alquanto astratto, snodò il filo rosso dello spiritualismo che addirittura, all’inizio del Novecento, si pervertì in spiritismo, nei circoli di Madame Blakatskj che attrassero i Kandinskij e i Mondrian. Se è condivisibile allora la collocazione dell’origine di quella che abbiamo chiamato la religione dell’arte nelle speculazioni pittoriche di Friedrich come di Turner, nelle cosmogonie di Asmus Jacob Carstens, di William Blake e di Runge (su quest’ultimo v. «Almanacco Romano» del 18 luglio 2009), sembra azzardato tuttavia considerare ancora dei sacerdoti del culto estetico i protagonisti della deriva americana nella metà del Novecento, piuttosto rappresentanti delle loro personali nevrosi, adoratori dei loro modesti capricci.
.
Il fatto è che i primi, benché spingano al massimo il soggettivismo nell’atto di rappresentare, mantengono poi il legame con l’oggetto rappresentato, ne cercano anzi una fedeltà più sottile, condannando il manierismo degli inganni, dei trompe-l’oeils. I novecenteschi, invece negano la rappresentazione stessa, sostituita dall’espressione: un animalesco trasmettere delle emozioni. Ove Friedrich lavorerà niente di meno che sulla pittura di genere, appena torcendo in chiave introspettiva i paesaggi sinistri che si rifacevano, già in un cliché secolare, agli scenari aspri e severi di Salvator Rosa, con le figurine che vi si perdono. In luogo delle rocce che si immergono nelle marine capresi, quelle che scivolano nel Baltico, gli abeti invece dei pini ombrelliferi, cieli bianchi turbolenti al posto del sempiterno azzurro d’Italia, considerato ormai stucchevole.
Nel Monaco in riva al mare, opera cui Rosenblum dedica parecchie pagine, le radiografie hanno rivelato che inizialmente Friedrich dipinse diverse barche, poi via via le cancellò, così come uno scrittore procede togliendo personaggi e aggettivi in un racconto, ma senza per questo rinunciare al racconto, senza trasformarlo in un lirico delirio. Turner calcò la mano sull’aspetto soggettivo della rappresentazione, scarnificò come Friedrich l’episodio narrativo al suo significato più essenziale, eppure tutto ciò non intaccava il fatto che il quadro rappresentava appunto una scena spoglia, un episodio scabro, niente a che vedere, cioè, con le tautologie di Rothsko.
L’ascesi di Friedrich, le voluttuose percezioni di Turner non rovesciano il senso della pittura. Magari – a causa del sublime innalzato da Kant a nuova fede, diremmo noi – per gli spettatori moderni il dipinto del Monaco evoca una esperienza religiosa, «come se i misteri della religione avessero abbandonato i rituali delle chiese e delle sinagoghe e si fossero trasferiti nel mondo della natura», però è piuttosto negli occhi del pubblico che si è già consumata l’esperienza romantica del sacro e si è pienamente abbracciata la religione dell’arte. Nella pittura di Friedrich, ha ragione Rosenblum, si può rinvenire il cristianesimo di Schleiermacher, che Barth esalterà come un moderno riformatore della teologia protestante. Ma mentre Lutero voleva contrapporre il crocifisso agli splendori romani, i suoi seguaci, dopo appena due secoli, rimuovono anche il crocifisso e si fissano su un triste paesaggio panteista («nulla di più triste», notò subito Kleist a proposito del Monaco friedrichiano), una contemplazione della natura che surroga il Dio torturato nel corpo. «Nuove religioni prendono il posto del cristianesimo», osserva Rosenblum, nuovi martiri sono celebrati: «quando l’ateismo vorrà dei martiri, non ha che da dirlo: il mio sangue è qui pronto», fa dire alla sua libertina il marchese de Sade nella Nouvelle Justine. Sia pure esulando allora apparentemente dal tema, bisognerebbe riflettere su questi riformatori protestanti che non sono mai in grado di reagire adeguatamente all’anticristianesimo che marca il moderno, al massimo offrendo una via malinconica e dolorosa alla rassegnazione, una accettazione luttuosa dell’attualità che fa a meno di Cristo…
..
Il problema è che – come si accorge Rosenblum – «nei paesi cattolici e protestanti la trasposizione dell’esperienza cristiana si fonda inevitabilmente sulla corporeità ereditata dall’iconografia religiosa». Ma «nel Nord protestante, assai più che nel Sud cattolico, avvenne un altro genere di passaggio dal religioso al secolare durante il quale ci accorgiamo che i poteri divini hanno abbandonato i drammi di carne e ossa dell’arte cristiana per penetrare nel regno del paesaggio». Cristina Campo parlava di «meravigliosa carnalità della vita divina» ferita dalla Riforma e dall'Illuminismo.
..
L’Inchiesta filosofica sul Bello e sul Sublime di Edmund Burke dimostra che anche un conservatore tanto equilibrato da non lasciarsi irretire dall’ondata rivoluzionaria che viene dalla Francia, si fa ammaliare dalla natura selvaggia e prova languore e tremore nei confronti di questo sacro vegetale. Figlio di una cattolica e di un protestante, il Cicerone britannico sembra ondeggiare tra i due poli, tra realismo politico e mistica estetica. Il culto della natura nell’isola britannica si diffonde al di là delle confessioni religiose. Il «landscape painting» si tramuterà nell’inscape, paesaggio interiore, neologismo inventato da Hopkins, il gesuita poeta delle nuvole. Chateaubriand, romantico latino, conosceva bene questa mania del sublime per aver abitato la Gran Bretagna negli anni dell’esilio, e la criticò con forza nella Lettera sul paesaggio in pittura, datata Londra 1795. In nome del pittoresco se la prendeva con le «folli» dismisure del sublime, invitando a «rettificare l’immaginazione», a ridimensionare le montagne che toccano il cielo, i flutti che si alzano nei nostri pensieri, i venti e i tuoni, «Un million de choses incohérentes presque ridicules». Che il pittore insomma guardi attentamente l’oggetto della rappresentazione, lo studi, lo conosca, prima di fantasticare tanto.
.
Il Werther dolorante, una specie di Cristo dei pittori irresoluti con la sua passione e morte, scrive nel diario: «mi sentivo esaltato da questa pienezza traboccante fino a percepire la divinità […]. Montagne stupende mi circondavano, abissi si spalancavano ai miei piedi…». Il saggio Goethe sa che questo suo giovanotto sentimentale si inebria di sensazioni che lo condurranno alla triste fine. Allora, fa meditare il fatto che la «pienezza» dello spirituale, il sublime del paesaggio, trascini all’autodistruzione, nascondendo la morte ancora più subdolamente dell’Arcadia di Guercino e di Poussin. A furia di sentirsi – come scriveva Carl Gustav Carus nelle sue Lettere sul paesaggio – «insignificanti» rispetto alla immensità della natura, ci si convince della propria nullità. Tutto il contrario della cultura cattolica che dà autentica pienezza all’individuo, a cominciare dal corpo, a sua immagine, come viene raffigurato nella stagione aurea del Rinascimento.
.
Nel 1907 apparve la tesi di dottorato di Wilhelm Worringer, Abstraktion und Einfühlung: l’astrazione si rifaceva all’arte islamica ma doveva incrociarsi con le sperimentazioni del Cavaliere Azzurro; l’Einfühulung era invece quell’empatia, quell’espandersi nel mondo, quel fondersi in un oggetto esterno che rompeva i ponti con la logica e la razionalità della rappresentazione. Il termine proveniva da Friedrich Schlegel e da uno stuolo di altri romantici. «La storia dell’arte – commenta Jean Clair – diviene così la storia delle pulsioni primitive, dei bisogni primordiali di esprimersi, come se creare e gridare, per esempio, come se cantare e comunicare, come se ‘esprimersi’ e ‘dire’ fossero una sola e identica cosa». Il passaggio segreto tra romantici del Nord ed espressionisti di tutte le risme risiede qui. L’importante è aver sempre presente le differenze che pure si mantengono tra i due movimenti.
Friedrichs Totenlandschaft, un paesaggio di morti di Friedrich, secondo un verso di Karl Theodor Körner: vi si raffigura esclusivamente la morte. Rosenblum lo paragona a Die Winterreise di Schubert, «un mondo gelato trasformato in cimitero». Un viaggio di morte infatti scrisse il musicista trentenne prima di concludere la vita terrena, una via crucis laica di ventiquattro stazioni – o della medesima religiosità di Friedrich, appunto –, un viaggio interiore sicuramente, allucinato anche, una estrema metafisica dell’assiderazione, ma c’è il canto che si dispiega – come nei quadri di Friedrich si raffigura ancora –, Lieder dolcissimi mitigano il cammino sotto l’egida di Saturno, melodie che gareggiano con l’infinito dolore del pittore del Nord, lacrime ghiacciate, marmoree scene, che riecheggiano i paesaggi del pittore, l’algido mondo della bianca luce, mentre gli epigoni sapranno solo trafficare con la morte come necrofori, senza più produrre alcunché di buono.
.
Magistrale era stato l’intervento del giovane Rudolf Borchardt sulla natura nordica e in specie tedesca, spiegata a contrasto con quella italiana, e in specie toscana, cui lo scrittore aveva dedicato il prezioso saggio «Villa» (1907). Riassumendo la lezione di Goethe e il tourbillon romantico, Borchardt scriveva: «nella religione del Sud si è sempre santificata la natura, già resa domestica e ferace di beni utili, mentre in quella del Nord ci si abbandona a una natura selvaggia, senza impronta di sé e a se stessa bastante. […] L’uomo di questa religione ama andare errando a inerpicarsi dovunque, calzato e attrezzato, su per rocce, neve e ghiacciai, ‘incontro alla tempesta, alla pioggia e al vento’; gli piace sostare in solitudine, anzi anela di trovarsi solo e di avere intorno a sé le foreste, sopra di sé le montagne, terre colte e case ai suoi piedi, distanti; quello dell’altra vuole abitare in un qualche posto. L’uno è insofferente a qualunque dimora; l’altro sta di casa in antichissime, bianche masserie, tra campi e armenti, pensoso dei suoi morti, e dalle mani delle divine stagioni compiacenti riceve i simboli della campagna: bianca farina e pani d’oro per i campi in piano, olio dorato per le ulivete, vino bianco o nero per le vigne, castagne per i boschi montani, una cornucopia di frutta per i frutteti – tributi della terra, ieri nemica, oggi suddita soave…». Schematizzando le parole del Giardiniere appassionato – come si autoritrarrà in un titolo – , del signore che abita la villa della Lucchesia, dell’ebreo che idealizza i regni tirrenici e sulle rive di questo mare incontra i suoi eletti amici, a cominciare da Hofmannsthal, da una parte la cultura cattolica, dall’altra non tanto quella luterana bensì la più evanescente religiosità dei Friedrich, dei Novalis, dei Jean Paul. «La sofferenza degli antichi arii – proseguiva Borchardt – per l’individuo, l’angoscia per la sua insana inquietudine, le contraddizioni che fanno ressa nell’anima sua, risvegliano nell’uomo del Nord il ricordo di un’esistenza più elementare, ormai perduta, e lo spingono verso una misteriosa fratellanza con ogni albero o fiume o roccia, verso ciò che vive come Dio ha stabilito e non conosce contraddizioni; la sua è nostalgia dei puri istinti […]; egli fugge se stesso e può chiamare Dio quello che cerca: anche lui è un fiume e cerca la sua foce». Eterno annaspare verso le origini, ritorni a quell’arcaico che nel Novecento si affermò nella pittura espressionista e nella poesia ‘dorica’ di Benn, mentre l’animo meridionale «non può risalire verso una primigenia condizione che già più non esisteva quando i latini si affacciarono alla storia, anzi era anteriore ai loro stessi miti. In fondo, il latino torna col desiderio a un’epoca intermedia…». Per il resto, si pasce dell’eternità divina. Ecco perché «il suo doloroso contrario – la condizione nel tempo opposta a quella eternità, la maledizione opposta a quel paradiso – egli non potrà mai sentirlo col mistico dissidio dell’anima del cui paradiso, il mondo selvaggio e smemorato, egli ha ormai perduto ogni ricordo» (da «Villa» in Città italiane, Adelphi, 1989, pp. 46-50 passim). All’inizio del Novecento, ancora lontani dalla generalizzazione del «globetto», come lo chiamava già Leopardi, gli italici rappresentati da Borchardt non potevano deliziarsi di una pittura tanto estranea e senza garbo, o meglio di una religione tanto selvatica come quella messa in scena da Friedrich.
..
L’aspetto antropologico che ancora nei coevi pittori francesi sapeva affermarsi, tra i nuovi mistici tedeschi è travolto dal «dominio della natura in cui l’uomo svolge il ruolo di un intruso malvagio e sfortunato». Lo stesso che si affermerà nei nostri tempi, nei quali l’uomo che attraversa una spiaggia o una foresta è visto come un profanatore, quasi la terra non fosse più ai suoi piedi. Il culto di Gea è la nuova religione pagana e oscura, che prese le mosse con il conte di Shaftesbury, con i giardini devotamente selvaggi all’inglese, che consacra la natura. Oggi più che mai il confuso pensiero neopagano sacralizza terra e ambiente, le si prostra devoto. Già ai tempi di Friedrich comunque sembrano attribuirsi sentimenti umani agli elementi del paesaggio.
.
L’Europa cristiana presenta paesaggi che contengono campanili, cupole, croci, città turrite, rovine classiche, «macerie gotiche» (Chateaubriand), ma ormai nei quadri di questi monaci dell’interiorità sono appena uno spettacolo, un pretesto pittoresco, un punto d’appoggio per spiccare il volo spirituale. Uno po’ come nel nostro tempo diventano sfondo per offrire valore aggiunto di suggestione a concerti e recital di poesie che evidentemente ne sono privi. Spiritualità spicciola a paragone con quella degli antichi credenti. Runge si sentiva ormai «al margine di tutte le religioni che sono nate dalla religione cattolica». Ed era convinto che ogni residuo religioso, ogni eclettismo estetico, «tutto cerca il paesaggio». Si passa «dai tradizionali temi cristiani ai loro surrogati» dice Rosenblum.
(È curioso che in una paradossale ed eccentrica scrittura di un post-moderno come Derrida si scopra come il filosofo ebreo francese ideando una mostra per ciechi, che produce a sua volta un testo, Memorie di cieco, ricorra a svariati esempi della tradizione – la Guarigione del cieco, i Ciechi di Gerico, Tobia e l’Angelo, Omero con gli occhi spenti, gli occhiali di Chardin o quelli che si scorgono in un disegno di Pisanello, allegorie sacre e profane – mai utilizzando gli occhi interiori della pittura romantica nordica e men che mai quelli dei contemporanei.)
Dalla «sopravvivenza e rinascita del romanticismo nel tardo ottocento» Rosenblum trae un altro capitolo. Il romanticismo come «potere originale di evocare il divino e il misterioso». Visioni e atmosfere di santità si placano nella metà dell’Ottocento mentre si afferma il Biedermeier e il realismo di marca francese. Si alterna pertanto l’addomesticamento della natura e l’addomesticamento dell’uomo.
Al contrario di quel che pensa Rosenblum, l’arte e la letteratura protestanti non traggono dalla natura una «umanizzazione del divino», bensì il divino perde così il più sottile tratto personificante e perfino il panteismo dimentica l’aspetto provvidenziale, riducendosi tutto a meccanismo cieco e oppressivo. «Se ci si allontana da Parigi», comunque, si scopre che questa ricerca religiosa nel naturale, volgendo le spalle all’Art pour l’art, prosegue il suo cammino eretico per l’intero secolo diciannovesimo. «L’opera di Vincent van Gogh – sostiene l’autore del libro – è il migliore esempio di questa sopravvivenza, o forse rinascita, nel diciannovesimo secolo postimpressionista, delle questioni sollevate dai romantici del Nord». Riesce l’accostamento tra i paesaggi desolanti con rovine gotiche, talvolta con figurine angosciose, di certi dipinti di van Gogh, e i paesaggi di Friedrich. Così come è accattivante il confronto tra alcuni ritratti di van Gogh e quelli di Runge: in ambedue le opere i bambini appaiono impressionanti «per dimensione e vitalità», «costringendo la madre a un ruolo subordinato, quello dell’albero vecchio e debole…». Segno ancora più eloquente di una tendenza spirituale dell’epoca, va detto che nulla ci autorizza a sospettare che il pittore olandese abbia mai visto anche una sola opera dei due artisti tedeschi.
Scendendo verso altri epigoni del pittore di Greifswald, l’autore dedica un capitolo a Munch. Il norvegese voleva dipingere immagini che costringessero gli uomini «a togliersi il cappello come se fossero in chiesa». Compose opere che piuttosto provocavano la compassione come in un ospedale psichiatrico. Anche nei quadri di Munch ci sono figure solitarie in tensione con la natura. In essi la contrapposizione degli umani-lillipuziani alla potenza della natura diviene contrasto violento tra le figure umane (femminili spesso) e la terrificante (agli occhi del pittore) potenza sessuale. Un magnetismo che si diffonde, un erotismo che però sembra voler fare a meno dei sensi e si trasforma in religione dei fantasmi. Paesaggi psicologici che denunciano delle patologie; geografie dell’anima inquieta. Questo il moderno che si distacca dalla religione di Roma. Ecco allora un trionfo della morte affidato a scarabocchi ossessivi, a caricature, a mostriciattoli, a visioni di adolescenti truci che riempiono i quaderni di segni sinistri, allusioni suicidarie, di morte e sesso sognati, di curiosità insoddisfatte per i misteri della vita.
C’era chi si immedesimava negli alberi e chi negli animali. Franz Marc fu uno di questi. I temi perciò restavano romantici, magari aggrovigliandosi maggiormente, ma le forme si immiserivano. I paesaggi non presentavano soltanto nero e morte, bensì puro niente. Lo aveva preannunciato Basilius von Ramdohr, politico conservatore, diplomatico prussiano, critico d’arte che aveva visto Napoli e Roma, vivendo nelle città mediterranee e studiando l’arte di quaggiù, quando partì all’attacco di Friedrich, in particolare della sua Croce in montagna e, in base a quest’opera, profetizzò sconvolto: «la sfortunata cova del periodo presente è l’orrendo presagio di una barbarie che velocemente si avvicina». E in un articolo per la «Zeitung für die elegante Welt» del gennaio 1809: «Quel misticismo che ora si insinua ovunque e che, dall’arte come dalla scienza,dalla filosofia come dalla religione, esala verso di noi come un fumo narcotizzante! Quel misticismo che spaccia simboli e fantasie per immagini pittoriche e poetiche, che vorrebbe scambiare l’antichità; classica con l’intaglio gotico, con rigide calcografie e con leggende! Quel misticismo che, al posto dei concetti vende giochi di parole…».
Strada facendo infatti – ma questo Rosenblum non lo dice –, man mano che i quadri diventavano verbosi, predicatorî, oracolari e sintomatici dell’estremo male esistenziale, le immagini si impoverivano. Ridotte all’essenziale nei romantici e post-romantici di fine Ottocento, sfiorando la naïveté figurativa dell’infanzia, finiranno per rinnegare se stesse, per diventare iconoclaste, segni iconoclasti; si bloccheranno (e baloccheranno) in una contraddizione mortale che è quella presente. Rosenblum invece vi cerca ancora una fertile discendenza.
Da parte di certi pittori, insomma, c’era il rifiuto del loro ruolo di decoratori del mondo, che non era cosa di poco conto: completare l’opera della creazione, rendere più evidente la bellezza dell’universo, un affare divino; considerando questa attività millenaria come un’opera servile, si inventarono una nuova missione, presero a vantarsi di scoprire i misteri, di rivelare le cose nascoste (o quantomeno di costruire un clima misterioso e segreto senza risolvere alcunché), di promuovere riti di incantesimo, di suscitare magie facili, di agitare simboli scontati. C’era dunque, e non solo in Munch, «l’ambizione romantica di ideare nuovi sistemi iconografici». Mancava loro però l’Iconologia di Ripa e mancava un qualche personaggio che, alla sua altezza, sapesse redigere un codice della simbologia moderna. Più che altro, sembravano rifarsi alla teosofia di moda nei salotti mediocri.
Invece di meditare sui tormenti umani del Dio incarnato o di sbizzarrirsi sui piaceri del Cielo, dando una direzione alla mistica anche estrema, un luogo figurato, un recinto concettuale, una silhouette individuale, una linea di contorno che permetta di distinguere, ci si immerge in una pittura di allusioni vaghe, di percezioni incerte, di pretese somme, di emotività senza alcun controllo. È la forma a essere sacrificata insieme ai sensi repressi. Giardini senza profumi, alberi carichi di simboli; non spira da queste parti la brezza sensuale.
Le opere di tali artisti dimostrano come la più profonda laicizzazione dell’arte religiosa sia avvenuta per opera dei romantici, proprio distruggendo l’antica separazione tra arte sacra e profana, sacralizzandola tutta in chiave che potremmo definire gnostica. Sbagliava il pur acuto Florenskij quando, con i sospetti russo-ortodossi per la tecnica della prospettiva che credevano d’ordine satanico, accusava il Rinascimento italiano di aver annientato l’arte sacra: era proprio quella armonia tra il cielo e la terra, tra lo spirito e la carne, che rispecchiava al meglio il cristianesimo romano e metteva in fuga le visioni eretiche. Quella eccelsa pittura latina era la gloria cattolica. E i più duri colpi le furono inferti dal romanticismo tedesco.
L’onnipotenza della natura diverrà una forza apocalittica che tutto distrugge: una natura sottratta alla lezione biblica e una morte sottratta al conforto cristiano si trasformano in un’unica, mostruosa, potenza. Una forza catastrofica. Talvolta anche la guerra parteciperà di questa energia annientatrice. La visione degli artisti volontari nel primo conflitto mondiale può così ricordare il sublime della fine Settecento, «un sermone religioso volto a ispirare terrore», dice Rosenblum. Questa la religione che annienta il creato.
Una religione che rifiuta il mondo sensibile e si libra nell’astratto è però ancora più spaventevole. Bisogna proprio averci fatto l’abitudine per non essere più sconvolti da certi titoli e affermazioni che costellano il libro: distruzione apocalittica, fine del mondo, mondo subumano, ritorno al primitivo, all’arcaico…
Rosenblum ricorda che soltanto perché orientati all’Art pour l’art di parigina origine possiamo considerare l’astrattismo come mosso da impulsi di carattere estetico. Piuttosto un terremoto spirituale, misticismo senza religione, cosmogonie personali, rivelazioni prêt-à-porter. I sogni romantici, ancora dentro una forma, divengono adesso informi conati di assoluto. Se si vuole capire quant’è lungo il cammino e triste la parabola: Runge si ispirava alle teorie di Goethe, Mondrian a quelle miserabili di Rudolf Steiner.
Gli eredi moderni del romanticismo del Nord abbandonavano il mondo secolare per manifestare – si dice – un sentimento religioso. Ma questo non era più, appunto, il sentimento cristiano che crede nel mondo creato da Dio e ne gioisce, bensì un’impressione dualistica che separa il corpo dall’anima, che proclama la propria estraneità al cosmo, che denigra la realtà materiale a frutto di un cattivo demiurgo, da respingere e da fuggire.
L’iconoclastia protestante costrinse quasi gli artisti romantici a una nuova iconografia. I loro seguaci, dal protestantesimo ben più tiepido o del tutto assopito, privi anche della cultura dei maestri, ripiegarono sulla negazione dell’immagine. Perché non considerare allora la Cappella di Rothko soltanto come una parodia delle concezioni di Runge? Sì, l’angoscia potrebbe essere comune ma la forma da darle si è persa per strada.
Etichette:
Le immagini del romanticismo del Nord
Iscriviti a:
Post (Atom)