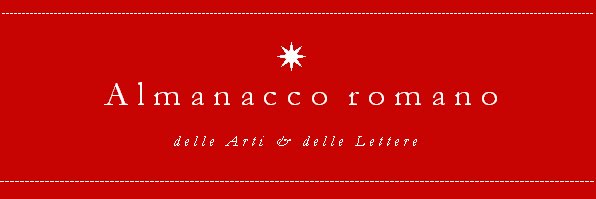RIFLESSIONI IN FORMA DI APPUNTI INTORNO ALLA MOSTRA FORLIVESE DEL SOMMO ARTISTA VENETO. LA «CARNE VIVA» SUB SPECIE AETERNITATIS E LA CONSOLAZIONE DELLA BELLEZZA NELLA ATTUALE VALLE DI LACRIME.
Una gazzetta romana non può non spingersi ai confini del territorio pontificio, nelle terre di Romagna appunto, per render testimonianza di una mostra di Antonio Canova, l’ultimo sovrano della Roma capitale delle arti. A Forlì, nel Museo San Domenico, che perennemente ospita una sua Ebe, danzatrice dell’eterno nell’atto di offrire una coppa di liquore salvifico, fino al 21 giugno si mette in mostra «Canova: l’ideale classico tra scultura e pittura», per la cura di Fernando Mazzocca. Sempre un buon pretesto per riflettere sulla bellezza alle soglie della modernità, anche se gran parte delle opere proviene da Roma stessa, da musei italiani noti e dall’Ermitage di San Pietroburgo prodigo, per necessità economiche, di copiosi prestiti a mezzo mondo. Già visto, dunque, ma fa piacere rivedere, benché fuori dalle rotte abituali.
.
.
Perché Canova fu odiato nel Novecento?.
Mario Praz spiegò sinteticamente, in un libro fondamentale, Gusto neoclassico, quello che era accaduto a Canova dopo la fine del suo regno, riportando le invettive e i frizzi e lazzi degli storici, specialmente italiani, del secolo scorso: credevano nell’immediatezza dell’arte, giù giù fino alla ‘presa diretta’ della imbarazzante action panting e dripping di svolazzo, sospettavano a dir poco della mediazione intellettuale (l’opera dei sospettati si era del resto svolta negli ultimi bagliori del diffidentissimo illuminismo), del disprezzo dell’istinto (repressione avrebbe detto la psicoanalisi, con visione meccanicistica, di quel gesto delicato che è la sublimazione), della mancanza di fretta nel rappresentare su tela e nel marmo quanto si era visto, l’opposto dell’ansioso pittore impressionista e del mistico espressionista. «In base a questo pregiudizio [romantico] è accademia quella che si ispira ai modelli classici, ma non quella che si ispira a quei modelli che, anziché ai Musei Vaticani, son conservati al Museo dell’Uomo a Parigi; si fa dell’accademia copiando l’Apollo del Belvedere e il Laocoonte, ma si farebbe dell’arte pura, primigenia, derivando motivi e tecniche da quelle pitture preistoriche sui ciottoli… ». E il critico anti-neoclassico «fa il cipiglio a David e a Canova, sorride a Mirò e a Klee: perché gli pare che colui che copia dai Musei Vaticani uccida ‘lo slancio meraviglioso verso l’ignoto della fantasia’, mentre colui che copia dalle grotte di Altamira e di Lascaux ‘realizzi appieno l’autonomia dell’arte’». Una spiegazione magistrale di questi pregiudizi si trova nell’introduzione a Romanticismo politico di Carl Schmitt e risale al 1919. Oggi non ci si divide più neppure su questi princìpi, semplicemente si sono introiettate simili credenze per cui si accorre, per feticismo culturale, a ogni svelamento di Caravaggio e, per la medesima ragione, si omaggia naturalmente anche l’artista neoclassico così come l’imbrattatore postmoderno, secondo la effemeride dominante, ma alla fine si resta imbambolati di fronte alla bellezza, all’armonia senza ammiccamenti, ripiegando magari in cuor proprio sui disegni e i bozzetti, secondo quanto dicevano con più malizia i competenti storici novecenteschi e Praz riusciva a prevedere: «l’immediatezza, feticcio romantico, di cui sono sottospecie l’impressionismo e la scrittura automatica, una volta assunta a supremo criterio di giudizio, ha fatto sì che non solo vengano condannate intere epoche artistiche come il neoclassicismo, ma che dei grandi artisti neoclassici, si salvino solo gli schizzi, gli abbozzi, gli spunti come quelli che conservano qualche scintilla di quel fuoco divino che poi la rielaborazione smorzerebbe».(Gusto neoclassico, Milano, 1974, pp.129-130). Un bel riassunto della critica moderna, dei suoi vezzi, debolezze, miserie.
.
Amato da Stendhal («io pongo in prima linea, tra gli uomini che ho conosciuto, Napoleone, Canova e Byron») e da Goethe, dai sovrani del mondo e dai popoli, sprezzato da critici novecenteschi. «Con i saturnali della libertà in arte, il mito di Canova disparve», scriveva monsignor Giovanni Fallani in una sua onesta monografia del 1949. Si dà per scontata la libertà assoluta dell’artista, al limite e oltre il limite del capriccio, ma si prova orrore, quantomeno scandalo, per un genio che sembra scolpire fuori del tempo. D’altronde, fare indossare agli dèi e agli eroi le vesti moderne è una cacofonia (anche Marx era convinto – forse per influenza di Heine – che la divinità classica a contatto con il mondo borghese scadesse in farsa), come svilire il linguaggio della tragedia con frasi corrive (è la forma tragica che in tal caso viene a mancare). Tali violazioni delle regole dei generi, invalse nel tempo nostro, sogliono presentarsi come eccentriche quando son solo il segno di una sordità alle cadenze poetiche. Zeitlos per Canova significava una fede robusta nell’eterno. Era già l’epoca in cui Marat sfidava Apollo: «Marat peut désormais défier l’Apollon, la Mort vient de le baiser de ses lèvres amoureuses, et il repose dans le calme de sa métamorphose» (Baudelaire, Le Musée classique du Bazar Bonne-Nouvelle sul celebre quadro di David). Canova si accostò alla storia mantenendo fede in Apollo, e si accostò ai tiranni, a Napoleone in specie, da pari grado: ne offrì perciò ritratti umani molto umani. Così anche i sovrani, i personaggi della storia, non sono incensati né temuti alla maniera di Goya, visti piuttosto con la saggezza morale di Manzoni. Reazionario, si dice, «nostalgico di un umanesimo cristiano».
Amato da Stendhal («io pongo in prima linea, tra gli uomini che ho conosciuto, Napoleone, Canova e Byron») e da Goethe, dai sovrani del mondo e dai popoli, sprezzato da critici novecenteschi. «Con i saturnali della libertà in arte, il mito di Canova disparve», scriveva monsignor Giovanni Fallani in una sua onesta monografia del 1949. Si dà per scontata la libertà assoluta dell’artista, al limite e oltre il limite del capriccio, ma si prova orrore, quantomeno scandalo, per un genio che sembra scolpire fuori del tempo. D’altronde, fare indossare agli dèi e agli eroi le vesti moderne è una cacofonia (anche Marx era convinto – forse per influenza di Heine – che la divinità classica a contatto con il mondo borghese scadesse in farsa), come svilire il linguaggio della tragedia con frasi corrive (è la forma tragica che in tal caso viene a mancare). Tali violazioni delle regole dei generi, invalse nel tempo nostro, sogliono presentarsi come eccentriche quando son solo il segno di una sordità alle cadenze poetiche. Zeitlos per Canova significava una fede robusta nell’eterno. Era già l’epoca in cui Marat sfidava Apollo: «Marat peut désormais défier l’Apollon, la Mort vient de le baiser de ses lèvres amoureuses, et il repose dans le calme de sa métamorphose» (Baudelaire, Le Musée classique du Bazar Bonne-Nouvelle sul celebre quadro di David). Canova si accostò alla storia mantenendo fede in Apollo, e si accostò ai tiranni, a Napoleone in specie, da pari grado: ne offrì perciò ritratti umani molto umani. Così anche i sovrani, i personaggi della storia, non sono incensati né temuti alla maniera di Goya, visti piuttosto con la saggezza morale di Manzoni. Reazionario, si dice, «nostalgico di un umanesimo cristiano».
.
Invece che artista di cadaveriche figure – come spesso ripeterono i critici moderni e a lui ostili –, si veda Canova in compagnia di Correggio – secondo l’intuizione di David – e di Petrarca (talvolta evocato dai più consapevoli), di Pergolesi per la soavità, e forse anche di Leopardi, per l’acutezza di pensiero. Leopardi si lamentò della propria sfortuna quando, riuscito finalmente ad arrivare a Roma, «il gran Canova, al quale principalmente era volto il mio desiderio, col quale sperava di conversare intimamente e di stringere vera e durevole amicizia […] se n’è morto». E la Roma capitale mondiale delle arti poco dopo se ne morì a sua volta, anche per la mancanza di un indomito artista e protettore di tutte le arti, patron dei giovani, finanziatore di grandi imprese, straordinario ambasciatore dei papi, maestro di umanità.
Invece che artista di cadaveriche figure – come spesso ripeterono i critici moderni e a lui ostili –, si veda Canova in compagnia di Correggio – secondo l’intuizione di David – e di Petrarca (talvolta evocato dai più consapevoli), di Pergolesi per la soavità, e forse anche di Leopardi, per l’acutezza di pensiero. Leopardi si lamentò della propria sfortuna quando, riuscito finalmente ad arrivare a Roma, «il gran Canova, al quale principalmente era volto il mio desiderio, col quale sperava di conversare intimamente e di stringere vera e durevole amicizia […] se n’è morto». E la Roma capitale mondiale delle arti poco dopo se ne morì a sua volta, anche per la mancanza di un indomito artista e protettore di tutte le arti, patron dei giovani, finanziatore di grandi imprese, straordinario ambasciatore dei papi, maestro di umanità.
.
«Canova regalò al mondo la consolazione della Bellezza» – dice Antonio Paolucci che presiede il comitato scientifico della mostra e non teme di usare le maiuscole quando occorrono. «I grandi della terra lo capirono e gli dimostrarono immensa gratitudine». I moderni invece non capirono più niente, come in molti altri campi impalpabili, e si comportarono da ingrati. Del resto, l’artista della cultura della Restaurazione non potevano certo spacciarlo per rivoluzionario, il suo linguaggio anzi, commentavano sprezzanti i posteri, si era richiamato alla tradizione, igitur andava divelto dai grandi della storia dell’arte, dove i guardiani, burocrati della politica, controllano il tasso di giacobinismo e di innovazione, niente sapendo, e quindi niente apprezzando, delle squisitezze che le belle arti riescono a procurare all’animo e al corpo.
.
«Canova regalò al mondo la consolazione della Bellezza» – dice Antonio Paolucci che presiede il comitato scientifico della mostra e non teme di usare le maiuscole quando occorrono. «I grandi della terra lo capirono e gli dimostrarono immensa gratitudine». I moderni invece non capirono più niente, come in molti altri campi impalpabili, e si comportarono da ingrati. Del resto, l’artista della cultura della Restaurazione non potevano certo spacciarlo per rivoluzionario, il suo linguaggio anzi, commentavano sprezzanti i posteri, si era richiamato alla tradizione, igitur andava divelto dai grandi della storia dell’arte, dove i guardiani, burocrati della politica, controllano il tasso di giacobinismo e di innovazione, niente sapendo, e quindi niente apprezzando, delle squisitezze che le belle arti riescono a procurare all’animo e al corpo.
.
La luce platonica e quella elettrica.
Comunque, l’esistenziale che si cercava nel non finito – come prevedeva Praz – , nell’accennato dei bozzetti, è tutto un effetto della luce, sosteneva Gian Lorenzo Mellini, che portava al suo mulino anche queste passioni popolari per l’aspetto meno classicheggiante di Canova. Mellini non è un esperto di cose canoviane, un accademico, un curatore di mostre, piuttosto un suo amico postumo, un possessore di sculture e pitture del Possagnese, ricevute in dono o acquistate con avvedutezza e occhio scaltro, lui nobile diseredato, autore di anacronistici libri di erudizione e preziosità, che si effigiava come un morto che parla; un Praz oscuro della nostra epoca, che non potette neppure trovare un rifugio nell’università immiserita ulteriormente, fissato ugualmente con l’arte che chiamiamo neoclassica, dove elegante ragionevolezza e forma armonica si accordano in una specie di viaggio al Parnaso. Ebbene, Mellini scorse il pittoricismo di marca veneta pure nelle statue, anzi soprattutto nel bianco dei marmi e dei gessi, con un effetto fosforico. Chiarore che risplenderebbe, per quanto diafano, in negativo, nell’oscuro sudario che avvolge il mondo.
.
Noi vediamo la lucentezza prodotta da riflettori potentissimi che tendono ad annullare la pittoricità delle statue – la luce elettrica facendo sparire ogni differenza – perciò possiamo soltanto immaginare il caldo bagliore delle fiaccole con cui – alla maniera introdotta a Roma da Winckelmann – ci si accostava alla scultura nei musei, aperti di notte, onde fuoriuscivano colori e ombre. In tal modo apparve la «morbidissima carne». Luce radente di candela chiedeva d’altronde nelle sue lettere lo stesso autore per scovare le delicatezze dei marmi, i chiaroscuri.
.
Noi vediamo la lucentezza prodotta da riflettori potentissimi che tendono ad annullare la pittoricità delle statue – la luce elettrica facendo sparire ogni differenza – perciò possiamo soltanto immaginare il caldo bagliore delle fiaccole con cui – alla maniera introdotta a Roma da Winckelmann – ci si accostava alla scultura nei musei, aperti di notte, onde fuoriuscivano colori e ombre. In tal modo apparve la «morbidissima carne». Luce radente di candela chiedeva d’altronde nelle sue lettere lo stesso autore per scovare le delicatezze dei marmi, i chiaroscuri.
.
Sempre seguendo la lezione di Mellini, potremmo dire che Canova velava l’Illuminismo per tirarne fuori lievissime ombre.
.
.
Sarebbe piaciuto a questo ‘secondo Praz’ il peso dato nella mostra di Forlì alla pittura dei contemporanei del sommo scultore, la presenza dei due quadri dello squisito Gaspare Landi (il terzo è un ritratto del festeggiato) che dialogano con le statue. Si sarebbe magari rammaricato della scarsità di quadri canoviani, dove rinvenire la «pittura paratattica», veneta nel colore, addirittura neotizianesca, «ma mengsiano sembrerebbe il progetto: un ritorno alla pittura greca almeno come la si poteva ricostruire allo stato dei rinvenimenti archeologici». Ci si può accontentare di una occhiata ai disegni, «piacevoli, pur non essendo dotato di una buona mano», dove comunque vedere quella «velatura lunare», quella «grisaglia ossianica», definizioni che la scrittura melliniana escogitava per Canova. E rilevare facilmente l’influenza di Füssli, talvolta di William Blake.
.
.
«Canova scultore notturnale, cioè neoplatonico», afferma lo studioso, e per indicare questo notturno disseppellisce le Notti di Alessandro Verri (v. «Almanacco», I morti viventi in giro per Roma), di Novalis, di Leopardi, perfino «la lirica musicalità nella Norma belliniana». Il doge Paolo Ranier aveva tradotto Platone in veneziano, Canova – che di quel doge ci ha lasciato un ritratto in terracotta – fece più o meno la medesima cosa: rese il platonismo nel delizioso pittoricismo veneto.
.
.
«La culla del Canova è la Venezia del settecento – sosteneva Ugo Ojetti nel celebre discorso commemorativo del centenario, 1922, oggi finito nell’oblio – ; e questa Venezia, da Benedetto Marcello a Giambattista Tiepolo, fu allora, è anche oggi, il segreto di quella tenerezza malinconica, di quella patetica sensualità, di questo amoroso abbandono, di questa grazia flessuosa e languida che ci incanta nelle opere di lui». È la Venezia ricercata da Hofmannsthal nel suo Andreas oder die Vereinigten. Se fosse stato terminato quel romanzo chiave del Novecento che si specchia nel Settecento, se la desiata ricongiunzione fosse avvenuta, si sarebbe, chissà, arricchito della luce di Canova.
.
.
Ma il soffio molle del Settecento, non finì incagliato nella rocaille, negli eterni manierismi rococò di marca francese, e neppure nella Venezia della sottomissione a Vienna, nella geografia frammentaria del triangolo della décadence; sorretta dalla forte architettura romana, la grazia canoviana fu linguaggio nuovo. Terzo in senso cronologico dell’eccelsa triade di veneti, Palladio e Piranesi prima di lui, dedicarono la loro arte a Roma e da questa ricevettero le stigmate universali che li resero figure straordinarie nella storia dell’arte occidentale.
.
.
La società neoclassica fu addolcita da quell’italico riso, «senza il quale niuna cosa è bella» si potrebbe dire citando Vincenzo Monti, non dall’ironia violenta oggi in voga, non l’onnivoro sarcasmo. Per intravederla, si porti con sé, Baedeker del viaggio a Forlì, L’Antichità come futuro, silloge delle teorie estetiche del neoclassicismo raccolte con la consueta amabilità di altri tempi da Rosario Assunto, ristampata nel terzo millennio in un quasi tascabile (Medusa edizioni).
.
.
Nel calice di Ebe.
Splendette il Possagnese per l’arte funeraria in un’epoca che concepiva la morte in maniera diversa dal passato, dopo secoli di pensiero cristiano. Suoi capolavori furono le tombe pontificie, regali, della nobiltà di sangue e di arte, le steli per gli amici. Canova sembra ridare il senso della sopravvivenza tenendo conto di quanto era accaduto, cercando dunque una forma nuova. Del moderno senso della morte, dei dubbi spaventosi che si aprivano sul dopo, della ricerca di forme diverse e appena accennate di immortalità aveva parlato Chateaubriand. Non sarà un caso allora che l’Ebe che versa l’ambrosia agli dèi – bevanda che dà eternità a chi la beva, eucaristia pagana e come tutte le cose pagane riservata a una élite – ricorra corale nei quadri che a Forlì fanno corona alle due raffigurazione canoviane della Coppiera dell’Olimpo, segno di una devozione vagamente gnostica.
.
.
Lessing, che riprendeva da Bellori, decretava che la scultura dovesse rappresentare la stabilità mentre la pittura raffigurare il fugace. In base a tale assunto, la Ebe di San Pietroburgo, che spiccava il volo dalle nubi spugnose, scolpite in marmo ruvido, risultava troppo pittorica. I tedeschi inclinavano alle gerarchie anche nell’arte, Winckelmann paventava il caos estetico e fissava delle regole, Baudelaire allora non poteva non trovare noiosa la scultura. Nel frattempo, Friedrich Schlegel aveva aggiunto un’altra, importante, definizione (e suddivisione): la scultura appartiene all’arte classica; la pittura a quella cristiana. E nacque così, si potrebbe dire, il Romanticismo. L’artista veneto-romano riassumeva il mondo classico e quello cristiano, la cultura cattolica li teneva insieme, non aveva davvero bisogno degli entusiasmi recenti dei romantici.
.
.
Età dell’oro il passato, epoca critica il presente. Così i neoclassici, soprattutto di scuola winckelmanniana. Perciò la soffusa melanconia per questo voltarsi indietro di novelli Orfei che sanno che la loro amata Euridice è ormai inafferrabile. Lo stesso Winckelmann era consapevole della distanza che separava la sua epoca dal classico. Un rapporto immaginario, letterario, con l’antico. Comincia così la coscienza delle epoche di decadenza. Epigoni di una storia aurea. Per cui, forse, neppure nel cattolico Canova si percepisce la pienezza del presente. «L’attualità inattuale» della ragione rispetto al presente.
.
.
L’eros neocattolico contrapposto a quello dei neopagani. Mentre il teismo dei Lumi già scavava la fossa della disperazione dove sarebbe precipitata l’umanità atea (sul finire del Seicento, Lorenzo Magalotti, nelle splendenti Lettere familiari, aveva messo in guardia i teisti che non credevano nella resurrezione della carne parlando del loro «temperamento stravolto, austero, fisso, insensibile a’ piaceri…»), dunque mentre sulla scia di Diderot si temeva il giudizio dei posteri piuttosto che quello divino, Canova dipingeva e scolpiva il trionfo della fede sulle false dottrine.
.
.
Il colosso cattolico
.
L’ideologia giacobina e quella dei suoi eredi magnificarono la presenza nelle loro file di letterati, artisti e teatranti che avrebbero ammonito i posteri sulla superiorità dell’ideologia rivoluzionaria, della virtù egualitaria; il cattolicesimo, tant’è l’abitudine, quasi non fece più caso al suo colto e divino apologeta, che significativamente chiude l’eccelsa schiera dei massimi artisti italici, dopo di loro, se non il diluvio, resistono delle schegge di quella tradizione, poi subentra l’eclisse della cultura cattolica e dell’arte senza aggettivi (da riflettere, peraltro, su questa coincidenza). Sull’altro fronte, perfino l’iconografia massonica protestante e liberale era sembrata ricorrere alle soluzioni canoviane, soprattutto al suo misterioso colosso mai realizzato.
.
.
Andò così: il Possagnese aveva scolpito di propria mano cinquantatre statue, dodici gruppi, quattordici cenotafi, otto grandi monumenti, sei colossi, due gruppi colossali, cinquantaquattro busti, era l’artista più celebre al mondo, quando dopo la sconfitta delle idee e degli eserciti francesi, con il ritorno del papa al Quirinale – che era stato preparato come reggia per la vecchiaia del Còrso («L’umana alterigia che stoltamente pretese di eguagliarsi all’Altissimo, è stata umiliata…», dirà seccamente Pio VII riprendendo possesso della sua dimora) –, volle celebrare la restaurazione del pontificato romano con un segno che sfidasse i secoli. Concepì una statua alta otto metri, un colosso grande come un palazzo, che personificava la Religione cattolica, da collocare nella basilica di San Pietro. La Catholica vestiva esplicitamente abiti ebraici, anzi quelli del sommo sacerdote, con lo strano copricapo che si è visto tantissime volte indossato dal celebrante che appare nei quadri del matrimonio di Maria o della circoncisione di Gesù. Si appoggiava a una stele, con caratteri ebraici e con un medaglione che raffigurava Pio VII ma che lo stesso papa, destinatario del dono, consigliò di modificare con l’immagine di Pietro e Paolo. A Forlì è esposto il modellino in gesso della primitiva versione, senza la raggiera intorno al volto, e di fronte ce ne è uno in terracotta della Fede che compare sulla tomba di Clemente XIV a San Pietro, una delle opere degli inizi, che lo innalzò tra i massimi che si erano esibiti in quel tempio. Fin dalla giovinezza, quindi, Canova si era dedicato a celebrare nel marmo la fede cattolica, e fin da allora la donna allegorica indossava abiti ebraici (il Novus Israel?), anche se la raggiera dietro il volto ricordava piuttosto il copricapo delle contadine lombarde, della Lucia manzoniana. Peccato che in quella stanza della mostra forlivese non ci sia testimonianza alcuna di un dipinto canoviano, Il trionfo della fede, dove una donna irrompe su un carro dorato, i raggi dietro il capo, il braccio proteso verso lo spettatore, con in mano l’eucaristia. Le diverse personificazione dovevano confluire nell’opera matura, nel colosso, però i canonici di San Pietro respinsero il dono con la scusa che una statua tanto imponente avrebbe potuto sfondare il pavimento della basilica vaticana. Lo stesso Valadier, che doveva preparare una base in bronzo, era preoccupato del peso. Canova propose allora una sede diversa, il Pantheon o la chiesa michelangiolesca di Santa Maria degli Angeli: niente, il dono fu rinviato al mittente. Probabilmente, quel che turbava era un’arte così apologetica. Davanti alla modernità, pure preti e monsignori, benché usciti vincitori da una guerra, cominciano a temere il ‘trionfalismo’, ovvero sembrano sempre scusarsi della abbagliante luce cattolica
.
.
Deluso Canova, modificò la statua per ornare, in altre dimensioni, la tomba di una dama inglese. Ma dovette cambiare personificazione, cancellare i riferimenti ebraici, velarla severamente: ora la religione diventava genericamente cristiana, più mestamente protestante. Ma quando venne creato l’ultimo e gigantesco simbolo dell’Occidente, la Statua della Libertà ancorata nel porto di New York, Bartholdi si ispirò proprio alla personificazione canoviana della fede cattolica, sicché le tolse l’ostia eucaristica e la sostituì con la fiaccola che sedurrà il mondo moderno.
..
Il neoclassicismo sottratto a Kant.
Ma l’eros cattolico non basta dedurlo soltanto dai temi svolti dall’artista. Sottili storici dell’arte che professavano il laicismo pur innamorati di Canova provarono a manovrarlo con categorie kantiane. C’è allora da meditare su uno scritto quasi segreto, privo di ogni minima fama – e sul web, che concede un po’ di notorietà a porci e cani, il nome dell’autore manca del tutto – , uscito un quarto di secolo fa su una rivista elegante, «Labyrinthos» (1983, nn. 2/3), dal titolo Morte e trasfigurazione del Neoclassicismo. L’autore, ormai scomparso, era Sergio Ruffino, che coniugava la storia dell’arte alla filosofia. Il saggio argomentava sull’eros settecentesco e partiva da Hans Sedlmayr, l’ultimo della cosiddetta Scuola di Vienna. Il quale tornò più volte sulla distinzione, decisiva in questo contesto, tra barocco e rococò (in specie nella voce «Rococò» sull’Enciclopedia Universale dell’Arte). Se nel primo stile la Gloria divina raggiungeva l’uomo mediante l’arte, nel secondo la glorietta umana, il piacere senza metafisica, provava a fare a meno di Dio, diventava l’arte del libertinismo. Nel barocco la vittoria dei «sensi superiori», nel rococò l’eros moderno. Boucher e Fragonard ce ne offrirono esempi decisivi e superbamente lascivi. Ma chi diede loro la forza di rovesciare la Grazia cristiana nella ‘graziosità’ civettuola? La risposta potrebbe essere: la prima, grande, crisi del pensiero occidentale, «la potenza filosofica del libertinismo». Quel libertinismo che «scindendo la politica dalla morale e dalla religione (entrambe erano radicalmente svalutate) propugnava l’assoluta autonomia del politico, respingendo ogni limite di diritto naturale e di legge divina». L’assolutismo libertino cambia la faccia anche della morte, che perde il sapore cristiano. Contro questa ideologia amorale e scettica si erge l’illuminismo, morale e razionalista. Dall’altra parte, c’è il cristianesimo ferito, e Sedlmayr ricorda il Sacro Cuore di Pompeo Batoni come un contrattacco cattolico al rococò. Ruffino allora, forte di questa tripartizione, applica lo schieramento in campo alla nascita del neoclassico. Da una parte il rococò che rifiuta morale e religione, dall’altra l’illuminismo con la morale e la religione di Roma con il trascendente. Ebbene illuminismo e cattolicesimo saranno le due componenti del neoclassicismo, che appunto avrà due anime, David e Canova. Nel primo la morale kantiana, il diritto di uccidere rivendicato da Marat, proprio perché egli conosce il suo destino di morte (appena una anticipazione di quelle che nei Demoni di Dostoevskij saranno le degenerazioni rivoluzionarie, l’inflazione degli assassini). «Il classicismo di Canova – scrive Ruffino – presuppone tutto il razionalismo illuministico, anzi è incomprensibile senza quella rivoluzione razionalista dell’architettura». Ma se David è un rivoluzionario, con il suo risvolto di eroismo morale, con il sublime neoclassico, «severo e a volte arcigno» direbbe Assunto – che raccoglieva tanti filoni austeri: dal classicismo seicentesco romano all’estetica di Port Royal, dal pietismo di Winckelmann al gusto politico dei giacobini –, Canova sta dalla parte di de Maistre anche se forse non ha mai letto il savoiardo. «L’intera sua opera può essere compresa (e l’averlo dimenticato fu la cagione di tanti sviamenti) se lo si riporta a quel vasto fenomeno culturale che è quasi il contraltare dell’illuminismo […] e che sarebbe giusto indicare come neoccasionalismo». Il ritorno a una visione settecentesca che spiega tutta la realtà. Se lo schema presenta David/Robespierre, va loro contrapposta la coppia Canova/De Maistre. Ecco perché Canova suscita odio secolare. In luogo del sentimento, infatti, egli colloca il cristianesimo come verità e rivelazione. Di fronte a queste scandalose immagini, i laici che voglion recuperare il Possagnese fanno ricorso a Kant. Gli apologeti della non-forma estetica attuale, adesso ritrovano addirittura in lui l’antesignano del superamento della rappresentazione, parlano e straparlano di «cosa stessa sublimata». «In realtà Kant c’entra poco», replica Ruffino, Canova rifiuta nettamente il soggettivismo kantiano. Canova e David lottano contro il ‘grazioso’ settecentesco in nome di un’altisonante idealità. Il francese però è rivoluzionario e moralista, mentre il veneto non separa mai l’etica dalla religione. Intanto, contemporaneo dei due, Sade è l’epitome del gran finale dell’Europa libertina. «L’illuminismo della libertà si capovolge nella dittatura della libertà». Ma questo è un capitolo della Dialettica dell’Illuminismo. Dopo l’idealismo di David e di Canova si apre il teatro borghese, questioni di soldi. Jacob Burckhardt pensava a una personificazione dei dèmoni del crack in Borsa. Il ritorno al classico si trasformava nella parodia. Heine metteva in scena il suo Olimpo irridente, quello neoclassico era stato di volta in volta ateo o cattolico, ma sempre solenne. Ogni immagine di Canova aveva una valenza cristiana, anche Paolina, Paulette Bonaparte sposata in seconde nozze con il principe romano Camillo Borghese, antico lignaggio ancorché sensibile ai venti giacobini, sì anche i nudi, soprattutto le immagini dei nudi. «Esse sono cattoliche come era cattolico il suo autore; anzi, per trovare il cuore della faccenda, direi che non è possibile immaginare l’equilibrio cattolico tra grazia e natura, libertà e merito senza quei nudi; proprio perché quell’equilibrio si sposta ora un poco più in qua, ora un poco più in là, e annullare uno dei due poli significherebbe infrangerlo, spegnere per sempre il ‘lume naturale’, quella analogicità dell’essere, quella naturale partecipazione della natura alla grazia soprannaturale, che tanto piacque, un tempo, a San Tommaso…». Successivamente l’equilibrio si ruppe, il sarcasmo di Heine rimbombò nelle figure di Daumier, che non credeva più alle tavole morali di David e alla trascendenza canoviana. Conclude Ruffino: «nel regno delle immagini non possiamo registrare ormai se non la risplendente stupidità beata dell’impressionismo, festevolmente inconsapevole, e la breve stagione di quell’isola felice, lontana ormai le mille miglia da noi. Ciò che segue è la nostra storia».
.
La consapevolezza della fictio, il rifiuto dell’istintività, della naturalezza. L’acclamatissima grazia, che è scioltezza, rinascimentale sprezzatura, equilibrio, deve dunque essere ben diversa dal sensuale rococò, libertino e licenzioso, come dall’agudeza barocca, dall’insolito come valore, dallo stravagante. Canova ammirabile, dice Antonio Giordani, non si sa se più per l’ingegno o per la mano. Equilibrio riuscito cioè, là dove i moderni escono sempre sconfitti, sostituendo formule intellettualistiche alla mano, al talento che proprio non c’è. Il sublime si sposa insomma con la grazia, senza civetteria e senza angoscia protestante (ma che di riflesso fu anche, nel pieno della Riforma cattolica, propria del manierismo più teso, dei rimuginii di Torquato Tasso, del barocco più vertiginoso, dell’arte dunque della religione di Roma).
La consapevolezza della fictio, il rifiuto dell’istintività, della naturalezza. L’acclamatissima grazia, che è scioltezza, rinascimentale sprezzatura, equilibrio, deve dunque essere ben diversa dal sensuale rococò, libertino e licenzioso, come dall’agudeza barocca, dall’insolito come valore, dallo stravagante. Canova ammirabile, dice Antonio Giordani, non si sa se più per l’ingegno o per la mano. Equilibrio riuscito cioè, là dove i moderni escono sempre sconfitti, sostituendo formule intellettualistiche alla mano, al talento che proprio non c’è. Il sublime si sposa insomma con la grazia, senza civetteria e senza angoscia protestante (ma che di riflesso fu anche, nel pieno della Riforma cattolica, propria del manierismo più teso, dei rimuginii di Torquato Tasso, del barocco più vertiginoso, dell’arte dunque della religione di Roma).
.
Defensor Romae.
Defensor Romae.
Un gran berretto frigio era stato calcato dai giacobini in testa all’angelo che se ne sta sulla terrazza del castello romano che da lui prende il nome. Sfregio alla creatura divina che brandiva la spada dell’ira celeste. Intanto, lunghe file di convogli portavano via da Roma innumerevoli opere d’arte, dalla Trasfigurazione di Raffaello all’Apollo del Belvedere, al Laocoonte, ai Correggio, Guido Reni, Domenichino, nel più imponente saccheggio moderno, pari a quello dei barbari di Alarico (i lanzichenecchi consumarono sul posto): ma stavolta in nome della cultura progressista veniva depredata la città eterna dalle armate rivoluzionarie, a maggior gloria dello sciovinismo francese. Con eleganza e sapiente distacco il sovrano della terra saccheggiata, papa Pio VII, diceva delle opere rubate: «le vicende dei tempi ce le hanno involate» (così nel chirografo per tentare di salvare la migliore arte del mondo, commissionata dai romani pontefici e sottratta dai francesi che declassavano Roma a seconda capitale del loro impero assai effimero). E intanto si affrettava con alate parole a porre riparo alla drammatica situazione, ricorrendo proprio al fido Canova: «Sono state queste le riflessioni che dappresso all’illustre esempio, che la S. M. di Leone X diede nella persona del gran Raffaello da Urbino, ci hanno recentemente determinati ad eleggere l’incomparabile scultore Canova, emulo dei Fidia, e dei Prassitele, come quello lo fu degli Apelli e dei Zeusi, Ispettore generale di tutte le Belle Arti, e di tutto ciò che alle medesime appartiene».
.
.
Il canoviano Perseo prese allora, per volontà di papa Chiaramonti, il posto lasciato vuoto dall’Apollo del Belvedere, che i liberatori si erano portati a Parigi. Il cosiddetto neoclassico sostituì il classico doc sul medesimo podio, per ragioni politiche. Canova, inoltre, il Perseo consolatore, come fu perciò chiamato, acquistò a proprie spese la Collezione Giustiniani – che stava per essere venduta ai francesi e a perdersi Oltralpe – e la donò ai Musei Vaticani, la pupilla dei suoi occhi di artista generoso. Intervenne presso gli occupanti francesi per la liberazione dei giovani artisti spagnoli, che non si erano voluti piegare ai rivoluzionari, e per garantire la permanenza a Roma di quelli tedeschi e austriaci, che gli invasori volevano rimpatriare.
.
.
A Parigi, nei numerosi colloqui con Napoleone che esaltava la spada, Canova citava Machiavelli, secondo il quale la potenza di Roma era dovuta più alla religione di Numa che alle armi di Romolo. Il moderno dittatore georgiano che irrise le esigue truppe del papa non avrebbe mai capito. Sembra comunque da queste parole che l’artista veneto riprendesse i temi discussi dai fantasmi classici nelle già citate Notti romane dell’amico Alessandro Verri, dove si parlava della superpotenza pontificia che aveva portato il nome di Roma ben al di là dei confini imperiali. Sostenne quindi Canova nel dialogo con l’imperatore gli immani vantaggi che godettero le arti sotto la Chiesa cattolica.
.
.
Quando Napoleone cadde, Canova corse a Parigi in nome del papa, a recuperare valorosamente i capolavori nostri deportati laggiù. In molti teorizzavano il dato di fatto: ormai sono qui, stanno meglio che a Roma, nel cuore dell’Europa… «Scortato dalle truppe austriache e prussiane, Canova entrò nel Louvre e, con l’aiuto volontario di molti artisti stranieri residenti a Parigi, cominciò la difficile opera di identificazione, distacco e imballaggio». (Pinelli in Lo studio delle Arti e il genio dell’Europa, Nuova Alfa editoriale, 1989, p. 3). Le scolaresche e le comitive italiane, che in sì gran numero si recano annualmente al Louvre, dovrebbero pur sapere di quante lacrime grondi quella concentrazione di opere d’arte, di quanti capolavori rubati su e giù per la penisola meni ancor vanto.
.
Fu dopo questo trionfo politico, di salvatore dell’arte romana, che Canova si recò a Londra ad ammirare i marmi ateniesi, a confrontarsi con il genio greco cui tutto il mondo lo accostava.
.
Fu dopo questo trionfo politico, di salvatore dell’arte romana, che Canova si recò a Londra ad ammirare i marmi ateniesi, a confrontarsi con il genio greco cui tutto il mondo lo accostava.
.
Ma aveva visto il suo «amato Stato» talmente in crisi, tanto «in ruina», da esser tentato – come raccontò in una lettera a un amico – di andarsene in America e stabilirsi colà.
.
.
La forma eroica.
«Mentre tutto il mondo si affaccenda attorno ad altre mode, e imperversa un pullulare di impressionismo sentimentale, Beethoven ripensa la grande Forma, di cui nessuno si occupa più, per portarla, con un gesto che è davvero ciclopico, fino alle sue ultime possibilità vitali […]. Ecco perché il Rosen può scrivere che la decisione di Beethoven, di continuare con le forme più puramente classiche, fu eroica. Mentre intorno a lui si affaccendano la frivolezza operistica e salottiera e la benedicente sentimentalità romantica, Beethoven erige, allo stile classico morente il suo monumento, più duraturo del bronzo» (Piero Buscaroli, La casa di Beethoven e altri saggi beethoveniani). Non fu altrettanto eroica, ciclopica, la scelta di Canova, suo illustrissimo contemporaneo, che non si lasciò irretire dalla frivolezza salottiera che accompagnava la pace ‘viennese’, dal «pullulare di impressionismo sentimentale»? E trattandosi di arti figurative, non si limitò alla forma nobile, seppe unirla, mantenendosi in questo devoto alla italica tradizione, a quella fedeltà al reale che bandisce ogni astrattismo nella bella penisola. Ojetti affermava che i migliori nostri artisti, del Cinquecento come del primo Ottocento, assumevano «l’idealismo greco come un limite, non come uno scopo», ché la passione loro era «un rispetto pel vero, un amore pel vero, un’aderenza al vero […]. Noi restiamo uomini anche in arte». E Canova, a Londra, insegnava: «gli uomini sono stati composti di carne flessibile e non di bronzo». Con la tinta di minio sparsa sul marmo provò del resto a correggere il candore delle sculture, concepì diversi trattamenti della superficie con finalità mimetiche. C’è chi come Mellini addirittura declina Caravaggio-Canova, «curiosa coincidenza nel realismo», «un certo comune idealismo unito a carnalità, nel segno indubbio di Raffaello». A controprova, Berenson, nel suo saggio su Caravaggio, con molto gusto del paradosso (e in non troppa larvata polemica con Longhi) parlava di Michelangelo Merisi come l’«antibarocco», «’classicista’ quanto J. L. David nel Giuramento degli Orazi».
.
.
La migliore dimostrazione di questa carnalità è nell’opera del migliore erede che forse ebbe Canova: Hayez.
.
.
Canova vede la realtà sub specie aeternitatis, «amore incoercibile della bellezza fisica», come ripete Paolucci: «Bella natura è il mito che si fa carne». E ricorda Ugo Foscolo che, tutto al contrario dei critici moderni, considerò la Venere canoviana come «una bellissima donna» e contrapponendola alla Venere Farnese diceva: «l’una mi faceva sperare il paradiso fuori di questo mondo e questa mi lusinga del Paradiso in questa valle di lacrime…».
.
.
Il secolo ventesimo è trascorso a digerire il barocco, fino a farne l’emblema della confusione moderna, e per questa riscoperta si è cancellato il neoclassico che a sua volta lo aveva seppellito, ci si è rifiutati per lungo tempo di ristampare le teorie di Francesco Milizia. Così comportandosi però si travolgeva ogni cosa per spirito inutilmente fazioso, a cominciare da quel filone classicistico, incoraggiato da monsignor Agucchi, che si originò proprio nel barocco. Talché si potrebbe dire che nel barocco si rischiava di finire con il nichilismo, proprio a furia di esaltare quell’istante tra il nulla e la tomba – come osservava guardando ormai indietro Aurelio de’ Giorgi Bertola – mentre il neoclassicismo rappresentò una specie di allungamento della vita, di rasserenamento, di pausa, di ragionevole indugiare…
.
.
«Il Canova – ricordano i biografi – si infastidiva a udire gli artisti fabbricar teorie alla tedesca e non quadri e non statue, e se qualcosa si compiaceva di insegnare, era il suo mestiere, e come si maneggiavano il mazzuolo, lo scalpello, la gradina e la subbia». Volesse il cielo tornasse un moderno Canova a insegnare il mestiere ai verbosissimi giovanotti – e ai loro ignoranti accompagnatori critici – che pretendono il nome di artisti solo per le parole vane che profferiscono, ma tecnica niente, neppure ci provano.
.
.
In margine.
Vedendo un’anziana signora che appena l’altro ieri fu assai attraente, veniva da lodare il Possagnese, quella sua arte che, per l’ultima volta – ad attenersi alle rigidezze storiche – sapeva fissare la beltà giovanile, bloccando il tempo, assicurando l’immortalità all’effimero. Quell’«eterna giovinezza» con cui, secondo Foscolo, «rivestiva il marmo». Oppure quanto osservava Stendhal: «finché Canova vive, l’immortalità si può comprare», alludendo ai ritratti eternizzanti che ci si poteva far fare. Così meditando, veniva in mente Jacob Taubes quando contrapponeva la ‘felicità nella fugacità’ di Walter Benjamin alla nostalgia goethiana del Faust per la durata, all’anima venduta al diavolo per sfuggire al tempo, per conquistare un po’ di eterno, all’eco che permane perfino in Nietzsche: «ogni piacere vuole l’eternità». Ne parlava da teologo ma illuminava sul presente delle arti. La sua osservazione, applicata alle nostre questioni, ci fa esclamare: ecco perché Benjamin è diventato il santo protettore dei procedimenti estetici contemporanei mentre Canova resta estraneo, incomprensibile ai moderni. Il gemito della creatura pretenderebbe la fine dei tempi, l’eternità apparirebbe una minaccia per i disperati della terra. Il cosiddetto contemporaneo enfatizzando la friabilità del mondo, negando ogni visione stabile o addirittura ogni visione, sarebbe una bella droga, uno stordimento per la corsa finale. Ma i conforti dell’arte non sono proprio in questa promessa di durata, nell’assicurazione della sconfitta di Madama Morte, della dissoluzione nel nulla? I disperati del resto ne sembrano le prime vittime.
.
L’istantanea, lo scatto della fotografia, blocca l’effimero in una immagine altrettanto effimera, atta a suscitare un effetto nostalgico, un rimpianto per quell’attimo definitivamente trascorso, di cui la fotografia è un assai tenue ricordo. Ha ragione ancora una volta Jean Clair quando sottolinea che la la riproduzione fotografica esclude proprio quanto c’è di artistico e impone il carattere più feticistico. Ben altro discorso per l’opera pittorica, o scultorea, dove il caduco esistenziale viene sottratto al suo destino di morte, assicurando una sopravvivenza finché resterà questo mondo, e forse anche dopo. Insomma una specie di vita eterna, comunque una sua allegoria che sa parlare ai sensi.
.
L’istantanea, lo scatto della fotografia, blocca l’effimero in una immagine altrettanto effimera, atta a suscitare un effetto nostalgico, un rimpianto per quell’attimo definitivamente trascorso, di cui la fotografia è un assai tenue ricordo. Ha ragione ancora una volta Jean Clair quando sottolinea che la la riproduzione fotografica esclude proprio quanto c’è di artistico e impone il carattere più feticistico. Ben altro discorso per l’opera pittorica, o scultorea, dove il caduco esistenziale viene sottratto al suo destino di morte, assicurando una sopravvivenza finché resterà questo mondo, e forse anche dopo. Insomma una specie di vita eterna, comunque una sua allegoria che sa parlare ai sensi.
.
Perfino la bellezza fisica attuale, senza più lo specchio dell’arte, ha un non so che di mortifero. Come al solito, René Girard annota con arguzia: ««Se i nostri antenati potessero vedere i cadaveri gesticolanti che riempiono le pagine delle nostre riviste di moda, li interpreterebbero verosimilmente come un memento mori, un monito di morte. Se spiegassimo loro che quegli scheletri disarticolati simboleggiano per noi il piacere, la felicità, il lusso, il successo, probabilmente scapperebbero in preda al panico, immaginandoci posseduti da un demone particolarmente cattivo». (Dal suo ultimo libretto, tradotto in italiano da Lindau, Anoressia e desiderio mimetico). I tentativi di Canova, l’arte che assicura la durata, la felicità nell’eterno, vanno in controtendenza. Se non c’è più arte, infatti, (non la sua parodia), resta la morte.