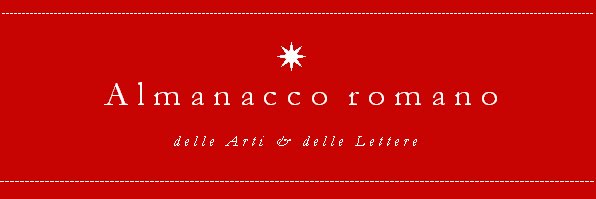ANCORA SUI FUNZIONARI CULTURALI CHE RIDUCONO L’ARTE A UNA ATTRAZIONE PER LE FOLLE E SUL PARADOSSO DEL NICHILISMO FINANZIATO DALLO STATO. QUALCHE LETTORE DELL’«ALMANACCO» HA ESPRESSO DEI DUBBI E DELLE OBIEZIONI, PROVIAMO A RISPONDERE
«Io credo che non possiamo neanche farci un’idea di quella sconfinata magnificenza che gli antichi ponevano in quel che facevano, per esempio nel donare in occasione delle loro solenni adunanze festive, dove a tutti si dava in un modo divino, regale…
Riassumendo: noi siamo diversi dagli antichi, e in questa diversità e coscienza della diversità consiste tutta la nostra natura e tutta la nostra missione: come d’altra parte tutta l’essenza dell’età goldoniana consisteva nell’essere, ad esempio, interamente sordi al Cinquecento e soddisfatti di sé. Noi siamo riflessi degli antichi. Anzi siamo ancora quelli stessi nelle ore tarde della vita.
Tale distanza – e distanza piena di pietà – è il sistema di coordinate del nostro spirito.
Il possesso delle singole cose conviene ad anime infinitamente più fresche, più ingenue; a noi conviene il possesso ipotetico di tutto: io traggo i sogni più belli dal magazzino di stoffe e di merletti della Venice Silk Company, ma non saprei intorno a quale nuca cingere perle».
H. VON HOFMANNSTHAL, Lettera dell’ultimo Contarini, 1903, apparso postumo nel 1929
Si è parlato molto di ‘contemporaneo’ sull’«Almanacco» di queste prime settimane del 2009. Per Hofmannsthal, «il concetto di attualità è da considerare inesistente», nient’altro che un fantasma: abbiamo dunque discusso del nulla? In effetti, osservando certe cose, era venuto il sospetto di un contagio nullista. Però qualcuno dei nostri rari lettori, invitando a una maggiore ponderazione, critica i giudizi recisi espressi, che gli sembrano un rifiuto del presente e delle sue pompe, invero assai pedestri. C’è chi prova a convincersi, a venire a patti con la realtà benché irriconoscibile, a mettersi il cuore in pace come talvolta accade dopo l’annuncio di un malanno devastante: «in fondo è l’arte del nostro tempo». Una semplice faccenda di eredità? Un installatore sarebbe dunque il diretto successore di Carlo Maratta o di Francesco Podesti nell’attività pittorica?
Non è così. Il richiamo alla tradizione artistica serve piuttosto per «estendere a tutti il privilegio di accedere a cose che non esistono più», come è stato detto sagacemente. Nonostante la confusione romantica, l’incrocio dei generi, i trapassi, le fuoriuscite dai quadri già praticate dai pii Nazareni, gli echi, i prestiti tanto frequenti nella indigenza del Novecento, si dovrebbe essere abbastanza giudiziosi per ammettere che gli eredi dei pittori sono i pittori, proprio come i nipotini di Shakespeare pur muovendosi maldestri nelle cantine off (se ne esistono ancora) continuano a far teatro, e quelli di Flaubert continuano a scrivere racconti, benché i media di supporto, dalla stampa in digitale alla riproduzione sullo schermo elettronico, si allontanino dalla carta vergata dall’inchiostro. Che cosa sono invece queste intenzioni estetiche che passano sotto il nome di contemporaneo? Delle inutili duplicazioni di realtà con scarsa verosimiglianza? Forse, come scriveva il giovane Lukács, «l’anarchia, la negazione della forma, che permetterebbe a un intelletto che si presume sovrano di giocherellare a suo piacimento con ogni possibilità»? Semplicemente dei prodotti di gente senza un particolare talento (una mano virtuosa, un occhio penetrante…) e che nonostante tale pecca vuole comunicare a ogni costo? O dei pubblicitari di se stessi in forme tanto aperte da perdere il carattere cogente di forma?
Un proustiano che non sa scrivere, che non è capace di raccontare storie né di acquerellare una carta, raccoglierà i biglietti ferroviari dei suoi viaggi e li esporrà da qualche parte; un altro più intimista e inabile a star su un palcoscenico ad ammaliare gli spettatori si porrà dimesso davanti a uno specchio, consapevole della maggiore indulgenza e complicità del pubblico delle gallerie; uno più intimista ancora e magari maggiormente timido prenderà il suo sterco e lo conserverà in una boccetta, reliquia privata come fiori secchi nelle pagine di Gozzano, che sarà venduta, postuma, a un museo; c’è chi offre il proprio corpo in pasto alla lussuria, alla maniera delle ragazze che si prostituiscono nei locali porno, ma con un confortevole velo ‘culturale’ che manca alle sfortunate mercenarie, e chi, presuntuoso come si potrebbe essere solo a sedici anni, vuole inglobare il mondo ma mancando della pur minima attitudine a rappresentarlo si industrierà a elevare cornici su cornici, in formato gigante, che si aprono sulla sua vuotezza (tentando magari di catturare la fatale Passante); altri metteranno in mostra gli scarabocchi che non ambiscono a essere disegni, e gli oggetti di vita quotidiana (la trivialità, avrebbero detto i critici d’antan), e il catrame e la plastica, e i peluches e i sonagli; i più sfrontati faranno le orecchie d’asino agli dèi, i pernacchi di tradizione futurista, gli scherzi licenziosi della goliardia. Qua e là un tono di adolescenti goffi, una volontà di scandalizzare i parenti adulti (che sono morti da tempo), ma anche una furba capacità di trarre profitto da ogni loro deiezione, da ogni minima fantasia, da ogni meschineria onirica, onde ricavarne guadagni spropositati. Non tutti sono schierati per le gozzaniane «piccole cose di pessimo gusto» (magari l’eleganza dei suoi versi! «il cozzare dell’aulico col prosastico», come osservò Montale; qui si è perso l’aulico), e allora pur non essendo Kapuscinski si sproloquia sullo stato del mondo, si accenna alle sue guerre. Con quale linguaggio? Con quello raccogliticcio del ‘contemporaneo’, che non sapendo sfidare la forma letteraria o pittorica, si arrangia con i rifiuti del pianeta, facendo altarini dei luoghi comuni, accontentandosi di mimare le brutture con la scusa di denunziarle, allestendo scenografie del vacuo, ricettacoli della Morte, impressionantemente tutti uguali. Si faccia avanti chi ha avuto un moto di stupore o il cuore in subbuglio in una galleria o in un museo contemporanei, nonostante gli ‘oh bej, oh bej’ sussurrato dalle ragazze degli uffici stampa. Luoghi inutili, allora.
Ci si mette a fotografare ma non per esibire delle immagini ‘ben fatte’ (che ingenua espressione, diranno i saputelli della scuola dell’obbligo), quanto per stroppiare la riproducibilità delle macchine, sovrapponendo alla impeccabile fattura che offre l’odierna tecnologia un modesto desiderio iconoclasta, una sovrapposizione, un tremolio, una impressionistica resa, per testimoniare l’artisticità che non possiederebbe il semplice documento. Poca o nulla pittura, molto pittoresco, ahimé.
I più dignitosi progettini ricordano assai da vicino quelli delle diligenti maestre della nostra infanzia, quando per sviluppare le intelligenze appena sbocciate organizzavano su alcuni temi dei percorsi didattici con plastici, disegni, scritte, grafiche e tanto cartoncino Bristol, spesso addobbando l’intera aula, con il plauso benevolente dei genitori; un vago apprendimento e un’aria di ricreazione lunga i giorni dei preparativi. Del resto, l’infantilismo faceva parte integrante dei programmi avanguardistici. Ma, sostituito il cartoncino con il plexiglas, perché degli adulti debbono bamboleggiare tanto?
C’è poi chi ambisce alla sociologia: dare la ‘diretta’ degli accadimenti del mondo, delle sue pieghe e abitudini, dei suoi appetiti nascosti, della violenza sottopelle, dei nuovi intrichi dell’eros, senza mediazione intellettuale, senza parole. Questa sarebbe l’obiettivo del contemporaneo – secondo un’obiezione che ci viene rivolta –, missione weberiana affidata ad angeli coatti che dovrebbero metterci di fronte, senza troppi orpelli anzi con tutto il suo vistoso squallore, il tempo in cui siamo costretti a trascorrere la vita. Ma per mostrare il non-senso del mondo non c’è bisogno di balbettare, né di ridurre a frammento, i grandi romanzi lo indicarono perfino con magniloquenza, e così la buona pittura. È da sempliciotti brutalizzare la realtà per farne apparire la desolazione. E che cosa può questa sociologia plastica, che si affida a vecchi filmini in super8 per svelare la nostra banalità, quando i reality televisivi sfoggiano decine di telecamere impalpabili e montaggi sfuggenti cosicché il banale, il quotidiano sgranato in tutti i suoi istanti, vien fuori nello splendore di una riproduzione mai vista prima, sotto luci abbaglianti, a intrappolarci in una tranche de vie davvero iperrealista?
.
Per dare a tutti questi oggetti vili uno spolvero nobile, si invoca l’etica. Ma mentre il soave Giovanni da Fiesole, il Beato Angelico, non si concedeva troppi a parte e metteva in scena la visione scolastica della Chiesa, i nostri sventurati ‘contemporanei’ vorrebbero sempre dir la loro e finiscono con il ripetere cose orecchiate dai giornali, sincretismi religiosi, spiritualismi gnostici, corbellerie socio-politiche, incapaci comunque di distinguere il bene dal male, di organizzare uno spazio in cui il divino e l’umano abbiano un loro posto, talvolta conflittuale talvolta armonico. Che morale, allora, è questa? Forse sarebbe meglio chiamarli motivi antropologici piuttosto che etici ma, come per la sociologia, sottratta alla parola, anche l’antropologia appena accennata, senza linguaggio verbale né figurativo, e tuttavia verbosissimo, confidando nell’espressività di oggetti trasformati in segni, risulta ben buffa cosa. È stato saggiamente rilevato che gli animali condividono con gli umani la possibilità di comunicare, perfino di esprimersi (lo stato di paura, per esempio), ma la rappresentazione è possibile solo all’uomo. Se si rinuncia a questo privilegio, se si rinuncia al racconto pittorico, si ritorna in-fanti, si cade nell’indistinto. Quei poveri diavoli degli psicoanalisti ben sanno quanto siano ripetitivi, tediosi, i prodotti non trattati dell’inconscio.
.
In queste opere, talmente ostentati sono gli enigmi contenuti da somigliare ai rebus della «Settimana Enigmistica», nient’altro che giochi. Eppure, benché in ogni epoca dell’Occidente cristiano si siano avuti numerosi esempi di «arte profana», adesso i prodotti del contemporaneo, con una criptografia a chiave, si propongono allusivi di una qualche superstizione, fuggono il profano, il frutto cioè dell’umanesimo per cui l’autore volgeva il suo sguardo divino sull’oggetto e lo forgiava di nuovo sulla tela o nel marmo. I contemporanei non dominano alcun rito, men che mai quelli dell’antichità pagana, ma impongono le abitudini della fede popolare negli oggetti magici, nei talismani. La potenza affatturante sarebbe poi il valore sul mercato. Quell’aura che Benjamin si illudeva fosse svanita, riappare azzurrina, artificiale, a neon, dietro l’amuleto in vendita. Si costruiscono dei simulacri, degli spaventapasseri drizzati negli spazi asettici delle gallerie. A chi devono incutere timore e tremore?
.
Qualcuno dei nostri interlocutori opina che non tutti si prostrino alla idolatria della frase fatta o all’icona corrente, che in opere contemporanee ci sarebbe la volontà di dialogare con il pensiero filosofico. Ebbene, il pittore meno dotato del Cinquecento ha una simbolica profondissima in confronto a un ‘concettuale’ del nostro tempo che riprende una formula da liceo, è illustratore di libri di testo, riduce il pensiero a immaginetta talvolta afigurativa, oppure a comics di filosofia. Midcult colorata.
.
Chiamarli artisti perciò risulta essere un abuso linguistico così come l’altisonante definizione di arte per i loro prodotti è un investimento nella ambivalenza semantica onde far passare sul mercato un mélange di Sehnsucht senza forma. Soprattutto all’inizio, ha fatto colpo sul grande pubblico questo richiamo alla storia dell’arte e alle vicende patetiche degli innovatori incompresi e dei critici che rifiutavano stoltamente il nuovo, episodi che, intimidendo chi accennava una resistenza conservatrice, dovevano addestrare ad aprire le porte a ogni insensatezza. Più tardi però, una volta introdotti nel mondo delle aste, delle gallerie e dei musei, si è diventati autonomi dalle vecchie regole artistiche, avendo anzi avviato un circuito commerciale che produce e promuove oggetti con scopi diversi da quelli di ogni tradizione. Non si tratta soltanto di differenze linguistiche. Nel contemporaneo si punta precipuamente a cogliere gli infinitesimali scarti di novità su una scala cronologica, e questi sono gli unici valori: tanto peccano di scarsa originalità nelle loro invenzioni che, come nella moda, prima o poi alla stessa trovata arriveranno tutti quelli che operano nel settore, per cui la grande gara consiste nel battere il concorrente al fotofinish. Lo spettatore della gara (assistito dagli arbitri ufficiali, gli esperti), una volta appurato il grado di stravaganza, spesso diventa l’acquirente. Difficile concepire in simile interazione lo spettatore incantato.
.
Sarebbe dunque interessante parlare di ciò che distingue questo strano miscuglio estetico dall’arte propriamente detta, invece di proseguire nell’equivoco. Basti osservare che non a caso sono nati i musei contemporanei perché, a differenza del moderno, i particolari oggetti che vi sono ammucchiati non hanno niente a che fare con i quadri, le statue, le incisioni, ecc., non riescono a convivere sotto il medesimo tetto con le belle arti, manifestando la più radicale estraneità. Che con il termine ‘contemporaneo’ non ci si riferisca soltanto a una questione temporale appare evidente proprio in questi musei: nessuna opera viene mai espulsa dalle loro sale per sconfinamento dell’hic et nunc; ad esempio, le tele seviziate con la lametta o quelle incatramate, che risalgono a una generazione ormai scomparsa, dovrebbero essere ospitate in un Limbo dei trapassati, musei intermedi delle stagioni trascorse, centri di vintage (definizione che, non a caso, richiede un solo ventennio per accertare il passatismo), altro che spazi vitalissimi del kairòs. Se dunque si tratta di oggetti raccolti per qualche curiosa mania, come lo sono quelli che accolgono le collezioni delle macchine da cucire o delle scatole di fiammiferi (e ce ne è un catalogo vasto come la merceologia), perché continuare sulla falsariga dell’arte, perché ricorrere alla parola (assai tradizionale) di museo? La Casa delle Muse, luogo di divino piacere, diventa una Casa degli stati d’animo, posto pernicioso che provoca disagio nel visitatore, molto prossimo al vecchio manicomio.
.
I critici (senza kritòs), spin doctors degli autori di questo potpourri, o ‘arbitri’ del loro ordine di arrivo al traguardo delle innovazioni, collaborano nell’infinito commento del commento, chiosa della chiosa, in gerghi che danno un’aria ostica, rintracciando le citazioni (come i motori di Internet sanno fare meglio e sul piano universale, laica glossolalia), senza mai arrivare al bandolo della matassa, che manca per intento dell’artefice, scivolando nel descrittivismo ridondante, nella esegesi del nonsense. Nell’incipit non c’è l’arbitrio proprio dell’artista bensì il caso.
.
I collezionisti che dovrebbero confermare la bontà di siffatti prodotti sono in genere gli imprenditori che dopo aver fatto i soldi vogliono darsi pure un tono. Niente di male, per carità, ma non risultano certo testimonials dell’esprit de finesse. E d’altronde, anche nell’arte autentica, presero clamorosi abbagli: quanti ne ingannò Berenson, rifilando loro falsi e croste della pittura medioevale. Che cosa albergherà in quegli animi – sarebbe curioso venire a sapere – quando tornando a casa dopo una giornata a produrre merci, troveranno altre merci, oggetti spesso seriali, che conoscono bene, ma mascherate da opere d’arte e pagate a caro prezzo? Gente pratica che si presta a simili credenze, a finzioni estetizzanti, pur di ben figurare in società. Per la solita soggezione nei confronti della cultura, proveranno a prestar fede alla fanfaluca messa in giro dai consulenti che si tengono a corte: che questi artigiani dell’inutile, solo perché mirano al niente, sono automaticamente degli artisti. (D’altronde, l’artisticità di simili oggetti poco artistici sembrerebbe spuntare proprio da un tale valore aggiunto, l’inutilità: artigiani del niente, pubblicitari che si distinguono da quelli al servizio delle aziende perché reclamizzano il niente, venditori del niente, ma con un sistema commerciale a carattere planetario.)
.
Vittime poco consapevoli dell’occasionalismo promosso dai romantici: ogni pretesto è buono per considerazioni e azioni estetiche. Se non si conosce l’arte delle velature né quella della recitazione fosse anche al cabaret, né quella del racconto né quella assai sfaccettata di dirigere un film sottomettendo la realtà alle esigenze narrative di uno script, se insomma non si ha un talento particolare ma una voglia generica di ricamare sul mondo una cifra stilistica, ecco la folla dei creatori di conati. Tali creazioni inattuate assumono una inquietante presenza proprio perché non essendo arte si vogliono immediatamente eloquenti, oggetti tautologici e leggermente autistici. Se in questo modo, con uno sfondo plumbeo, sinistro, deprimente, o con una euforia drogata, ci appare il contemporaneo - lasciando da parte l’architettura che pone problemi diversi - perché mai andrebbe trattato, anche dal punto di vista dei pubblici finanziamenti, come si tratta l’arte?
.
Rispondono i nostri interlocutori: bisogna informare su tutto quanto accade nella nostra epoca e la riflette a suo modo. Anche le cerimonie della morte dell’arte – ci scrivono – vanno seguite e studiate. Ma – controbattiamo – non bastano le foto di questi funerali dell’arte? Perché acquistare l’originale quando proprio tutte le teorizzazioni estetiche contemporanee escludono anche l’esistenza di un originale, di un prius, nel cerchio eterno del nichilismo. Casomai, appunto, l’originale ha soltanto un valore monetario. Che quindi si apra un pedantissimo archivio pubblico d’ogni evento e d’ogni mostra, come al ministero dell’Interno se ne ha, presumiamo, di tutti i crimini commessi nella penisola. E a chi insiste che qualche soldo pubblico non si nega a nessuno: non sarebbe giusto eventualmente finanziare solo artisti italiani che non ottengono successo economico, così come si aiutano i film difficili non la serie sulle Vacanze di Natale? E le belle arti difficili non saranno quelle di chi si ostina a dipingere su una tela, a restare fedele – con le infinite difficoltà che ciò comporta – all’iconofilia?
.
La discussione tocca un tema più arduo. Nietzsche, nel 1871, si accorse spaventato: «Fenomeno nuovo, lo Stato come stella per guidare la cultura!». Un secolo e mezzo più tardi, si dà per scontato il suo intervento per sorreggere tutti i capricci estetici: un’amica ci scrive che «forse la crisi farà un po’ di pulizia: giocoforza rimarranno solo (semmai) i soldi dei privati mentre le amministrazioni comunali vivacchieranno su mostre e mostrine, tendenzialmente sempre più sbiadite. Ma non istituirei nessuna parentela tra il presunto scandalo del finanziamento ai musei contemporanei con le alte quotazioni dell’arte che si celebrerà dentro questi». Forse, più che la presunta arte, sono «le alte quotazioni» che «si celebrano» in questi templi. Macchine per fare soldi, per quotare degli oggetti più o meno investiti di intenzioni estetiche, altro che scandalismo, è una questione di precisione linguistica. Che rimanga nel piatto solo il denaro dei privati dovrebbe essere scontato. Quanto alle amministrazioni comunali, sarebbe meglio si occupassero di viabilità e di trasporti piuttosto che spartire politicamente, in iniziative sbiadite o terse, i resti della rivolta avanguardistica di cento anni fa.
.
Preoccupati dalla crisi, coloro che svolgono una qualche attività in questo sistema dai piedi di argilla, si sentono alla vigilia di un terremoto. L’effimero galvanizza nei periodi di ottimismo sociale, adesso, nella situazione precaria, viene a galla con maggiore nettezza la confusione lessicale: qui «arte» e «denaro» rimano tra loro in modo sospetto e risentono dei bruschi alti e bassi della Borsa odierna. Scrive ancora la nostra conversatrice, che di questo mondo è una testimone importante: «Si dice che, sulla spinta della catastrofe finanziaria, l’arte si umanizzerà. Ovvero, calerà di prezzo, finiranno le speculazioni e Jeff Koons o Damien Hirst, i più costosi e, specie il primo, tra i più discutibili artisti del momento, non guadagneranno più soldi a palate. Personalmente credo poco a un’arte umanizzata (l’Umanesimo, diciamo, è roba di un altro secolo). […] È un mercato e, come tale, farà più saldi e meno soldi, licenzierà, chiuderà qualche bottega. Niente di più e niente di meno».
A dire il vero, non avevamo mai immaginato che l’umanizzazione dell’arte avesse qualcosa a che vedere con prezzi e saldi. Negare l’umanesimo significa ostentare un cinismo poco credibile: almeno di non confondersi con la semplice arte del delitto, non sembra si sia in grado di sostenere la ferocia di Gottfried Benn in un’epoca tanto piagnucolosa. Nessun umanesimo infatti ma molto umanitarismo, commossi per la pelle del presidente mondiale, sensibili alle bestialità dei popoli più selvatici, turbati per i tiranni finalmente impiccati. Ma per quanto riguarda l’arte, la parola d’ordine è disumanizzazione, anzi La deshumanización del arte, come voleva Ortega y Gasset all’alba del Novecento – oggi l’aristocratico pensatore, che confidava in questa esotericissima esperienza estetica, non sarebbe troppo soddisfatto dei suoi risultati di massa, l’aborrito Luna park del tempo libero; e il suo librino, che zelanti editori consigliano pubblicamente al ministro bonario affinché, folgorato dalle teorie del signore conservatore, sganci le sovvenzioni, si consuma in aforismi d’altri tempi, roba ormai naïve di fronte alla spregiudicatezza dei mercanti –, insomma con o senza lo Spagnolo si teorizzano fredde geometrie e raggelanti boutades per l’arte di diventare ricchi . E si ripete senza un soprassalto morale l’espressione alla moda post-umano, evitando di riflettere sul carattere fantascientifico di una tale minaccia? Almeno che non si voglia una sperimentazione estetica così mimetica per cui alla «crescente pietrificazione della vita» (Jünger) seguano tentativi scriteriati di pietrificarsi e pietrificare lo sguardo. Era il desiderio dell’avanguardia di risultare buona imitatrice dei mali del mondo, di ripeterne le forme animalesche, «una riduzione dell’uomo al suo lato animale»; ma se ancora poteva suggestionare nell’operare di quei disorientati del primo Novecento, intorno alla Grande Strage Mondiale, con l’infantilismo dada o il demonismo surrealista, appare meno rispettabile nei nostri anni, quando «nel preumano e nel preterumano, cioè verso la psicologia dei primitivi, dei malati di mente e dei delinquenti, nel mondo dell’ebbrezza e del sogno, della massa, delle scimmie» (Sedlmayr) si crogiolano i programmi televisivi di intrattenimento, anzi è canone della ideologia collettiva.
.
«Quanto ai musei, scandalizzarsi per un po’ di spiccioli non è forse il caso», ci critica la mondana amica (oddio, gli «spiccioli», che sono milioni di euri, di fronte ai vecchi con la social card evocano le brioches che costarono la testa alla candida Maria Antonietta). Il nichilismo finanziato dallo Stato: la genesi di un simile paradosso è stato rinvenuta da Marc Fumaroli, storico del pensiero che ha davanti a sé lo Stato più accentratore d’Europa, lo Stato culturale (come suona il titolo del suo titolo, in italiano, da Adelphi), la Francia. Lassù, l’ottocentesco socialismo dei maestri impose arte e musica per tutti, quando tutti erano poveri, ma proseguì con il mecenatismo del fantasioso Malraux, letterato che al ministero gaullista della Cultura (il primo del genere) giocava con le messe in scene regali. E nella Francia eternamente colbertiana, capitò di leggere su un grande manifesto anni Novanta: «Il Consiglio regionale dinamizza le arti plastiche». Oscuro messaggio pubblicitario che ha trovato parecchi seguaci in Italia. Ma da noi accade che la Regione Campania apra musei contemporanei proprio mentre la immondizia si accumula per le strade in una performance unica al mondo, dove la specularità con certe sculture pop confonde ancora una volta lo spettatore: è l’estetica contemporanea che viziosamente annusa i letamai puzzolenti o semplicemente i suoi oggetti sono immondizia che la realtà fa sua, platonica «copia di copia»? Il mondo intero rimase orripilato da tale esposizione dei rifiuti e disdisse le gite a quella città derubata della sua bellezza ma che ora poteva vantare un nuovo museo. Intanto, tra il proliferare dei luoghi del contemporaneo, iniziative atte forse a smuovere un po’ di turismo in Arizona, al Museo Archeologico, una delle massime attrattive italiane, mancava regolarmente la luce in alcune sale straordinarie, perché «la corrente non basta», confessavano mortificati i guardiani.
.
Nei musei contemporanei e nell’indotto, «la cultura, nel suo senso originale e fertile, non ha posto, e a maggior ragione le arti e la poesia», dice con franchezza il saggio francese. I libri dei funzionari culturali che esaltano la creatività, l’aspetto ludico dei musei, la demitizzazione dell’arte, «non bisogna leggerli, come non bisognava leggere la ‘Pravda’», roba burocratica, linguaggio sindacale, socialismo culturale, il peggiore. «Bisogni culturali» è una parolaccia, anche insensata, insegna pazientemente Fumaroli.
.
È concepibile che un qualsiasi cittadino, senza altre referenze che quelle delle sue cosche beneficiarie, metta su una qualche strampalata impresa che si fregia della denominazione di ‘artistica’ e successivamente chieda i soldi pubblici, la tutela, gli aiuti, come faceva la Fiat che almeno un rilevante ruolo nella produttività italiana lo ricopriva? Perché l’obbligo all’elevazione culturale dei contribuenti? Si può auto-determinare la propria vita e la propria morte – dicono – ma non ci si può rifiutare di lasciarsi acculturare, costretti a dar l’obolo a questi orrori? (Era il problema che ci stava a cuore nel corsivo del 23 gennaio, «Tre domande sulla bolla contemporanea». Da allora ci separa un mese rovente di discussioni accese da un romanziere alla moda e di sinistra, che ha scandalizzato i suoi compagni affrontando gli aspetti pecuniari dello sperimentalismo. Vivaddio, qualcosa si muove nelle pagine ‘culturali’!)
.
Viene allora da chiedersi: la cultura è autonoma dalla propaganda? Questo si dovrebbe appurare quando i ministri sono chiamati a mettere soldi in qualche baraccone estetico. Gli impresari, indignati, risponderebbero naturalmente che in nessuna maniera si può accostare réclame e contemporaneo, per poi gridare alla censura e concludere con una bella raccolta di firme quando si ipotizza che una surrettizia propaganda nichilista venga fuori dalle manifestazioni del contemporaneo. I collusi con le imprese estetiche scendono allora in campo con la divisa di paladini della cultura per respingere la ignobile ingerenza della destra ignorante. Ma questa, a dire il vero, è una concezione della cultura come territorio dei privilegi e dei privilegiati. Meglio sarebbe perciò, dal momento che nel terzo millennio la maggioranza degli italiani spende senza troppe riserve per cinematografi e pizze, che i musei contemporanei e i festival di canzonette, i club pornografici e i raduni di poesia, contassero soltanto sulle loro forze e sul loro pubblico, se ne hanno uno disposto a crederci.
.
La rete dei musei in Francia si estende fittissima, quel che mancano sono gli artisti. C’è già un posto per le loro opere, come nei cimiteri moderni, è la materia prima che scarseggia. Anche da noi un guru di questo genere di cose, forse pentito, dichiara che sono i musei ormai a sollecitare le opere e non viceversa. E l’arte sottomessa al «potere pubblico» delle amministrazioni locali non può proprio far sognare. Per contrastarla, Fumaroli stigmatizza il «terrore» che impone di amare l’arte, non di conoscerla, studiarla, capirla, saperla imitare, eventualmente rifiutarla; soltanto il fatuo amore si predica, l’imposizione di visitare i musei, di partecipare alle grandi mostre, anche con viaggi, gite, sfacchinate. In un campo attiguo si muove la crociata che intima: leggete, leggete!
.
La formula che permette il «terrore» somiglia al sacerdozio universale di marca luterana: «tutto è cultura». Per Fumaroli si tratta di una definizione che rimanda a un «altruismo infinito». Ovvero, i funzionari culturali, i burocrati del bello, si sono trasformati in sociologi e animatori, come i pubblici eccitatori dei villaggi di vacanze. Si preoccupano dei turisti, si mettono nei loro panni, ma i turisti sono loro, dei vacui pregustatori di spettacoli cheap, dei contemplatori e dei divoratori del nulla, al solo scopo di far riempire un museo, di affollare un ‘evento’. Sono invasi dalla stessa ossessione del pubblico, che trova il senso solo nel successo.
.
Se tutto è cultura, se proprio tutto è arte, i miliardari che toccano allegramente i record della ricchezza, e che talvolta rovesciano anche le sorti della politica, sarebbero dei giganti alla pari di Michelangelo; per non parlare, sinistramente, di criminali storici, che organizzarono eventi tremendi e in dimensioni mai viste: anche loro dei grandi artisti? Artisti del male?
.
Per non limitarci a denunciare il ridicolo della faccenda, sentiamo chi seppe dipingere nel Novecento senza lasciarsi intimidire dai ricatti dei ‘teorici’. In una intervista degli anni Sessanta, alla domanda «ma cos’ha la pittura moderna che non va?», Giorgio de Chirico rispondeva: «Tutto. Non è pittura. È pasticcio, è confusione, è dilettantismo. La pittura moderna è come una donna che da giovane ha vissuto la sua bellezza, adesso che è vecchia, non potendo più interessare, fa l’intellettuale… I pittori moderni non potendo fare la vera arte, si rifugiano negli intellettualismi». «Ma perché i pittori moderni non possono fare la vera arte?», insisteva l’intervistatrice. «Perché non sanno dipingere», affermava sicuro il Pictor Optimus. «E perché non sanno dipingere?» diceva lei, e lui rispondeva laconico: «Perché hanno perso il mestiere». «E perché hanno perso il mestiere?», ecco un bel problema: «La ragione principale è che non ci sono più le scuole d’arte. La pittura è una forma di artigianato superiore. Con l’industrializzazione del materiale da pittura, l’artigianato è morto e, con l’artigianato, l’arte». Viene da concludere che invece di buttare soldi per delle vane imprese estetiche, lo Stato potrebbe limitarsi a finanziare dei buoni istituti, dove insegnare le tecniche della pittura, così come a scuola si insegna a scrivere, anche un romanzo.