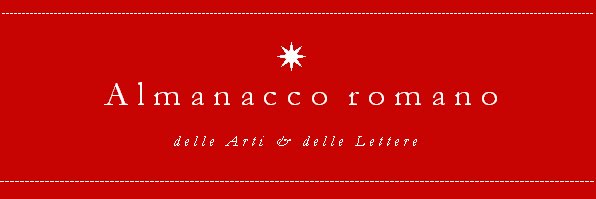CHE NON HANNO BISOGNO
DI TURISMO ~
Si era concentrati nella lettura di un libro su un tram romano non più sferragliante come un tempo, quando il gommoso fluire venne disturbato da un chiacchiericcio con cadenze siciliane: «la cultura... la cultura», ripeteva il mantra. Cosicché finimmo nolenti a intercettare le conversazioni di due boss dei cosiddetti beni culturali in viaggio di lavoro nella capitale, con frasi reboanti sugli affari che controllavano. Uno dei due teneva tra le mani un volumone che incuriosiva per la mole: che tema meritava mai tanto peso, quale trattatista poteva permettersi di ingombrare quanto un bagaglio? Il titolo, Mafie, faceva subito intendere di che razza di passionisti dell’ovvio si trattasse. Il principale nel grado burocratico si lamentava con l’altro per la Cappella Palatina di Palermo, di cui sembrava avesse una qualche responsabilità amministrativa, che gli dava non pochi grattacapi. Era il prete che celebrava la messa a procurargli il maggior fastidio, sottraendo ai turisti quella mezzoretta così preziosa, ma sembrava irritato anche dai palermitani che la domenica si volevano sposare in quell’aureo tempio invece di avere a cuore gli incassi della biglietteria posta all’ingresso della chiesa. Il prete era malvisto perché voleva pregare nel luogo di preghiere, le coppie perché pretendevano di far benedire in una sala delle meraviglie le loro nozze sottraendo così molti soldi alla «cultura». Ancora una volta questa appariva come uno dei peggiori feticci contemporanei, esigendo continui sacrifici delle cose più sacre. Ma è anche vero che forse a Palermo non conoscono la formula per mischiare liturgia e turismo in voga a Roma sul sagrato della basilica petrìna, dove i pellegrini si rivelano essenzialmente dei gitanti, ragion per cui recentemente li si accontenta riducendo al minimo i sacri riti e ampliando l’entertainment, anche con opportuni discorsetti al livello dei viaggiatori in brache corte, e con gesti che fanno fuori la solennità, a maggior gloria del tutto compreso.
Che severità, obietterete, si deve pur mangiare. «Prostituzione intellettuale», secondo la lezione di un elegante lusitano, e si finisce per confondere la seduzione dell’arte con l’adescamento: si mette a disposizione il più squisito e vulnerabile lascito degli avi nostri al voyerismo internazionale. A metà Ottocento, Gustave Flaubert scriveva in una lettera da Napoli di bambinetti e bambinette proposti da padri e madri alle stazioni delle carrozze per danarosi passeggeri stranieri; il commercio infantile adesso è più nascosto, non si fanno scrupolo invece i prosseneti delle opere d’arte. La chiamano risorsa la triste pratica di commerciare la bellezza. A sentir giornali ed esperti, la Grande Proletaria non pare possedere altre chances per sopravvivere. Non si posa ammirato e stupefatto sulla bellezza quello sguardo profano, ottusamente distratto, intriso di turpitudine, senza più riverenza per le testimonianze del passato; le guide, cieche tra i ciechi, si limitano a tener serrata la mandria. Il commercio dei secoli è inconfondibile segno di decadimento. Rubate alla quotidianità, le chiese non servono più a Dio e ai suoi fedeli, bensì ai visitatori estranei che pagano per guardare. Un tale traffico lo chiamano cultura quando sarebbe più appropriato il termine simonia. Povera Italia ridotta a un museo perché quelle opere esposte non sa più crearle, perché non riesce a ideare la taumapoietica, perché ha dimenticato i segreti del bello e deve accontentarsi di rivendere quello ereditato.
A Roma, Firenze e Venezia, dilaga il «colera turistico» (Manlio Brusatin) e tutta la penisola è contagiata dal morbo senza preci e immagini taumaturgiche che ottengano il miracolo della guarigione. Tutti osti e camerieri, hostess e ciceroni, autisti e museificatori: chi progetta ancora senza mettersi nello specchio dello spaccio turistico? I nostri borghi nacquero per egoistica dolce vita, al massimo per competere con il paese accanto. I visitatori allora, i giovani aristocratici del Grand Tour, erano accolti alla tavola dei signori per scambiare quattro chiacchiere sugli affari del mondo non per smerciar loro emozioni. Quelli che confidano nella «cultura» si rammaricano invece che il Sud non sia all’altezza del servizio turistico, destinando con cinismo, e con l’avallo delle autorità governative, una parte cospicua e già sfortunata della penisola repubblicana a questa nuova attività ancillare, senza più prevedere un futuro minimamente dignitoso dove magari si sappia costruire una Cappella Palatina del nostro tempo. Certo, ben poco di quel che firmano oggi con iattanza - nell’architettura come nel ‘visivo’ - potrà tornare utile ai nostri figli nel caso malaugurato che finissero anche essi in una crisi paralizzante e volessero superarla ricorrendo al mestiere dei padri, ovvero di avvilire e svendere le proprie arti. Meglio essere conquistati dai Normanni o dagli Angioini - intrecciando tra indigeni e invasori amorose invenzioni - che essere sottoposti all’effimero dominio di chi lascia dietro di sé soltanto rifiuti.
Il pubblico funzionario sul tram sembrava avere in mente l’idea più balorda: il Belpaese costretto a sostentarsi con la propria bellezza, cioè con la più impalpabile delle ricchezze. La Cappella Palatina umiliata a opera da tre soldi ma contando le monete raccolte con l’occhio avido di Scrooge McDuck. Per pompare denaro un ospedale diventa un museo e la casa di Dio un sito a pagamento. Magari tra un po' venderanno tutto direttamente a chi sa sfruttare meglio le italiche uova d’oro (liberalismo da Mackie Messer) e per dire messa si ricorrerà a qualche garage, secondo lo pseudo francescanesimo alla moda. Intanto, a furia di apporre un prezzo a ogni angolo delle città d’arte e di far pagare le nostre memorie, succede che pure a un italiano in giro per la casa davvero comune càpiti di dover versare somme insostenibili; lo si notava con dolore giorni fa a Siena: per vedere duomo e palazzo comunale, l’ex ospedale e la torre cittadina, a otto euri in media, magari con una scarna famiglia, egli dovrà sborsare una banconota da cento. E in sovrappiù essere travolto dalle folle di profani vocianti, che vogliono soltanto agitare i loro smartphone e scattare. Che ne sanno le masse di Caterina Benincasa?
A Roma, Firenze e Venezia, dilaga il «colera turistico» (Manlio Brusatin) e tutta la penisola è contagiata dal morbo senza preci e immagini taumaturgiche che ottengano il miracolo della guarigione. Tutti osti e camerieri, hostess e ciceroni, autisti e museificatori: chi progetta ancora senza mettersi nello specchio dello spaccio turistico? I nostri borghi nacquero per egoistica dolce vita, al massimo per competere con il paese accanto. I visitatori allora, i giovani aristocratici del Grand Tour, erano accolti alla tavola dei signori per scambiare quattro chiacchiere sugli affari del mondo non per smerciar loro emozioni. Quelli che confidano nella «cultura» si rammaricano invece che il Sud non sia all’altezza del servizio turistico, destinando con cinismo, e con l’avallo delle autorità governative, una parte cospicua e già sfortunata della penisola repubblicana a questa nuova attività ancillare, senza più prevedere un futuro minimamente dignitoso dove magari si sappia costruire una Cappella Palatina del nostro tempo. Certo, ben poco di quel che firmano oggi con iattanza - nell’architettura come nel ‘visivo’ - potrà tornare utile ai nostri figli nel caso malaugurato che finissero anche essi in una crisi paralizzante e volessero superarla ricorrendo al mestiere dei padri, ovvero di avvilire e svendere le proprie arti. Meglio essere conquistati dai Normanni o dagli Angioini - intrecciando tra indigeni e invasori amorose invenzioni - che essere sottoposti all’effimero dominio di chi lascia dietro di sé soltanto rifiuti.
Il pubblico funzionario sul tram sembrava avere in mente l’idea più balorda: il Belpaese costretto a sostentarsi con la propria bellezza, cioè con la più impalpabile delle ricchezze. La Cappella Palatina umiliata a opera da tre soldi ma contando le monete raccolte con l’occhio avido di Scrooge McDuck. Per pompare denaro un ospedale diventa un museo e la casa di Dio un sito a pagamento. Magari tra un po' venderanno tutto direttamente a chi sa sfruttare meglio le italiche uova d’oro (liberalismo da Mackie Messer) e per dire messa si ricorrerà a qualche garage, secondo lo pseudo francescanesimo alla moda. Intanto, a furia di apporre un prezzo a ogni angolo delle città d’arte e di far pagare le nostre memorie, succede che pure a un italiano in giro per la casa davvero comune càpiti di dover versare somme insostenibili; lo si notava con dolore giorni fa a Siena: per vedere duomo e palazzo comunale, l’ex ospedale e la torre cittadina, a otto euri in media, magari con una scarna famiglia, egli dovrà sborsare una banconota da cento. E in sovrappiù essere travolto dalle folle di profani vocianti, che vogliono soltanto agitare i loro smartphone e scattare. Che ne sanno le masse di Caterina Benincasa?