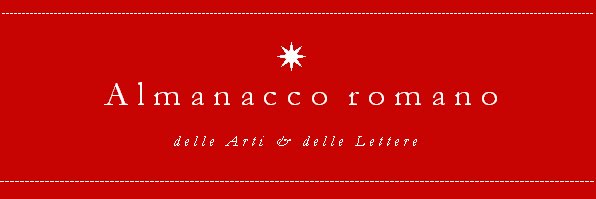~ LA VITTORIA SULLA MORTE MESSA IN SCENA DA PIERO
E CONTEMPLATA DA ANDRÉ SUARÈS ~
Prima che Roberto Longhi ‘scoprisse’ Piero della Francesca, uno scrittore francese ormai dimenticato, André Suarès (1868-1948) celebrava «il più intelligente dei pittori», l’artista che mostrava «una mescolanza profondissima e intimissima tra intelligenza e fede». Adesso, nelle poche righe dedicate a Suarès dalle enciclopedie non si menzionano neppure i volumi del Voyage du Condottière ambientati nell’Italia dei primi decenni del Novecento. Lo scrittore marsigliese percorreva a piedi la nostra penisola, come il suo confratello tedesco Rudolf Borchardt che batteva palmo a palmo la Toscana, fuori dalle limitate rotte ferroviarie. Anche Suarès prediligeva la Toscana, Siena in particolare, ma si spinse fino a Roma, che non amò mai, nei suoi tanti viaggi in Italia. Si considerava un condottiero spirituale, «un cavaliere errante, che ho visto partire dalla Bretagna per conquistare l’Italia. Perché ormai, in un mondo in preda al carnaio e alla plebe, la più alta conquista è l’opera d’arte». Era la fine dell’Ottocento quando cominciò quella «conquista d’Italia». Si considerava un resistente, un artista «in un’epoca in cui nessuno lo è più» e si specchiava così nel suo personaggio: incapace di guadagnare denaro, «preso pertanto da ogni cosa della terra, amante di ogni seduzione, avido soprattutto di dare, cogliendo un piacere che nessuno ha saputo assaporare meglio. […] sempre povero, talvolta mendicante», collerico, «sembrava straniero dappertutto». «Lo si è creduto anarchico, era la gerarchia fatta uomo» «con un amore per la creazione che nessuno eguaglia…». Proust si convinse a visitare Venezia grazie alle prose seducenti di Suarès. Ogni tanto qualcuno in Francia si ricorda che il suo Voyage è «guida incomparabile» (Jean d’Ormesson) per capire l’Italia e la sua arte. Il poeta Yves Bonnefoy sulle tracce di Suarès ha ripreso il culto per Arezzo come luogo dell’anima e per Piero. Agli occhi del Condottiero della Bellezza, diviso tra la passione per i santi e quella per gli eroi, il pittore della Croce fu subito il suo eroe e divenne «Piero il grande» nel capitolo aretino che apre il volume del Voyage titolato Sienne la bien aimée da cui traiamo queste poche righe sul mattino di Pasqua. Paradossalmente ma non troppo, l’opera francese in cui si magnificavano con sapienza le città del Belpaese come mai avevano fatto i nostri cugini d’Oltralpe sempre affetti da un certo sciovinismo, non ha visto ancora una traduzione italiana (salvo una pubblicazione locale limitata alle pagine senesi).
«Piero ha dipinto la Resurrezione, o per meglio dire Gesù che esce dal Sepolcro. Così Borgo sembra derivare il suo nome proprio dall’ammirevole opera del suo pittore. Questo affresco è senza dubbio l’ultimo cui Piero abbia messo mano. Doveva avere allora dai settant’anni in su. Non c’è dipinto che non sappia meno di vecchiaia. Una forza intatta e una altrettanta sicurezza. Una indomabile energia che si possiede e nessuna debolezza da temere. Il genio è più vigoroso, addirittura più insolente che mai; e il pensiero magnifico. Un tale capolavoro non ha altri equivalenti che la Crocifissione sublime di Grünewald a Colmar: vi si contrappone, polo a polo, come il mezzogiorno al nord, e il giorno alla notte. Piero è proprio il figlio nobile della città del Sepolcro. Crede alla resurrezione e all’immortalità. La sua fede sembra certa, piena di autorità e di calma violenza. Il Salvatore è un guerriero. Al termine della notte, scaturisce dalla tomba, la croce in pugno, come uno stendardo, come una lancia. Il suo gesto è quello di un atleta, la sua taglia quella di un gigante. Sotto il sepolcro aperto, i soldati di guardia dormono. Il più vigilante di tutti, che dovette cedere alla fatica per ultimo, il torso dritto, addossato alla tomba, si è assopito con la guancia a contatto con la sua lunga lancia, che serra tra le mani. E il piede del Cristo, che sale a questo primo grado della resurrezione, tocca quasi la barbetta all’angolo del legionario addormentato. Il loro Dio resuscita, e questi non vedono niente, non intendono niente. Veri fedeli, veri soldati.
Potente e sofferente, Gesù è terribile. Nel Giudizio universale, Michelangelo se ne è ricordato. Il suo sudario è un’armatura, il furore gonfia le pieghe di questa toga. Il piede sinistro in aria, che preme il bordo del sarcofago, il ginocchio a squadra, egli sta per salire in cielo con un solo slancio, rischiando di schiacciarsi prima sulla terra; il medesimo slancio anima il suo braccio armato dello stendardo. Il volto ha visto la morte, mantiene le tracce del supplizio. Che vittoria dolorosa. Ma il movimento totale della forma cancella ogni sentimento di dolore: il corpo di questo atleta è quello di un vincitore infallibile. Egli occupa il centro del dipinto. La figura parte dal suolo, ove il piede destro preme ancora la pietra del sepolcro, per andare fino al cielo tempestoso, che tocca la croce dello stendardo. L’intero paese, alberi, cielo e montagne, corre dietro al Cristo. I giochi d’ombra e di luce, forse per la prima volta nell’arte del dipingere, danno un’anima e un canto all’ora dell’alba, tra la notte e il giorno, che è l’ora più da brividi tra tutte, quella irreale e tragica della resurrezione».
E CONTEMPLATA DA ANDRÉ SUARÈS ~
Prima che Roberto Longhi ‘scoprisse’ Piero della Francesca, uno scrittore francese ormai dimenticato, André Suarès (1868-1948) celebrava «il più intelligente dei pittori», l’artista che mostrava «una mescolanza profondissima e intimissima tra intelligenza e fede». Adesso, nelle poche righe dedicate a Suarès dalle enciclopedie non si menzionano neppure i volumi del Voyage du Condottière ambientati nell’Italia dei primi decenni del Novecento. Lo scrittore marsigliese percorreva a piedi la nostra penisola, come il suo confratello tedesco Rudolf Borchardt che batteva palmo a palmo la Toscana, fuori dalle limitate rotte ferroviarie. Anche Suarès prediligeva la Toscana, Siena in particolare, ma si spinse fino a Roma, che non amò mai, nei suoi tanti viaggi in Italia. Si considerava un condottiero spirituale, «un cavaliere errante, che ho visto partire dalla Bretagna per conquistare l’Italia. Perché ormai, in un mondo in preda al carnaio e alla plebe, la più alta conquista è l’opera d’arte». Era la fine dell’Ottocento quando cominciò quella «conquista d’Italia». Si considerava un resistente, un artista «in un’epoca in cui nessuno lo è più» e si specchiava così nel suo personaggio: incapace di guadagnare denaro, «preso pertanto da ogni cosa della terra, amante di ogni seduzione, avido soprattutto di dare, cogliendo un piacere che nessuno ha saputo assaporare meglio. […] sempre povero, talvolta mendicante», collerico, «sembrava straniero dappertutto». «Lo si è creduto anarchico, era la gerarchia fatta uomo» «con un amore per la creazione che nessuno eguaglia…». Proust si convinse a visitare Venezia grazie alle prose seducenti di Suarès. Ogni tanto qualcuno in Francia si ricorda che il suo Voyage è «guida incomparabile» (Jean d’Ormesson) per capire l’Italia e la sua arte. Il poeta Yves Bonnefoy sulle tracce di Suarès ha ripreso il culto per Arezzo come luogo dell’anima e per Piero. Agli occhi del Condottiero della Bellezza, diviso tra la passione per i santi e quella per gli eroi, il pittore della Croce fu subito il suo eroe e divenne «Piero il grande» nel capitolo aretino che apre il volume del Voyage titolato Sienne la bien aimée da cui traiamo queste poche righe sul mattino di Pasqua. Paradossalmente ma non troppo, l’opera francese in cui si magnificavano con sapienza le città del Belpaese come mai avevano fatto i nostri cugini d’Oltralpe sempre affetti da un certo sciovinismo, non ha visto ancora una traduzione italiana (salvo una pubblicazione locale limitata alle pagine senesi).
«Piero ha dipinto la Resurrezione, o per meglio dire Gesù che esce dal Sepolcro. Così Borgo sembra derivare il suo nome proprio dall’ammirevole opera del suo pittore. Questo affresco è senza dubbio l’ultimo cui Piero abbia messo mano. Doveva avere allora dai settant’anni in su. Non c’è dipinto che non sappia meno di vecchiaia. Una forza intatta e una altrettanta sicurezza. Una indomabile energia che si possiede e nessuna debolezza da temere. Il genio è più vigoroso, addirittura più insolente che mai; e il pensiero magnifico. Un tale capolavoro non ha altri equivalenti che la Crocifissione sublime di Grünewald a Colmar: vi si contrappone, polo a polo, come il mezzogiorno al nord, e il giorno alla notte. Piero è proprio il figlio nobile della città del Sepolcro. Crede alla resurrezione e all’immortalità. La sua fede sembra certa, piena di autorità e di calma violenza. Il Salvatore è un guerriero. Al termine della notte, scaturisce dalla tomba, la croce in pugno, come uno stendardo, come una lancia. Il suo gesto è quello di un atleta, la sua taglia quella di un gigante. Sotto il sepolcro aperto, i soldati di guardia dormono. Il più vigilante di tutti, che dovette cedere alla fatica per ultimo, il torso dritto, addossato alla tomba, si è assopito con la guancia a contatto con la sua lunga lancia, che serra tra le mani. E il piede del Cristo, che sale a questo primo grado della resurrezione, tocca quasi la barbetta all’angolo del legionario addormentato. Il loro Dio resuscita, e questi non vedono niente, non intendono niente. Veri fedeli, veri soldati.
Potente e sofferente, Gesù è terribile. Nel Giudizio universale, Michelangelo se ne è ricordato. Il suo sudario è un’armatura, il furore gonfia le pieghe di questa toga. Il piede sinistro in aria, che preme il bordo del sarcofago, il ginocchio a squadra, egli sta per salire in cielo con un solo slancio, rischiando di schiacciarsi prima sulla terra; il medesimo slancio anima il suo braccio armato dello stendardo. Il volto ha visto la morte, mantiene le tracce del supplizio. Che vittoria dolorosa. Ma il movimento totale della forma cancella ogni sentimento di dolore: il corpo di questo atleta è quello di un vincitore infallibile. Egli occupa il centro del dipinto. La figura parte dal suolo, ove il piede destro preme ancora la pietra del sepolcro, per andare fino al cielo tempestoso, che tocca la croce dello stendardo. L’intero paese, alberi, cielo e montagne, corre dietro al Cristo. I giochi d’ombra e di luce, forse per la prima volta nell’arte del dipingere, danno un’anima e un canto all’ora dell’alba, tra la notte e il giorno, che è l’ora più da brividi tra tutte, quella irreale e tragica della resurrezione».