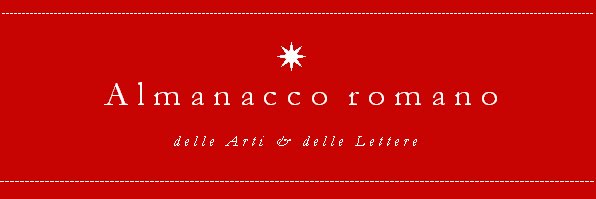~ LA VISIBILITÀ DEL DIVINO E LA PITTURA ESTREMAMENTE FISICA SUGLI ALTARI. ~ PARLANO I TEOLOGI ~
Mortificazione: i corpi senza bellezza erano un’afflizione monacale, una penitenza per gli occhi, una severa concezione religiosa, prima che diventasse un exploit nichilista presso i nostri contemporanei. Immagine interiore spogliata di carnalità, disseccata asceticamente, flagellata nelle sue morbidezze estetiche. Non che non fosse altrettanto religioso l’afflato che metteva in scena gli umani simili a dèi – metafora per dire in linguaggio sofisticato l’espressione biblica «a sua immagine» –, anzi sembrava quella splendente rappresentazione il coronamento del cattolicesimo romano dopo secoli di influenze orientali, platonismi e bizantinismi, che avevano tentato di soffocarlo, di smaterializzarlo. Finalmente, giunti all’Umanesimo, ci si misurò con la propria tradizione e la si convertì sia pure con non poche mirabili contorsioni alla religione di Cristo. Solo che simile tentativo ebbe sempre le sue opposizioni e resistenze, talvolta finite in eresie, talvolta in correnti locali, il cattolicesimo riformato dallo spirito tridentino essendo rispettoso di antiche tradizioni, come appunto quella lombarda di rito ambrosiano, pur nell’organizzazione ferrea della fede e della liturgia.
Il Caravaggio sembra venir fuori dalla cultura borromaica, che ebbe come capisaldi le Schole bresciane e bergamasche, che puntava a un realismo al limite del grottesco, che si rivolgeva all’«osservatore devoto». Il pittore si prodiga nella più religiosa delle missioni, almeno per il suo tempo: rendere l’immagine del divino in forme umane. Scrive Jean Clair: «Scegliere di dipingere la Vergine Maria con i tratti di una ‘vergine tra i palafrenieri’, mutuati da quelli di una mendicante, oppure di dipingerla morta come dice il Baglione, ‘col corpo gonfio e le gambe scoperte’, significa partecipare alla stessa idolatria umana, troppo umana, secondo la quale ciò che non si può guardare in faccia, ossia il sacro, l’invisibile, viene antropomorfizzato: anziché far vedere l’invisibile, si tende a convincere che questa potenza del buio e del terrore, attraversata da lampi, è di fatto la prossimità, il quotidiano, l’immediato. […] Questo antropomorfismo totalitario della Controriforma, espresso nella assoluta visibilità delle cose, è sostenuto da un teologo […]. Ignazio di Loyola, fin dalle prime pagine dei suoi Esercizi spirituali, ordina al lettore la ‘composizione visiva del luogo’ (compositión viendo el lugar) in termini che sembrano, come afferma Italo Calvino, istruzioni per la messa in scena di uno spettacolo: ‘nella contemplazione o meditazione visiva, come appunto il contemplare Cristo Nostro Signore in quanto visibile, la composizione consisterà nel vedere con la vista dell’immaginazione il luogo fisico dove si trova la cosa che voglio contemplare. Dico il luogo fisico, come per esempio un tempio o un monte dove si trovano Gesù Cristo o Nostra Signora’» (Medusa, Milano, 1992, pp. 104-107)
Il cardinal Tommaso de Vio, noto come il Caetani, già generale dei domenicani, austero difensore della spiritualità, entrato nella narrazione storica in qualità di inflessibile inviato del papa in Germania che chiede a Martin Lutero di ritrattare tutto, senza alcuna concessione, avrebbe potuto intrattenersi col frate saccente sulla questione delle immagini, chissà che non si sarebbero trovati in comune accordo. Perché il porporato di Gaeta era pieno di scrupoli sulla rappresentazione della maestà di Dio e giudicava sacrilego l’antropomorfismo, concedendo qualcosa al metaforico, per cui sarebbe meglio dipingere «una nube da cui sorgesse la Creazione in modo che il popolo comprendesse che Dio non è rappresentabile». Ma i papi – racconta Besançon, che mette a confronto i due personaggi – preferiranno il gesuita Francisco Suarez che ricorderà come Dio si sia manifestato spesso sotto forma sensibile. Perché dunque non dipingerlo nelle medesime forme? Nel frattempo c’era stato il Concilio di Trento.
Giovanni Bonanno, presentando su un giornale cattolico il suo libro Pittura, sacralità e carne nel Rinascimento e nel Barocco (Electa), ammette: «Sarebbe assurdo negare nella pittura dei secoli XVI e XVII la fragranza voluttuosa di angeli e santi, avallata da una teologia ardita, come quella dei gesuiti, che consente nella volta del Gesù di Roma l’apparizione della carnalità quale sacramento. Se in non pochi ambienti imperversa la sessuofobia, nella cerchia degli umanisti e dei biblisti è considerata consustanziale alla beatitudine la corporeità, senza la quale non potrebbe esserci né vita né grazia. Da qui scaturisce il sentimento sacro dei corpi e la visione delle Sante e della Vergine, nei cui volti gli artisti esprimono l’idea suprema della bellezza […] Soprattutto il Barocco non nasconde l’incanto della natura, sapendola opera di Dio. Anzi ne recupera il senso trascendente, esaltando il corpo come epifania del mistero. Con maggiore o minore penetrazione, tra il XIV e il XVII secolo, la pittura sacra, rifuggendo spesso da estetismi illustrativi, si connota di una teologia della carne, inquieta ed eroica, che testimonia come gli artisti si sentano poeticamente esegeti del Verbo, mentre ne traducono la presenza in immagini umane».
Pittura oscura dell’alma inquieta. Un epigramma sul Caravaggio dal suo estimatore Marzio Milesi (ritrovato da Giorgio Fulcro): «Quel che suol dare a mille forme vita / si vide a vivi corpi anche dar morte. / Stupì Natura, che se morte e vita / rend’ella, e questi anch’ei dia vita e morte». Giovan Battista Marino lo cantava quale creatore del proprio doppio, quale vivificatore del ritratto, autore di figure con un’anima in guisa quasi divina o senza quasi, qui è colui che rappresenta anche la morte, colui che dà vita e morte, assassino pittorico piuttosto che per vicende biografiche. E si noti il chiasmo vita/morte su cui le rime son costruite, non limitandosi ad alternare i due fulcri in fine verso.
Nel suo saggio sull’erotismo Bataille scriveva: «Oscenità significa […] uscita dalla condizione dei corpi». Augusto del Noce chiosava sinteticamente: «il diavolo simia Dei». Cominciava la danza gnostica moderna, la negazione della fisicità umana, l’allontanamento dall’arte del Caravaggio. Non sarà un caso allora che oggi il pubblico più ingenuo si affolli a sgranare gli occhi su quei corpi resi in pittura, sulla grazia misteriosa del realismo, sullo splendore miracoloso del visibile. Che cosa gli importerà allora dei cataloghi – come quello della mostra alle Scuderie – dove il curatore si imbroglia con il termine ‘democrazia’, che cosa saprà dei discorsi ideologici che hanno tentato di fare del giovanotto lombardo – fiero e irruento, con tanta dottrina artistica e cristiana, appresa nel profondo Nord di allora – un militante insolente di altri e più sordi realismi, virati nel materialismo ateo? Nell’epoca iconoclasta ci si incammina verso le figure sacre caravaggesche come si processiona verso la Sindone, invertendo tutte le teorie estetiche contemporanee, a cominciare da quel rictus che le sovrasta, riso forzato in una smorfia malata, ma anche alcuni pregiudizi teologici, venerando un’immagine, mostrando somma curiosità per l’aspetto esteriore del Messia. Se nei secoli medioevali si ricorse alla mediazione celestiale della tradizione degli acheiropoietai, mani estranee all’umano, angeliche, o per impronta diretta del divino sulla trama del lino, dall’epoca moderna in poi le mani umanissime dei pittori faranno da mediatori con la Rivelazione. Il Caravaggio sarà uno di loro, principe degli iconoduli.
Non temette infatti i corpi la Chiesa romana, nonostante certi equivoci, e già alcuni teologi medioevali come Pietro Lombardo mettevano in guardia sul fatto che la vera idolatria era quella dell’immagine mentale: «Idolum enim hic appellat speciem quam non vidit oculos, sed animum sibi fingit», il peccato consiste dunque nell’evocazione allucinatoria del fantasma, dell’immagine mentale, forse nel «disegno interno» della teoria manierista, non certo nel pittore del realismo. È singolare che i nostri contemporanei, pochissimo addentro alle cose ecclesiastiche, si affannino nel mostrare Michelangelo Merisi quale pittore anti-cattolico, mentre semmai altri, più fantasmatici artisti, alcuni spettrali seguaci della maniera per esempio, rischiarono di precipitare nell’eterna eresia gnostica. Lui se ne stava fedele alla carne e alla incarnazione, a mostrare in umanissimo linguaggio il mistero, certo rischiando non poco – ma non era il primo – di suscitare pensieri lascivi anche intorno alle persone sacre per via delle nudità con le quali son rappresentate. E ci si immagina che solo la pittura del Caravaggio provochi timori, che appaiano di uno scandaloso mai visto i suoi san Matteo e la Madonna sul letto di morte, mentre già i trattatisti medioevali discutevano di casi consimili, raccomandando circospezione non riducendo a censura.
Quando leggiamo gli storici dell’arte che considerano ‘luterani’ i pittori estranei alle mollezze romane, ‘spirituali’ come i due Michelangeli, vengono in mente le parole del rabbioso frate agostiniano che nel migliore dei casi non riteneva «cosa buona» collocare un quadro in chiesa, dannando o comunque limitando notevolmente il mestiere dell’artista. Anche la Vocazione di San Matteo insomma non sarebbe stato accettato dai riformati, anzi proprio per il carattere umano troppo umano avrebbe avuto il bando dalle chiese evangeliche, secondo la predicazione radicale di Carlostadio Von Abtuhung der Bylder, mentre Roma se ne adornò. Si potrebbe dunque parlare di ‘superstizione protestante’, di feticismo per il medium verbale a scapito di quello rivolto agli occhi. Soltanto l’orecchio sarebbe adibito alla Rivelazione, soltanto esso otterrebbe il grado di senso spirituale!
Invece, sul terreno scabro, arato dalle violente parole heideggeriane –Der Ursprung des Kunstwerkes – paesaggio desertico e desolante, dove le ‘scarpe’ di van Gogh ci dicono povere cose, accorrono mille ciarlatani a contrabbandare boutades per arte.
Un altro lombardo avvinto alla speranza cristiana nella carne, Giovanni Testori, tornava sull’incandescente intreccio arte/vita del pittore per celebrarlo addirittura come una figura biblica: «i fatti e le realizzazioni della cultura» venivano precipitati «nell’abbraccio mortale in cui non poteva (e, in effetti, non poté) non risolvere il suo modo di vivere e partecipare la realtà», così come rilevava una «impossibilità, cieca e demente, a uscir dai nodi, per lui assolutamente esaustivi, della materia e della carne». Perciò la critica testoriana ai caravaggeschi che «presero i risultati del Caravaggio come stilemi d’un metodo, senza capire che, non tanto di risultati figurali si trattava, quanto d’atti tragicamente testimoniali. Se questo è vero, quale forma risulta meno riproponibile e metodologizzabile della sua?». Tale forma infatti, a parere dell’altrettanto tragico scrittore cattolico, è ‘sformata’ dalla sua vocazione, e questa a sua volta non fu forse «quella di pronunciare, in pittura, la parola (l’immagine) che non è più solo parola, che non è più solo immagine, e dunque d’adire i termini, privi d’ogni contorno, che son proprii alla profezia?» (Caravaggio e il disegno: una proposta in Fra Rinascimento, Manierismo e Realtà, Scritti di Storia dell’arte in memoria di A.M. Brizi, Firenze, 1984).
E Michel Butor, con la precisione ossessiva del Nouveau roman, riprende a dialogare con Marangoni sull’altra sponda, quella della forma che si sottrae all’esistenziale: questi «opponeva il Canestro alle nature morte fiamminghe del XVI secolo, facendo osservare in esse la scelta di esemplari ‘giganteschi’; potremmo dire voluminosi. Come si può accentuare l’impressione di volume data da un frutto? Innanzitutto situandolo in uno spazio misurato con l’aiuto d’una scacchiera per esempio, ma anche scegliendolo particolarmente liscio e di un colore particolarmente unito, ‘perfetto’ in tal senso, una mela tutta rossa o tutta gialla, senza la minima macchia, poiché, in questo caso, tutte le differenze di tonalità o di valore saranno interpretate dall’occhio come indicazione di rilievo. A contrario, le macchie e gli appassimenti della frutta del Caravaggio compensano la sua voluminosità, l’aiutano a inserirsi pienamente sulla tela». Finché così scrutando i molti aspetti tecnici di quel realismo, Butor approda a una conclusione che insiste sul sacro ma attraendolo nella moderna, sperimentale, Ver sacrum: «l’attenta analisi di questo Canestro, qui solo abbozzata, ci riporta alle soglie di un immenso problema, quello del posto che possono occupare tali nature morte nell’evoluzione religiosa e mentale del XVII secolo e di tutta l’epoca moderna, del loro ruolo. Si vede bene a qual punto si trova giustificata l’osservazione del Longhi che si rifà alla citazione del marchese Giustiniani, appena ritrovata, secondo la quale il pittore proclamava: ‘[…] ed il Caravaggio disse che tanta manifattura gli era a fare un quadro buono di fiori come di figure’, affermando, a proposito di questo Canestro, che dal contatto della luce e dei vegetali si sprigiona un dramma ‘dello stesso ordine’ di quello delle grandi composizioni sacre’» (Saggi sulla pittura, Milano, 2001).
Per non costringere il povero pittore cinque-seicentesco nella tortura della modernizzazione forzata – ché quella libera e non suppliziante è l’affinità che si impone con i nostri più intimi umori e pensieri – , si vogliono riportare i pareri del cardinale Gabriele Paleotti, teorico della Controriforma, sulla pittura nell’età del Caravaggio. È l’ultimo dei «giudizi sghembi» della nostra piccola antologia, tratto dal celebre Discorso intorno alle immagini sacre e profane, che tendeva a risolvere nel realismo, o quantomeno nella verosimiglianza, i problemi della rappresentazione sacra. Perfino la prospettiva – respinta come diabolica dagli spiritualisti dell’ortodossia russa – sarà pienamente accettata da Roma per via del verosimile. In tale direzione, Paleotti criticherà anche i pittori che si rifanno ad altri maestri, che copiano i modi precedenti, nel citazionismo manierista, invece di procedere nel sano e ortodosso realismo; noi esteti dimentichiamo spesso che la novità che maggiormente suscitava scandalo era quella in materia di fede non della forma pittorica.
Nelle ultime righe citate qui sotto compare addirittura la condanna di ogni trasfigurazione, della metafisica luccicante appiccicata alla scena terrena, compito del pittore essendo l’«imitare le cose nel naturale suo essere e puramente come si sono mostrate agli occhi de’ mortali». È una buona copertura teologica d’ogni quadro del Lombardo. Quando poi parla dell’«acerbità de’ flagelli» e di tanti altri dettagli della pietà popolare, come non pensare alle tele caravaggesche anche per le fonti, non sempre evangeliche quanto della letteratura minore. Pressappoco nei medesimi anni, il gesuita Roberto Bellarmino, attaccando il nemico protestante, gli eretici cui erano dedicate le sue Disputationes, tornava sulla rappresentazione realistica che riesce a ricreare la presenza anche di chi è lontano: «chi infatti ama, volentieri guarda l’immagine dell’amico assente e, guardando, più si infiamma», esclamava il santo teologo. Pascal avrebbe scritto: «Figure porte absence et présence, plaisir et déplaisir».
Paleotti, Discorso sulle immagini sacre e profane (1594)
[…] Essendo assai manifesto, e per sé stesso e per le ragioni dette di sopra, di quanta importanza siano le immagini cristiane per ammaestramento del popolo, non ci saressimo noi stesi più oltre intorno a ciò, per fuggire la supefluità, se non ci spignesse la proterva importunità degli eretici, che con tutto ciò ardiscono pure di biasimarle, sforzandosi di bandirle da ogni luoco, come nocive alla salute degli uomini.
Alla quale impietà se bene si cercherà di farsi incontro al luogo suo, nientedimeno ora, con la occasione di quello che si tratta, che è di mostrare l’utile grande che ne riceve il popolo per sua disciplina, non possiamo lasciare di ricordare che il levarle dall’uso degli uomini serìa come esercitare un’ingiustizia estrema verso infinite persone, e forse la maggior parte del popolo cristiano: non solo perché si verria a privarli di quel modo della natura concesso a ciascuno, che mediante il senso si possa venire in cognizione delle cose necessarie; ma anche perché, sendo ognuno obligato, secondo i teologi e sommisti, per la salute propria di sapere esplicitamente gli articoli della fede, e, non sapendoli, non possono avere l’assoluzione sacramentale, come inabili alla grazia; saria bisognoso che quelli, che aborriscono le immagini, insegnassero in che modo si dovrà provedere alla salute di infiniti poverelli, che non sanno leggere, né meno con parole si possono far capaci di misterii necessarii alla salute.
E certo è che per via di questa pittura communemente usa la santa Chiesa in tutti i luoghi della cristianità di soccorrere alle infermità loro, perché, dichiarati che li sieno almeno rozzamente gli articoli della fede, per mezzo poi della pittura più facilmente li capiscono e li conservano a memoria. […] Ma di più anco: se è lecito di predicare il misterio della Passione e la vita d’un santo, perché non sarà permesso parimenti il poterla con figure rappresentare? […]
È però d’avvertire che non ogni cosa incerta, narrata nondimeno o dipinta come certa, rende subito lo autore di essa temerario; perché ciò non ha luogo quando quello che si narra o dipinge è accompagnato da molta probabilità et insieme è atto a muovere il cuore et eccitare divozione; sì come veggiamo che sogliono le persone contemplative e predicatori nella passione di Nostro Signore narrare molte cose che non si trovano scritte negli Evangelii: come dei lamenti della Madonna, dei prieghi lunghi fatti da N.S. nella orazione nell’orto, della acerbità de’ flagelli, delle parole obbrobriose usate lì da’ Giudei, et simili altre cose che si raccontano per muovere più l’affetto et intenerire il cuore. Le quali narrazioni o pitture, se saranno congionte con giudicio e verosimilitudine, scanseranno i predicatori e pittori della temerità […].
Diciamo che essendo l’officio del pittore l’imitare le cose nel naturale suo essere e puramente come si sono mostrate agli occhi de’ mortali, non ha egli da trapassare i suoi confini. […] Altrimenti serìa un confondere ogni cosa e passare tumultuariamente dallo stato della natura a quello della grazia e della gloria; il che ognuno vede che si potria fare medesimamente in tutti i santi, che, essendo stati ripieni de’ celesti doni in questa vita, godevano insieme di mirabile luce e gioia interna: ma poiché le scritture autentiche non dicono che da alcuno siano mai stati veduti in tale trasfigurazione, non pare che convenga al pittore ora di introdurla […].
(da La Chiesa e le immagini. I testi fondamentali sulle arti figurative dalle origini ai nostri giorni, a cura di Daniele Menozzi, Cinisello Balsamo 1995).
(4. Fine)