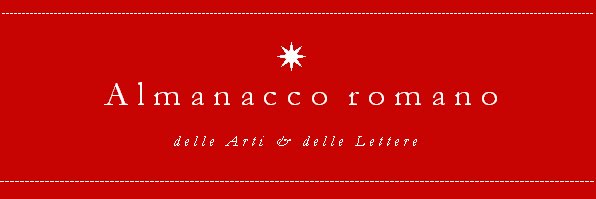~ LA SFILATA DEI SATURNINI
PER NOBILITARE LE AVANGUARDIE~
Il 7 di maggio si cita l’allegra invettiva di Raffaele La Capria contro i concettualizzatori che soffocano l’arte con astrattezze scoraggianti, spesso nient’altro che tautologie, e subito una lettrice amica evoca la «barrueca» a stretto giro di posta: «… In fondo già i barocchi erano grandi concettuali, creavano opere bellissime e dense di parole e pensiero. Chi meglio di loro ha introdotto noi contemporanei dentro l’allegoria? (così diceva il maestro Benjamin nella sua tesi sul teatro tedesco…)». C’è davvero qualcosa in comune tra il concettualismo di Piero Abelardo, il concettismo dell’«agudeza», l’«arte de ingenio» seicentesca, e i nipotini di Magritte che ostentano cogitazioni trite, prescindendo dalla forma? L’inventio diventa monopolizzante, «Sola Inventio» è scritto nello stemma vacuo degli snob. Ha ragione Paul Valéry, «le moderne se contente de peu», appena di assonanze, di ombre cinesi, di allusioni colte, nient’altro che decorazioni della vita per soddisfarsi.
Questi sparsi pensierini rimandano a una più polposa arte e sono dedicati a M. C. che li ha messi argutamente in moto.
Benché si registri qualche eccesso tra i marinisti, non si tratta di eccentrici per amore di eccentricità, per suo unico fine, come i neoavanguardisti di ieri e i ‘contemporanei’ tout court di oggi. Epperò si legge in Ludovico Muratori (Della perfetta poesia), appena tramontata la moda: «Oltre a ciò confesseranno i Franzesi anch’essi, che la lor Poesia non è tanto da magnificarsi, come se il Gusto cattivo allignasse ora in Italia, e non punto in Francia; e quasi piacessero ne’ tempi addietro alla sola Italia, non alla Francia le Argutezze, gl’Equivoci, i Concetti falsi, e il raffinamento nei pensieri. Questo diluvio fu universale in Europa, né da esse furono esenti la Francia, la Spagna, l’Alemagna, essendosi vedute nel medesimo tempo sommerse ancor quelle Provincie dalla piena de’ falsi Concetti. […] so che Lope de Vega, promotore di tal gusto, nacque fra gli Spagnoli, prima che fra gl’Italiani venisse alla luce il Cavalier Marino, Poeta da noi considerato come il primo che mettesse in riputazione le arguzie viziose, e i falsi Concetti». Restaurata la visione ‘classica’, «questo diluvio universale in Europa» appariva «vizioso» e ci si rimpallava l’accusa di aver introdotto per primi un simile cattivo gusto, una parentesi tenebrosa nella storia solare delle belle arti, un episodio da dimenticare. Soltanto i tedeschi, privi per secoli di pittura e di scultura memorabili, potevano andare a rovistare per primi in quell’epoca biasimata e rovesciare i suoi caratteri tetri in segni di gloria. Non stiamo parlando, ovviamente, dell’arte romana di un Bernini quanto delle germaniche e lugubri opere letterarie e pittoriche (la musica barocca fiorì fuori tempo). Comunque, l’arte della Controriforma è abbellimento del vero, mancano invece nell’intellettualizzazione contemporanea sia l’abbellimento che il vero.
Walter Benjamin in quel suo saggio intraducibile sul Trauerspiel non accennò a Racine o a Corneille, i giganti latini che mettevano in soggezione i tedeschi. Malinconicissimo contemplatore, quando pensava agli angeli non incontrava le splendide creature di Melozzo da Forlì o di Lorenzo Lotto bensì il mostruoso essere raffigurato da Klee con il titolo Angelus Novus, messaggero della post-bellezza, essere umano che declina nell’animalesco.
Esoterismi e complicazioni di origine cabbalistica, da dove derivava l’onnipotenza dell’allegoria, sono alla base di quel trattato che si vuole messa in scena delle avanguardie (del surrealismo soprattutto). Poche pagine, quasi un tratto di penna politico, per cancellare in nome di reperti polverosi seicenteschi la storia dell’arte, i trionfi della tradizione occidentale, qui risucchiati da Saturno, illividiti da un incontenibile lutto: la felicità cui aveva sempre alluso l’arte doveva quindi perdersi, sembrare anzi una ingenua e pacchiana pretesa davanti al tribunale degli intellettuali cervellotici. La aspirazione totalizzante della ideologia invadeva prepotentemente il campo estetico trascurando la tecnè, mettendola tra parentesi come sempre fa di fronte ai dettagli realistici che scompongono i suoi schemi.
Per Benjamin il barocco, come più tardi il romanticismo non costituisce «un correttivo del classicismo quanto dell’arte stessa». Ben più eccentrica del solito binomio barocco/romanticismo – che talvolta poteva diventare gotico/barocco/romanticismo, secondo l’articolazione tedesca – una frase che proviene dal tumultuoso periodo di Weimar, di Werner Kohlschimidt: «Gli antichi come simbolo della catastrofe: questo è il fatto nuovo; perché non è più questione di rifiuto, di ostilità ai classici. Qui si tratta di affinità, addirittura di adeguazione esistenziale al mondo classico». Giusto per dire della febbre alta, del delirio con il quale ci si accostava al mondo della tradizione aurea.
Allegoria della morte: l’operare delle avanguardie non sarebbe altro che il rito di creature senza speranza. Alcuni, tra i più fini interpreti dell’oscura trama benjaminiana, negando i riferimenti metafisici – se non nella terminologia tradizionale – sono concordi sull’allegoria della morte e la collegano addirittura alla meditazione heideggeriana di quegli anni sul finito.
Benjamin ripeteva il luogo comune tedesco, dai romantici ai novecenteschi: «la profondità appartiene solo all’uomo triste». Come in un’eco, scriveva Curtius in una lettera del 1921 a Carl Schmitt: «Essere felici è una deficienza morale». Non riguarda il pensiero heideggeriano questa melancholia ma il suo gergo (che Adorno derideva), le pose che si davano gli ‘esistenzialisti’ (quasi si trattasse di un movimento), gli afflitti panofskiani, i warburghiani ansiosi, i foschi tedeschi immersi nelle scenografie di Albert Speer. La tristezza dell’uomo naturale, dell’animale del post coitum, senza la luce della redenzione pur sempre cercata dal povero W. B. Oppure il cristianesimo angosciato di Lutero.
Cercare modelli artistici nella Germania spossata dalla Guerra dei Trent’anni, nella Germania affamata, dissanguata, annichilita, spettrale, è proprio un bel paradosso. Alla ricerca di spettri legnosi. Né si dimentichi che il mondo germanico volle a un certo punto della sua storia, ovvero nel punto più felice, mescolare Barocco e Romanticismo esploso in una sola corrente anti-latina, che ogni tanto sembrava irrompere sulla scena europea eternamente ‘classica’, fino a trasformarsi un secolo più tardi nella lava espressionista. Il malinconico si disperava così nel grottesco. Benedetto Croce, nella sua Postilla alla Storia dell’età barocca in Italia giustamente ricorda questo barocco metastorico che si agitava nelle acque tedesche – non tralasciando di mettere in rilievo un certo «etnicismo» che vi galleggiava, radici e sangue germanici, nella Kultur anti-classica – e gli opponeva una definizione positiva, precisa, della storia dell’arte e dei suoi stili.
Dietro al barocco riscoperto da Benjamin c’era pure la battaglia brechtiana contro l’empatia, contro l’Einfühlung, contro la simbolica. Già lì si riapriva la porte all’allegoria. E si ricordi inoltre che nel 1888 Heinrich Wölfflin aveva rimesso al centro della storia dell’arte moderna la «questione barocca», anche per «la diretta suggestione di quell’insieme di tendenze artistiche per eccellenza moderne dell’inizio del nostro secolo, che per semplificare possiamo designare espressionistiche». La forma «aperta» che si oppone al Rinascimento, all’italico Rinascimento, un’apertura alla trascendenza vs l’autosufficienza, la terrestrità, il paganesimo del Rinascimento romano. Gotico e Barocco scelsero le forme aperte, secondo Wölfflin. Poi, in letteratura, Fritz Strich, in concomitanza con la suggestiva narrazione spengleriana: l’uomo tedesco è gotico e barocco, igitur faustiano.
In un articolo di Roberto Longhi su I pittori futuristi (in «La Voce» del 10 aprile 1913), appare tutt’altro discorso, si mette in evidenza il legame strettissimo delle stagioni della storia dell’arte, né vi sono preoccupazioni religiose, timori del paganesimo, la Catholica avendo considerato sue creature il Rinascimento come l’arte della Controriforma: «Il Barocco non fa che porre in moto le masse del Rinascimento: la liscia facciata di chiese, una tavola di pietra spessa e robusta s’incurva pressa da una forza gigante. Al cerchio succede l’ellisse. Cerchio è staticità abbandono riposo. Eclisse è cerchio compresso, energia all’opera, movimento».
Ai luttuosi barocchi germanici, ritrovati ed esposti nelle bacheche cabbalistiche di solitari pensatori ebrei con l’allure dell’antiquario, si contrappongono gli aurei barocchi latini, il Góngora che pure quando scrive i sonetti funebri «parla assai poco della morte e del morto», tutto è «sontuosità, magnificenze, splendori, sotto la luce del mezzogiorno» (Jorge Guillén).
La volontà benjaminiana di ricorrere alla allegoria come ai motivi religiosi e teologici per trascinarli – sulla scia di von Baader ma anche di Carl Schmitt (della Politische Theologie che tanto amava) – nell’arsenale politico rivoluzionario, nella fattispecie marxista (e forse anche questo fortino fu costituito per ingannare il piatto materialismo, dunque un altro trompe-l’oeil), trova il suo limite nell’impossibilità di staccare tali allegorie dal mondo della tradizione. Come insegnava padre Giovanni Pozzi da Locarno, un maestro nel campo delle comunicazioni miste di parole e immagini, ricordando una sua visita alla collezioni di imprese dell’Accademia della Crusca nel 1949-50 insieme a Gianfranco Contini: «Coltivavo allora qualche velleità di attività figurativa, orientata verso una natura morta un poco ‘metafisica’ che non manca in queste pale, il maestro redarguiva: questo è il p. Pozzi Novecento tiri fuori il p. Pozzi Seicento». Il cappuccino erudito capì l’antifona e poté scrivere sulle imprese: «All’origine di questo fenomeno così singolare stanno più motivi concomitanti: il trasferimento di formule liturgiche (anamnesi ed epiclesi) a realtà mondane; il diffondersi capillare di quella specie di idolatria che caratterizza ogni società dominata dall’idea autoritaria; l’imporsi di un modello unico di perfezione; l’acquisizione di un rituale esemplato sulla fonte più autorevole; la corte celeste e la corte degli dèi in terra. Ma sta soprattutto l’immobilità di quel materiale che si cristallizzò intorno alla simbolizzazione del cosmo come gran significante visibile di fatti invisibili: infatti, se la base dottrinale subì nei secoli molte fluttuazioni, le equivalenze metaforiche fra la ‘res’ e i significati, una volta acquisite, sopravvissero fino in fondo. Non è un caso che l’impresistica sia morta quando si sfaldò quella dottrina. Metafore visive di questo tipo sono ormai tramontate per sempre sul nostro orizzonte» (da Imprese di Crusca in Sull’orlo del visibile parlare, Adelphi).
Adorno riteneva che Benjamin trattasse un testo letterario alla maniera con la quale i commentatori medioevali si misuravano con la Bibbia. In effetti, più che le Sephirot, sembra che sia il misticismo romantico a stendere una coltre nebbiosa sul Dramma barocco tedesco. Sullo sfondo della scena c’era il Kunstwollen, un altro termine oscurissimo dei moderni, un altro modo, come l’Inconscio, forse per dire Dio.
All’opposto del nostro barocco, Benjamin scrive: «L’aldilà è svuotato di tutto ciò in cui fila il minimo alito mondano […] per sgomberare un ultimo cielo e permettergli, come vuoto, di annientare la terra con violenza catastrofica». Apocalisse tedesca, interiore, luterana: un vuoto ci seppellirebbe, minaccia sottile certo per i marchiati dall’horror vacui che però nel cattolicesimo hanno trovato un riempimento speciale, uno spettacolo mondano che esorbita dai soffitti delle chiese controriformistiche e riconcilia il Cielo e la Terra.
Una bellezza geroglifica. Il gesuita tedesco appollaiato al Collegio Romano, Athanasius Kircher, magistrale creatore di una Wunderkammer tra le più attraenti d’Europa (lasciata decomporre dai conquistatori laici della Roma dei papi, andrebbe ricordato l’episodio infame in questi mesi di celebrazione risorgimentale), Kircher dunque distingueva in quel ginepraio di macchine, automi, obelischi, cineserie, installazioni del suo laboratorio magico, più volte visitato da Gian Lorenzo Bernini: la Romània sviluppa le arti formali, la Germania gli aspetti contenutistici. Benjamin sembrava fissare i suoi occhi miopi su quest’ultima, sebbene con grande acutezza. Da quella scuola, del resto, discendeva Aby Warburg e il drappello di studiosi da lui finanziati per interpretare gli enigmi che inquietavano il miliardario ebreo.
Le Origini del dramma barocco tedesco sono un testo apologetico dell’allegoria. Questa vi appare come un residuo misterioso del passato, in assonanza con le rovine (gran voga del revival rovinista in quegli anni, si pensi soltanto a Die Ruine di Simmel), archeologia del sapere. Meno giocoso e luttuoso, piuttosto un disvelamento della verità, il Leo Strauss che indaga nei segreti della scrittura filosofica, ricostruendo il lato ombroso della storia dell’Occidente (Cfr. Scrittura e persecuzione. Nei ludici messaggi cifrati del «contemporaneo» invece la persecuzione è inventata, pare piuttosto un delirio persecutorio). Maschere e inganni che inseguiva anche Freud.
I simboli cifrati dell’allegoria tornavano a scatenare un pubblico di ermeneuti. Dimentichi di quanto anche in casa tedesca aveva detto Goethe, alle soglie del moderno, svalutando l’allegoria come non-arte o arte inferiore. Decadevano allora anche alcuni generi letterari convenzionalmente allegorici: le favole, l’apologo, l’ode politica, i bestiari, gli exempla, ecc. Ormai lontani dall’allegoresi introdotta dai Padri della Chiesa, si perdevano anche le distinzioni ricordate da Auerbach: Allegoria in verbis = opera dell’uomo; Allegoria in factis = opera di Dio.
Trauerspiel: per oggetto la storia e non il mito, l’anti-tragedia classica dunque (anche se la storia, secondo Benjamin – distingueva Cases – è piuttosto «destino» o «allegoria della precarietà d’ogni sforzo umano», e viene in mente l’accattivante canzone brechtiana, il Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens, il suadente motivetto che, rubando le cadenze sapienti del Qohèlet, insiste sulla vanità degli umani sforzi).
Renato Solmi, da una impervia sponda politica, da punti di vista del comunismo d’antan, concludeva il suo saggio esemplare con il quale nel lontanissimo 1959 presentava Walter Benjamin al pubblico italiano, dicendo che le migliori pagine del pensatore ebreo-tedesche che aveva tradotto erano lì come documento non come esempio. Convinto che «le forze che liberano dalla decadenza» non possano venire in soccorso della stessa decadenza. Oggi nel giro infernale del sempreuguale ogni insensatezza appare liberatoria.
Del dramma barocco italiano non si fa più cenno nel nostro dibattere ‘tedeschizzato’, insistendo su quei frammenti germanici sconosciuti e dimenticati anche tra i tedeschi. Eppure a Firenze, già sul finire del Cinquecento, ci si interrogò in modo grandioso sulla interpretazione della tragedia greca, cercando di inserire l’elemento musicale, cosicché gli esperimenti di Giulio Caccini e Jacopo Peri e Ottavio Rinuccini già anticipano di secoli quanto andrà dicendo Nietzsche sulla Nascita della tragedia dallo spirito della musica mentre il dramma Dafne fu la prima incarnazione di tali ricerche. Quindi nel Seicento il matematico pesarese Guidobaldo marchese del Monte pubblica Perspectiva libri sex dedicato alla scenografia prospettica, le invenzioni pittoriche raggiungono il teatro. Lo spettacolo è sontuoso.
Sullo stupore La sfilata dei saturnini cui ricorrevano le avanguardie del Novecento per nobilitarsi, i Pontormo e i Tasso a vario titolo endorserment di un’arte che sarebbe anticipatrice della non-arte contemporanea, non regge alla prova dei fatti. Nelle usanze moderniste che provocano lirismi a buon mercato, nella festa della faciloneria, delle boutades d’accatto, nell’incuria per la forma, nell’onirico sempre uguale, nell’inconscio balbettante – tutti caratteri del carnevale triste che si snoda nel Novecento più accidioso, nelle stagioni che seguono gli eventi cruciali e drammatici – che maggiormente caratterizzano, quasi in tinta folclorica, la dissoluzione dell'arte, ci si richiama non solo ai drammaturghi funerei della Germania ma soprattutto ai grandi e ben più celebri retori del Siglo de Oro spagnolo. Nella moderna ispanistica avanza tuttavia qualche serio critico a precisare con rigore: «l’opera di Quevedo – scrive per esempio l’indimenticabile Vittorio Bodini – è stata stranamente sopraffatta dal simbolo invadente offertoci dal suo personaggio, e dal suo ingegno troppo energico e contraddittorio» (Prefazione all’edizione italiana dei quevediani Sonetti amorosi e morali, Einaudi, 1965). E il traduttore pugliese, benché a sua volta poeta futurista e sensibile alle avventure surrealiste, a proposito di Quevedo parla a ragione di «estremismo stilistico», di «cupa grandezza di lirico», di «disperata gravità» che lo allontana nobilmente dai giochi vezzosi dei nostri contemporanei. Precisando poi con ammirabile sintesi: «il culteranismo persegue un oscuro linguaggio da iniziati mediante neologismi, cultismi, industriose inversioni di parole e soprattutto facendo di ciascuna poesia una serie ininterrotta di dense metafore che soppiantano le comparazioni. Le accuse e le burle sulla loro oscurità […] hanno poca presa sui culterani giacché un critico ad essi favorevole come Martín Vázquez Siruela definisce quella oscurità necessaria ‘per scostarsi dal volgo e meritare l’approvazione dei pochi’». Vien qui da pensare a José Ortega y Gasset che nella sua Deshumanización del arte nel primo Novecento tenta un culteranismo intorno alle avanguardie storiche, si illude che i cubisti e le loro elucubrazioni chiudano i musei alle masse incolte, nulla prevedendo delle fiere contemporanee dove tutto – espositori, esposti e visitatori – appartengono alle masse del ‘tempo libero’, ai complici e alle vittime della pubblicità, alle culture reclamistiche, a quella che un tempo ormai lontano fu definita «industria culturale» per somma irrisione e adesso sembra soltanto una descrizione sociologica, se non una lode per l’organizzazione ben salda. Secondo Bodini, al contrario, il ricercar di Góngora nei sentieri dell’insolito non lo aliena da «un caldo e palpitante mosaico sensoriale». Le idee dei culterani sono insomma rivestite di preziosa sensualità, casomai sono i concettisti che posseggono «più idee che parole» (Pfand). Ma appunto il concettista Quevedo, quando si fa poeta amoroso diviene culterano, sempre la veste estetica ricoprendo di una sorta di pudore i più complicati intellettualismi. Né si dimentichi che culterani e concettisti, ovvero i più strampalati barocchi, lavorando sulla poesia si richiamano alla scuola di Petrarca, non allo slang pop. Inoltre la lingua ermetica, concettosa, eccessiva, era pur sempre la loro divisa: la lingua è tecnè, là si pratica l’arte, così come nell’aggrovigliata gabbia della metrica (il bello è l’immagine che fuoriesce da simili incatenamenti; in queste barriere da superare costantemente si sciolgono e si condensano sogni, passioni, ribellioni. Oggi il capriccio è senza limiti).
Del resto, scriviamo e diciamo spessissimo «come è moderno», riferendoci ad artisti e letterati che amiamo: ci confortiamo così in una complicità con un personaggio splendente della tradizione che ci sorregge nelle nostre debolezze, nel deserto del Moderno. Il concetto, gli emblemi, gli arzigogoli, le imprese servono a giustificazione dei retorici oggetti estetici dei nostri giorni che poi si vogliono insignificanti. Perché attribuire al barocco la sfaccettatura del puro niente?
In uno di quei libri germogliati sui sentieri benjaminiani a proposito dell’Europa «irregolare», Il manierismo nella letteratura di Gustav R. Hocke – potrebbe accompagnarsi alle ricerche italiane sull’Antirinascimento di Eugenio Battisti, che nei Cinquanta-Sessanta faceva da sottofondo erudito alla neoavanguardia –, si può trovare in metastorico accumulo l’Ars combinatoria di Raimondo Lullo e i versi di Paul Celan, la magia antica e il gongorismo, gli enigmisti e Mallarmé, rinvenendoci anche una contrapposizione politica, per esempio tra atticismo conservatore e asianesimo moderno e rivoluzionario, mimesis classicista e perciò da dannare per sempre e phantasia oltremodo lodevole e da esercitare ad libitum, ebbene in questo bazar del Manierismo l’autore è costretto a ricordare che Plotino, un grande riferimento per i seguaci della manìa in estetica, ossia per i pazzerelloni d’ogni sorta di sperimentalismo, ammoniva: «La realtà terrena contraffatta e stravolta abbisogna d’essere completata in un’immagine bella, affinché appaia tanto bella quanto in assoluto essa è». Questo il punto su cui insistere quando i teorici del cosiddetto contemporaneo avanzano nobili pedigrees.
Alla fine ci si accorge che nella letteratura e nelle arti tradizionali, per quanto esse siano «irregolari» e precipitate nella vertigine «ingegnosa», c’è una tecnica sempre calcolata e che l’intricatissimo labirinto ha bisogno di un artista-ingegnere armato di somma tecnè.
Se il fantastico diventa la norma
«L’artista del pensiero» si dice talvolta e, certo, rispetto ai protocolli burocratici di molti filosofi attuali, insensibili alla verità e ossessionati dalle definizioni, è un’espressione attraente. Ma Curtius: «Da Platone in poi una eterna lotta divide il poeta dai pensatori. Il poeta è superiore poiché per lui i problemi non si risolvono in concetti ma in forme». (George, Hofmannsthal e Calderón). Talvolta, ai tempi di Calderón per esempio, in forme concettose ma sempre gradevoli ai sensi, purificate dalla durezza filosofica.
Visto che il ricorso all’agudeza di Grácian e del suo gruppo è il Leitmotiv degli apologeti d’ogni aberrazione (nel senso dell’ottica) contemporanea, val la pena riportare quanto diceva uno del cenacolo di quel gesuita spagnolo, Matteo Peregrini, a proposito delle acutezze viziose, cioè dei difetti che poi a maggior ragione caratterizzano la pseudo-arte dei giorni nostri: «Fredde, stiracchiate, fanciullesche, vuote, insipide inette, stolte, niquitose, sfacciate, buffonesche». Potrebbero tali aggettivi scintillare sui cancelli della Biennale e sulle porte di molte gallerie. Toglierebbero il fiato agli argomentatori in malafede.
Tutti gli apologeti di un’arte di soli segni, della meta-poesia, dell’oblio dei ‘contenuti’ si rifanno in un modo o nell’altro a Valéry, al suo insistere sull’importanza del processo creativo. Ma il poeta matematico sapeva distinguere sapientemente tra stupore estetico e sbalordimento da effetto circense [v. in proposito su «Almanacco»: «Marc Fumaroli: viaggio critico nel ‘contemporaneo’»; «Pensieri prismatici di Valéry sull’arte»]. Perciò tentava di rendere la miracolosa epifania della bellezza un mistero non una semiotica.
Prima di Valéry si ricorre a Mallarmé, al suo Libro derivato magari dall’Ars combinatoria di Athanasius Kircher, concepito per letture pubbliche in dieci recite (attingendo evidentemente all’arte totale di Runge [v. «Almanacco» «Il pittore che inventò l’opera d’arte totale»], tutta questa scrittura però – e non è un fatto trascurabile – serviva a riflettere la bellezza, anzi si faceva scrittura totale per meglio riflettere la bellezza del mondo. Un intento che la strappa dalla compagnia di chi vuole sommergere il pubblico con la bruttezza ostentata e gridata, tipica dell’espressionismo e di certi naturalismi.
Ancora sullo stupore. Scriveva Roger Caillois (Nel cuore del fantastico, SE, 1964): «Stupire a buon mercato e simulare il mistero»: potrebbe essere una sintesi di molto Novecento. L’«ibridazione sistematica» di Bosch, ecco un esempio del «fantastico per partito preso». C’è, a maggior ragione si potrebbe dire, il prosaico per partito preso, i temi e gli scontati svolgimenti. Caillois invece si divertiva in quel suo studio sul fantastico a spiegare il misterioso enfatizzato e a gettare un sospetto su pitture apparentemente ‘normali’. In tal modo per esempio spiega l’origine del superlodato Arcimboldo nei miniaturisti che lavorano alle iniziali, sostanziandole di fiori e frutti. Lo stratagemma – sostiene Caillois – è misterioso solo per i pigri. Se il fantastico diviene la norma ecco Bosch; se la desolante ‘provocazione’ diviene la norma ecco il nostro contemporaneo. Altro che lo scandalo inammissibile per la ragione. Tutto è previsto, già visto, come i dibattiti televisivi.
Per pietà, allora, non si ricorra alle fantasiosissime metafore di Góngora per profetizzare il surrealismo, né ci si riduca alle banalizzazioni della storia di chi vuole iscrivere alla setta di Breton il medioevale Bosch: la fede di Góngora e di Bosch li porta a configurare il mondo con l’incanto totalitario, nel puro regno della poesia, nel mondo dei re e delle regine direbbe Novalis. Saturnino appare invece il partito dei surrealisti (Jean Clair l’ha illustrato nel Processo al surrealismo, dove invero ha messo in luce anche i risvolti fascisti, e già Sedlmayr spiegò il fondo malefico di chi predicava l’omicidio come opera d’arte). E poi i Monsù Desiderio sono una spezia nella storia dell’arte, una bottega che fabbrica souvenir sinistri, un cliché pittoresco per invogliare anziane turiste del Nord Europa, una sottospecie piranesiana prima di Piranesi, non un modello per la pittura.
«Il meraviglioso da paccottiglia»: può essere un cartiglio che domina l’imagery dell’arte cosiddetta fantastica, da Barnum al surrealismo, ma sarebbe già un titolo onorifico vederlo appeso sulle opere del nostro «contemporaneo» dove soltanto il denaro senza altra dicitura ne è la chiave interpretativa universale.
Talvolta certi installatori si vorrebbero anagogici dimenticando però l’essenziale: che si può spiccare il volo dal sensibile al celeste soltanto quando la scrittura, la rappresentazione da cui partire, è vera e sacra. Dante in persona ce lo attesta nel Convivio: «Lo quarto senso si chiama anagogico, cioè sovrasenso; e questo è quando spiritualmente si spone una scrittura, la quale ancora [sia vera] eziandio nel senso litterale, per le cose significate significa de le superne cose de l’etternal gloria sì, come vedere si può in quello canto del Profeta che dice che, ne l’uscita del popolo d’Israel d'Egitto, Giudea è fatta santa e libera…». Neppure verosimili sono le installazioni, noi non saremo esegeti di falsi evangeli.
Pittura discorsiva, letteraria, che richiede l’ausilio della parola, di didascalie, anche invisibili: ecco l’inflazione verbale che contrassegna certo manierismo e le avanguardie moderne. Comunque che la parola dipinta e la pittura parlante siano minora è la storia delle arti a dircelo. Il Polifilo di Francesco Colonna, con le sue vignette e rebus, nobilita il genere e i suoi culti appassionati, non lo si mette in discussione neppure per amore di polemica, però non si riduca la storia dell’arte, anche di quel periodo tra il Rinascimento e il Barocco in cui tal genere raggiunse vette eccelse, e tanto meno lo si utilizzi per promuovere le vane immagini senza neppure Witz nello scomposto «contemporaneo» d’oggi.
Metaforicità coatta, tassonomia di astruserie, salotti di fantasie maniacali, l’effetto noioso che provocano non è dissimile da quello che si ritrova nelle più piatte prose. Dopo un po’, questa pernice (l’originale per l’originale) disgusta anche il palato più corrivo e affama, perché di pernice virtuale, senza carne, si tratta. Non nutre la fantasia, titilla l’intelletto, ed è gioco puerile.
Il perpetuo tramutarsi per cui la serva nel Don Chisciotte si fa nobildonna mentre il mondo che le ruota attorno ugualmente si rovescia – è un’antica trovata per muovere il riso e suscitare considerazioni morali, di scuola controriformista, sullo stolto agire dell’umanità. Un’arte – e una teoria sottesa – che tutto voglia ridurre a riso, a parodia, è estremamente snervante e in breve suscita irritazione e dolore.
L’allegoria leggermente delirante di certe incisioni tedesche, anche di parte cattolica, porta a raffigurare la metafora producendo effetti paradossali: una ragazza con il vitino di vespa, espressione verbale quotidiana, diventa un monstrum quando l’incisore rappresenta proprio un corpo di insetto per la ragazza della metafora. Ma allora, si può dire che nell’allegoria basti possedere una chiave interpretativa perché l’incanto si rompa? E se le allegorie restano misteriose, allusioni confuse, dov’è il loro insegnamento che i marxisti della prima metà del Novecento inseguivano con fervore? Qui l’allegorico si confonde con il didattico.
I «metafisici» inglesi del Seicento «sentivano i pensieri come il profumo di una rosa» (T. S. Eliot); tanfo emana il concettuale del nostro tempo che non di pensieri si nutre, men che mai di olezzanti pensieri, bensì di slogan del Moderno andati a male. Ossia, il «barocco fecale» di cui parla Gottfried Benn a proposito dell’espressionismo in cui pure militò.
Si comincia nel Seicento con il tentativo di delectare non attraverso la grazia quanto con il sorprendere, sbalordire, con il raro e il misterioso. Per quella strada non si va lontano. Si gira sempre intorno. La poesia viene mescolata con l’oratoria. Quadri anamorfici. Montaigne, il nostro amato Montaigne, fu saggio anche in tali conflitti estetici e condannò quel mondo «ambiguo, variopinto, facilone» dei concettisti. Eppure chi aveva lubrificato il pensiero umano meglio di lui, chi scritto con maggiore originalità? Senza ricorrere pertanto ai macchinari verbali, alle installazioni ampollose, alla immaginazione sofistica, agli anagrammi, crittogrammi e così via. Montaigne garantiva all’Occidente, assetato già allora di esprit de géométrie un benefico e liberatorio esprit de finesse.
Le «langues imperfaites» di Mallarmé, il «disarmonico morale» di Borchardt e le vestigia allegoriche di Benjamin sembrano coincidere, reliquie per resistere al Moderno. Ma troviamo invidiabile il tono disinvolto con cui Vladimir Nabokov affronta la questione: «L’arte, in un certo senso, è sempre simbolica; ma noi dobbiamo dire ‘fermati, ladro’, al critico che deliberatamente trasforma il simbolo sottile di un artista nella vieta allegoria di un pedante – le mille e una notte nel convegno di una setta segreta» (Lezioni di letteratura).