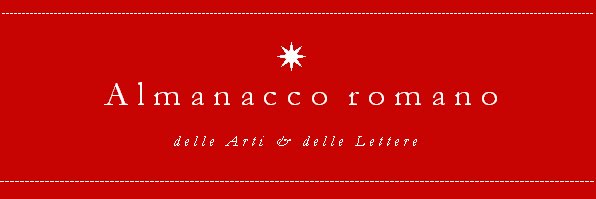~ PERCHÉ GLI SFOTTÒ SULL’ITALIA
NON FINISCONO MAI ~
In casa, l’altro giorno, ci rammentavano l’affaire Méduse, la nave francese arenatasi all’inizio dell’Ottocento sulle coste della Mauritania. Géricault raccontò nei dettagli i tormenti dei passeggeri, la celeberrima Zattera trascinava per mare morti e vivi. Scandaloso fu il comportamento del comando della fregata, se ne discusse a lungo con varie ripercussioni politiche, e l’opera d’arte rilanciò la faccenda, ma nessuno rise, non si trattava di una barzelletta etnica. Lucrezio, nel De rerum natura sottolineava che «Bello, quando sul mare si scontrano i venti/ e la cupa vastità delle acque si turba,/ guardare da terra il naufragio lontano:/ non ti rallegra lo spettacolo dell’altrui rovina,/ ma la distanza da una simile sorte» (II, 1-4), su quei versi Hans Blumenberg meditò a lungo, erano la metafora della vita contemplativa. In televisione non c’è solo l’immane distanza, anche lo spettacolo, per cui se ne gode come al cinema: la scatola davanti al divano è terribile, «fa rallegrare dell’altrui rovina», si tratti del naufragio o degli arrestati in catene, dà coraggio tra i cuscini del soggiorno, superbia morale tra le mura domestiche. Talvolta il triste spettacolo è globale, così gli stolti che pensavano bastassero le dimissioni del Cavaliere dalla guida del governo italiano perché gli stranieri smettessero di sbeffeggiare il belpaese, gli ingenui che erano davvero convinti che il colore politico della coalizione vincitrice alle elezioni potesse allarmare la democrazia europea, i parvenus che sorridevano di ogni gesto poco scontato del Presidente, di ogni violazione delle regole piccolo-borghesi, le maestrine che provavano vergogna per ogni sua paronimia, gli ignoranti che non ricordavano come in pieno Rinascimento, quando nessun posto al mondo era più sublime del nostro, un frate sassone, e con molta eco, ci riempì di insulti, paragonandoci ai peggiori delinquenti, corrotti, blasfemi, sacrileghi, ladri, truffatori, spergiuri… ebbene, tutti costoro son serviti: soltanto «la Repubblica», giornale dei cuori semplici, poteva convincere le pie anime che lo sfottò internazionale sarebbe finito una volta cacciato il tycoon lombardo. Dimenticando che nel Settecento già deridevano la nostra decadenza pur non avendo mai riconosciuto l’apogeo di questa civiltà, che nell’Ottocento disdegnavano l’italica arretratezza trovando qui dei seguaci che sembravano non sapere come fin dai tempi delle loro scorribande i barbari fossero mossi da brama e disprezzo insieme, il che spesso accade; e tutti gli scrittori a disegnarci quali scellerati, a cominciare da Shakespeare, i filosofi a teorizzare la nostra inferiorità eterna, gli uomini della strada a farci il verso, per cui nel primo Novecento il povero Filippo Tommaso Marinetti, appena sbarcato a Parigi con grande vanto d’esser italiano, passava il suo tempo a sfidare a duello i denigratori, i francesi che sputacchiavano spernacchiando nel commentare ogni cosa proveniente dall’altra parte delle Alpi, sulle orme di Stendhal, pur invidiandoci molto come il loro romanziere; più recentemente, i tedeschi ci condannavano per mancanza di valore bellico, maledicevano le alleanze con simili infingardi e intanto, sui campi di battaglia, guadagnano assai poco dalla loro arte militare. Insomma, nient’altro che l’antico odio mal truccato per il paese che non si adatta ai parametri correnti moderni benché abbia inventato la modernità. Oggi è un capitano di una multinazionale delle crociere che fa affondare una nave in un bicchier d’acqua a fornire il pretesto per l’insulto tedesco alla «codardia degli italiani», il che suscita una risposta muscolosa di un giornale milanese, alla maniera dei nazionalisti primi Novecento. I quali a loro volta pretendevano, come un baffuto politico della sinistra, che l’Italia fosse o potesse almeno diventare «un paese normale». Sciocca richiesta, la penisola italiana è irriducibile alle altre patrie. Nostra prima gloria è proprio la mancanza di meschineria sciovinista.
Questo l’antieroismo di cui si parlò spesso e che un giovanissimo Leopardi (forse riecheggiando il padre Monaldo, sicuramente Francesco Petrarca), in uno scritto poco noto, difese con bella retorica: «La nostra nazione riunita tutta sotto un sol capo sarebbe formidabile ai suoi nemici; un popolo, come il nostro generoso e nobile, colle immense risorse somministrate dal suo territorio e dalle sue facoltà intellettuali, potrebbe concepire dei vasti disegni ed ottenere dei grandi successi. Egli fu un tempo signore dell'universo, potrebbe ora gettar dell’ombra su tutte le nazioni. Ma l’Italia sarebbe perciò felice? Per asserirlo, converrebbe supporre che la felicità della nazione consista nella forza delle armi, nell’esser terribile allo straniero, nel poter con vantaggio cominciare una guerra e continuarla senza cedere, nel possedere tutto ciò che fa d’uopo per esser temuta e che è necessario per non temere, nell’abbondanza dei mezzi per sostenere la gloria dei propri eserciti e la fortuna delle proprie armi. Ma se la vera felicità dei popoli è riposta nella pace necessaria alle arti utili, alle lettere, alle scienze, nella prosperità del commercio e dell’agricoltura, fonti della ricchezza delle nazioni, nell’amministrazione paterna di Sovrani amati e legittimi; possiam dirlo con verità, non v’ha popolo più felice dell’italiano». Ai nazionalismi montanti, preferiva infatti la felicità pigra della provincia, la dolce vita che sempre sopravvive alle imitazioni penose dei costumi altrui: «Divisa in piccoli regni, l’Italia offre lo spettacolo vario e lusinghiero di numerose capitali animate da corti floride e brillanti, che rendono il nostro suolo sì bello agli occhi dello straniero. Questa specie di grandezza può consolarci di quella che noi perderemmo. Sì, noi fummo grandi una volta: noi rigettammo quei Galli, che il tempo ha resi più forti, fuori delle nostre terre, noi li cacciammo alle loro tane, noi li soggiogammo, noi li facemmo nostri schiavi. Dalle colonne di Ercole sino al Caucaso noi stendemmo la gloria del nostro nome e il terrore delle nostre armi. Tutto si sottomise al nostro impero, tutto cedè al nostro valore, e noi fummo i signori del mondo. Fummo per questo felici? Le discordie civili, le guerre, le vittorie stesse non ci lasciavano un’ora di quella pace che tutto il mondo sospira. Il tempio di Giano sempre aperto vomitava disordini e sventure. Padroni dell’universo, noi non lo eravamo di noi stessi. Ci convenne conquistare la sede delle scienze per apprendere a regolare le nostre passioni. Terribili a tutto il mondo, noi eravamo, ciò che ora è la Francia […] La nostra grandezza, la nostra felicità deve dunque consistere in fare degli infelici? Italiani! rinunziamo al brillante ed appigliamoci al solido. Quando ci si propone un potere pernicioso o una pace di cui tutto ci garantisce la durata, rigettiamo l’uno ed eleggiamo l’altra: quello ci darebbe dei nomi e questa ci dà delle cose; quello una gloria fantastica e questa dei reali vantaggi. Una nazione non deve esitare nella scelta della sua vera felicità». (Agl’Italiani. Orazione in occasione della liberazione del Piceno, 1815). Però, a quei tempi – come Leopardi osserverà in uno scritto successivo e già di parere diverso, dove si atteggia ad arcigno critico dei suoi compatrioti – ancora dell’opinione pubblica «gl’italiani, in generale, e parlando massimamente a proporzion degli altri popoli, non ne fanno alcun conto. Corrono e si ripetono tutto giorno cento proverbi in Italia che affermano che non s’ha da por mente a quello che il mondo dice o dirà di te, che s’ha da procedere a modo suo, non curandosi del giudizio degli altri, e cose tali…» (Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani). Adesso, come in tutte le epoche della più rovinosa decadenza, si idolatra ogni rabbuffo o sorrisetto o moda o titolo di giornale che venga dall’estero...
NON FINISCONO MAI ~
In casa, l’altro giorno, ci rammentavano l’affaire Méduse, la nave francese arenatasi all’inizio dell’Ottocento sulle coste della Mauritania. Géricault raccontò nei dettagli i tormenti dei passeggeri, la celeberrima Zattera trascinava per mare morti e vivi. Scandaloso fu il comportamento del comando della fregata, se ne discusse a lungo con varie ripercussioni politiche, e l’opera d’arte rilanciò la faccenda, ma nessuno rise, non si trattava di una barzelletta etnica. Lucrezio, nel De rerum natura sottolineava che «Bello, quando sul mare si scontrano i venti/ e la cupa vastità delle acque si turba,/ guardare da terra il naufragio lontano:/ non ti rallegra lo spettacolo dell’altrui rovina,/ ma la distanza da una simile sorte» (II, 1-4), su quei versi Hans Blumenberg meditò a lungo, erano la metafora della vita contemplativa. In televisione non c’è solo l’immane distanza, anche lo spettacolo, per cui se ne gode come al cinema: la scatola davanti al divano è terribile, «fa rallegrare dell’altrui rovina», si tratti del naufragio o degli arrestati in catene, dà coraggio tra i cuscini del soggiorno, superbia morale tra le mura domestiche. Talvolta il triste spettacolo è globale, così gli stolti che pensavano bastassero le dimissioni del Cavaliere dalla guida del governo italiano perché gli stranieri smettessero di sbeffeggiare il belpaese, gli ingenui che erano davvero convinti che il colore politico della coalizione vincitrice alle elezioni potesse allarmare la democrazia europea, i parvenus che sorridevano di ogni gesto poco scontato del Presidente, di ogni violazione delle regole piccolo-borghesi, le maestrine che provavano vergogna per ogni sua paronimia, gli ignoranti che non ricordavano come in pieno Rinascimento, quando nessun posto al mondo era più sublime del nostro, un frate sassone, e con molta eco, ci riempì di insulti, paragonandoci ai peggiori delinquenti, corrotti, blasfemi, sacrileghi, ladri, truffatori, spergiuri… ebbene, tutti costoro son serviti: soltanto «la Repubblica», giornale dei cuori semplici, poteva convincere le pie anime che lo sfottò internazionale sarebbe finito una volta cacciato il tycoon lombardo. Dimenticando che nel Settecento già deridevano la nostra decadenza pur non avendo mai riconosciuto l’apogeo di questa civiltà, che nell’Ottocento disdegnavano l’italica arretratezza trovando qui dei seguaci che sembravano non sapere come fin dai tempi delle loro scorribande i barbari fossero mossi da brama e disprezzo insieme, il che spesso accade; e tutti gli scrittori a disegnarci quali scellerati, a cominciare da Shakespeare, i filosofi a teorizzare la nostra inferiorità eterna, gli uomini della strada a farci il verso, per cui nel primo Novecento il povero Filippo Tommaso Marinetti, appena sbarcato a Parigi con grande vanto d’esser italiano, passava il suo tempo a sfidare a duello i denigratori, i francesi che sputacchiavano spernacchiando nel commentare ogni cosa proveniente dall’altra parte delle Alpi, sulle orme di Stendhal, pur invidiandoci molto come il loro romanziere; più recentemente, i tedeschi ci condannavano per mancanza di valore bellico, maledicevano le alleanze con simili infingardi e intanto, sui campi di battaglia, guadagnano assai poco dalla loro arte militare. Insomma, nient’altro che l’antico odio mal truccato per il paese che non si adatta ai parametri correnti moderni benché abbia inventato la modernità. Oggi è un capitano di una multinazionale delle crociere che fa affondare una nave in un bicchier d’acqua a fornire il pretesto per l’insulto tedesco alla «codardia degli italiani», il che suscita una risposta muscolosa di un giornale milanese, alla maniera dei nazionalisti primi Novecento. I quali a loro volta pretendevano, come un baffuto politico della sinistra, che l’Italia fosse o potesse almeno diventare «un paese normale». Sciocca richiesta, la penisola italiana è irriducibile alle altre patrie. Nostra prima gloria è proprio la mancanza di meschineria sciovinista.
Questo l’antieroismo di cui si parlò spesso e che un giovanissimo Leopardi (forse riecheggiando il padre Monaldo, sicuramente Francesco Petrarca), in uno scritto poco noto, difese con bella retorica: «La nostra nazione riunita tutta sotto un sol capo sarebbe formidabile ai suoi nemici; un popolo, come il nostro generoso e nobile, colle immense risorse somministrate dal suo territorio e dalle sue facoltà intellettuali, potrebbe concepire dei vasti disegni ed ottenere dei grandi successi. Egli fu un tempo signore dell'universo, potrebbe ora gettar dell’ombra su tutte le nazioni. Ma l’Italia sarebbe perciò felice? Per asserirlo, converrebbe supporre che la felicità della nazione consista nella forza delle armi, nell’esser terribile allo straniero, nel poter con vantaggio cominciare una guerra e continuarla senza cedere, nel possedere tutto ciò che fa d’uopo per esser temuta e che è necessario per non temere, nell’abbondanza dei mezzi per sostenere la gloria dei propri eserciti e la fortuna delle proprie armi. Ma se la vera felicità dei popoli è riposta nella pace necessaria alle arti utili, alle lettere, alle scienze, nella prosperità del commercio e dell’agricoltura, fonti della ricchezza delle nazioni, nell’amministrazione paterna di Sovrani amati e legittimi; possiam dirlo con verità, non v’ha popolo più felice dell’italiano». Ai nazionalismi montanti, preferiva infatti la felicità pigra della provincia, la dolce vita che sempre sopravvive alle imitazioni penose dei costumi altrui: «Divisa in piccoli regni, l’Italia offre lo spettacolo vario e lusinghiero di numerose capitali animate da corti floride e brillanti, che rendono il nostro suolo sì bello agli occhi dello straniero. Questa specie di grandezza può consolarci di quella che noi perderemmo. Sì, noi fummo grandi una volta: noi rigettammo quei Galli, che il tempo ha resi più forti, fuori delle nostre terre, noi li cacciammo alle loro tane, noi li soggiogammo, noi li facemmo nostri schiavi. Dalle colonne di Ercole sino al Caucaso noi stendemmo la gloria del nostro nome e il terrore delle nostre armi. Tutto si sottomise al nostro impero, tutto cedè al nostro valore, e noi fummo i signori del mondo. Fummo per questo felici? Le discordie civili, le guerre, le vittorie stesse non ci lasciavano un’ora di quella pace che tutto il mondo sospira. Il tempio di Giano sempre aperto vomitava disordini e sventure. Padroni dell’universo, noi non lo eravamo di noi stessi. Ci convenne conquistare la sede delle scienze per apprendere a regolare le nostre passioni. Terribili a tutto il mondo, noi eravamo, ciò che ora è la Francia […] La nostra grandezza, la nostra felicità deve dunque consistere in fare degli infelici? Italiani! rinunziamo al brillante ed appigliamoci al solido. Quando ci si propone un potere pernicioso o una pace di cui tutto ci garantisce la durata, rigettiamo l’uno ed eleggiamo l’altra: quello ci darebbe dei nomi e questa ci dà delle cose; quello una gloria fantastica e questa dei reali vantaggi. Una nazione non deve esitare nella scelta della sua vera felicità». (Agl’Italiani. Orazione in occasione della liberazione del Piceno, 1815). Però, a quei tempi – come Leopardi osserverà in uno scritto successivo e già di parere diverso, dove si atteggia ad arcigno critico dei suoi compatrioti – ancora dell’opinione pubblica «gl’italiani, in generale, e parlando massimamente a proporzion degli altri popoli, non ne fanno alcun conto. Corrono e si ripetono tutto giorno cento proverbi in Italia che affermano che non s’ha da por mente a quello che il mondo dice o dirà di te, che s’ha da procedere a modo suo, non curandosi del giudizio degli altri, e cose tali…» (Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani). Adesso, come in tutte le epoche della più rovinosa decadenza, si idolatra ogni rabbuffo o sorrisetto o moda o titolo di giornale che venga dall’estero...