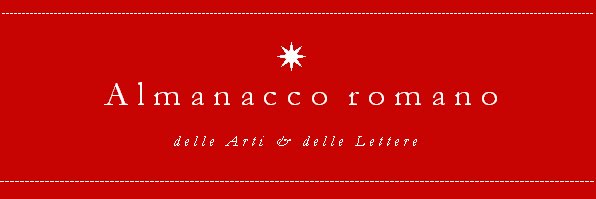Calendario dell’Avvento 17. Pio XII, nella notte
I depravati pretendono spesso che mezza umanità abbia i loro stessi desideri, i membri delle camorre fanno credere che anche gli onesti siano associati in qualche camarilla, corrotti e corruttori si mettono l’animo in pace ripetendo che così fan tutti; mal comune minore colpa è il confortevole luogo comune, ma che per alleviare le colpe dei nazisti ( e dei loro alleati italiani) si chiami in correo la Chiesa cattolica, come fa un signore che sul fascismo si è formato, è semplicemente miserevole. Ancor più ridicola l’opposizione che plaude al pentito perché fa i nomi che loro vogliono, non rendendosi conto che simili discorsi portano acqua al mulino nazista più di ogni dubbio e distinzione sulle cifre dei morti da parte dei revisionisti: altro che fenomeno unico lo sterminio moderno degli ebrei, – come ci aveva insegnato Adorno nelle pagine finali di Minima moralia –, l‘orrore razziale sarebbe invece nient’altro che un semplice errore collettivo, cui partecipò tutta Europa e addirittura la massima istituzione benefica su questa terra, sia pure in forma di complice silente. Tutti insieme appassionatamente, l’umanità è debole e negli anni trenta del Novecento prese un clamoroso abbaglio, questa è la storia insegnata dai politici italiani di destra e di sinistra. Sennonché ci sono parole che inchiodano ai loro imbrogli chi prova a confondere i ricordi. Nella notte di Natale del 1942, nella notte della Seconda guerra mondiale, quando ancora non era chiaro chi sarebbe uscito vincitore, il pontefice romano parlava ai popoli del mondo con un linguaggio fermo e solenne – ci sono stolti che vorrebbero vedere utilizzati i loro gerghi attuali da uomini di altri secoli –, con un linguaggio religioso non certo politico, e sembrava l’unica autorità morale in un incrocio di barbarie, l’unico non compromesso con le miserie del tempo, un degno successore di Leone Magno di fronte ad Attila, che ripeteva a chiare lettere la dottrina della Chiesa, la critica dell’assolutismo statale, la denuncia dei mali della guerra e dei mali che ne furono la causa, che parlava delle «centinaia di migliaio di persone, le quali, senza veruna colpa propria, talora solo per ragione di nazionalità o di stirpe, sono destinate alla morte o ad un progressivo deperimento». Chi altro in quel tempo, pronunciò una denuncia come questa? Quale altra radio trasmise al mondo una sferzante ricognizione degli errori dell’ideologia nazista? Forse è proprio per un tale motivo che i complici degli assassini e i vigliacchi che non seppero resistere provarono poi a sporcare quella nobile figura.
Del lungo radiomessaggio, qui se ne riproducono solo alcuni passi.
Il santo Natale e l'umanità dolorante
24 dicembre 1942
Con sempre nuova freschezza di letizia e di pietà, diletti figli dell'universo intero, ogni anno al ricorrere del Santo Natale, risuona dal presepe di Betlemme all'orecchio dei cristiani, ripercuotendosi dolcemente nei loro cuori, il messaggio di Gesù, luce in mezzo alle tenebre; un messaggio che illumina con lo splendore di celestiali verità un mondo oscurato da tragici errori, infonde una gioia esuberante e fiduciosa ad un'umanità, angosciata da profonda e amara tristezza, proclama la libertà ai figli d'Adamo, costretti nelle catene del peccato e della colpa, promette misericordia, amore, pace alle schiere infinite dei sofferenti e tribolati, che vedono scomparsa la loro felicità e spezzate le loro energie nella bufera di lotta e di odio dei nostri giorni burrascosi.
E i sacri bronzi, annunziatori di tale messaggio in tutti i continenti, non pur ricordano il dono divino, fatto all'umanità, negli inizi dell'età cristiana; ma annunziano e proclamano anche una consolante realtà presente, realtà come eternamente giovane, così sempre viva e vivificante; realtà della "luce vera, la quale illumina ogni uomo, che viene in questo mondo" e non conosce tramonto. L'Eterno Verbo, via, verità e vita, nascendo nello squallore di una grotta e nobilitando in tal modo e santificando la povertà, così dava inizio alla sua missione di dottrina, di salute e di redenzione del genere umano, e diceva e consacrava una parola, che è ancor oggi la parola di vita eterna, valevole a risolvere i quesiti più tormentosi, insoluti e insolubili da chi vi porti vedute e mezzi effimeri e puramente umani; quesiti i quali si affacciano sanguinanti, esigendo imperiosamente una risposta, al pensiero e al sentimento di una umanità amareggiata ed esacerbata.
Il motto "Misereor super turbam" è per Noi una consegna sacra, inviolabile, valida e impellente in tutti i tempi e in tutte le situazioni umane, com'era la divisa di Gesù; e la Chiesa rinnegherebbe se stessa, cessando di essere madre, se si rendesse sorda al grido angoscioso e filiale, che tutte le classi dell'umanità fanno arrivare al suo orecchio. […]
Una chiara intelligenza dei fondamenti genuini di ogni vita sociale ha un'importanza capitale oggi più che mai, mentre l'umanità, intossicata dalla virulenza di errori e traviamenti sociali, tormentata dalla febbre della discordia di desideri, dottrine e intenti, si dibatte angosciosamente nel disordine, da essa stessa creato, e risente gli effetti della forza distruttrice di idee sociali erronee, le quali dimenticano le norme di Dio o sono ad esse contrarie. E poiché il disordine non può essere superato se non con un ordine, che non sia meramente forzato e fittizio (non altrimenti che l'oscurità coi suoi deprimenti e paurosi effetti non può essere bandita se non dalla luce, e non da fuochi fatui); la salvezza, il rinnovamento e un progressivo miglioramento non può aspettarsi e originarsi se non da un ritorno di larghi e influenti ceti alla retta concezione sociale; un ritorno che richiede una straordinaria grazia di Dio e una volontà incrollabile, pronta e presta al sacrificio, degli animi buoni e lungimiranti. […]
L'ordinamento giuridico ha inoltre l'alto e arduo scopo di assicurare gli armonici rapporti sia tra gli individui, sia tra le società, sia anche nell'interno di queste. A ciò si arriverà, se i legislatori si asterranno dal seguire quelle pericolose teorie e prassi, infauste alla comunità e alla sua coesione, le quali traggono la loro origine e diffusione da una serie di postulati erronei. Tra questi è da annoverare il positivismo giuridico, che attribuisce una ingannevole maestà alla emanazione di leggi puramente umane, e spiana la via ad un esiziale distacco della legge dalla moralità; inoltre la concezione, la quale rivendica a particolari nazioni o stirpi o classi l'istinto giuridico, quale ultimo imperativo e inappellabile norma; infine quelle varie teorie, le quali, diverse in sé e procedenti da vedute ideologiche contrastanti, si accordano però nel considerare lo Stato o un ceto, che lo rappresenti, come entità assoluta e suprema, esente da controllo e da critica, anche quando i suoi postulati teorici e pratici sboccano e urtano nell'aperta negazione di dati essenziali della coscienza umana e cristiana. […]
Per un cristiano, cosciente della sua responsabilità anche verso il più piccolo dei suoi fratelli, non vi è tranquillità infingarda, né si dà fuga, ma lotta, ma azione contro ogni inazione e diserzione nel grande agone spirituale, dove è proposta in palio la costruzione, anzi l'anima stessa della società futura. […]
Oggi più che mai scocca l'ora di riparare; di scuotere la coscienza del mondo dal grave torpore, in cui i tossici di false idee, largamente diffuse, l'hanno fatto cadere; tanto più che, in questa ora di sfacelo materiale e morale, la conoscenza della fragilità e della inconsistenza di ogni ordinamento puramente umano è sul disingannare anche coloro, che, in giorni apparentemente felici, non sentivano in sé e nella società la mancanza di contatto coll'eterno, e non la consideravano come un difetto essenziale delle loro costruzioni. […]
Non lamento, ma azione è il precetto dell'ora; non lamento su ciò che è o che fu, ma ricostruzione di ciò che sorgerà e deve sorgere a bene della società. Pervasi da un entusiasmo di crociati, ai migliori e più eletti membri della cristianità spetta riunirsi nello spirito di verità, di giustizia e di amore al grido: Dio lo vuole! pronti a servire, a sacrificarsi, come gli antichi Crociati. Se allora trattavasi della liberazione della terra santificata dalla vita del Verbo di Dio incarnato, si tratta oggi, se possiamo così esprimerci, del nuovo tragitto, superando il mare degli errori del giorno e del tempo, per liberare la terra santa spirituale, destinata a essere il sostrato e il fondamento di norme e leggi immutabili per costruzioni sociali di interna solida consistenza.
Per sì alto fine, dal presepe del Principe della pace, fiduciosi che la sua grazia si diffonda in tutti i cuori, Noi Ci rivolgiamo a voi, diletti figli, che riconoscete e adorate in Cristo il vostro Salvatore, a tutti quelli che sono con noi uniti almeno col vincolo spirituale della fede in Dio, a tutti infine, quanti anelano a liberarsi dai dubbi e dagli errori, bramosi di luce e guida; e vi esortiamo con scongiurante paterna insistenza non solo a comprendere intimamente l'angosciosa serietà di quest'ora, ma anche a meditare le sue possibili aurore benefiche e soprannaturali, e a unirvi e operare insieme per il rinnovamento della società in spirito e verità.
Scopo essenziale di questa Crociata necessaria e santa è che la stella della pace, la stella di Betlemme, spunti di nuovo su tutta l'umanità nel suo rutilante fulgore, nel suo pacificante conforto, qual promessa e augurio di un avvenire migliore più fecondo e più felice. […]
Chi vuole che la stella della pace spunti e si fermi sulla società, concorra da parte sua a ridonare alla persona umana la dignità concessale da Dio fin dal principio; si opponga all'eccessivo aggruppamene degli uomini, quasi come masse senz'anima; alla loro inconsistenza economica, sociale, politica, intellettuale e morale; alla loro mancanza di solidi principi e di forti convinzioni; alla loro sovrabbondanza di eccitazioni istintive e sensibili, e alla loro volubilità; favorisca, con tutti i mezzi leciti, in tutti i campi della vita, forme sociali, in cui sia resa possibile e garantita una piena responsabilità personale, così quanto all'ordine terreno come quanto all'eterno; sostenga il rispetto e la pratica attuazione dei seguenti fondamentali diritti della persona: il diritto a mantenere e sviluppare la vita corporale, intellettuale e morale, e particolarmente il diritto ad una formazione ed educazione religiosa; il diritto al culto di Dio privato e pubblico, compresa l'azione caritativa religiosa; il diritto, in massima, al matrimonio e al conseguimento del suo scopo, il diritto alla società coniugale e domestica; il diritto di lavorare come mezzo indispensabile al mantenimento della vita familiare; il diritto alla libera scelta dello stato, quindi anche dello stato sacerdotale e religioso; il diritto ad un uso dei beni materiali, cosciente dei suoi doveri e delle limitazioni sociali. […]
Chi vuole che la stella della pace spunti e si fermi sulla società, rifiuti ogni forma di materialismo, che non vede nel popolo se non un gregge di individui, i quali, scissi e senza interna consistenza, vengono considerati come materia di dominio e di arbitrio […]
Il risanamento di questa situazione diventa possibile a ottenersi, quando si ridesti la coscienza di un ordinamento giuridico, riposante nel sommo dominio di Dio e custodita da ogni arbitrio umano; coscienza di un ordinamento che stenda la sua mano protettrice e punitrice anche sugli inobliabili diritti dell'uomo e li protegga contro gli attacchi di ogni potere umano. […]
Il rapporto dell'uomo verso l'uomo, dell'individuo verso la società, verso l'autorità, verso i doveri civili, il rapporto della società e dell'autorità verso i singoli debbono essere posti sopra un chiaro fondamento giuridico e tutelati, al bisogno, dall'autorità giudiziaria. Ciò suppone: un tribunale e un giudice, che prendano le direttive da un diritto chiaramente formulato e circoscritto; chiare norme giuridiche, che non possano essere stravolte con abusivi richiami ad un supposto sentimento popolare e con mere ragioni di utilità; riconoscimento del principio che anche lo Stato e i funzionari e le organizzazioni da esso dipendenti sono obbligati alla riparazione e al ritiro di misure lesive della libertà, della proprietà, dell'onore, dell'avanzamento e della salute dei singoli. […]
Diletti figli! Voglia Dio che, mentre la Nostra voce arriva al vostro orecchio, il vostro cuore sia profondamente scosso e commosso dalla serietà profonda, dall'ardente sollecitudine, dalla scongiurante insistenza, con cui Noi vi inculchiamo questi pensieri, che vogliono essere un appello alla coscienza universale e un grido di raccolta per tutti quelli che sono pronti a ponderare e misurare la grandezza della loro missione e responsabilità dalla vastità della sciagura universale. […]
Questo voto l'umanità lo deve agli innumerevoli morti, che giacciono sepolti nei campi di guerra[…], questo voto l'umanità lo deve a quegli innumerevoli esuli che l'uragano della guerra ha spiantati dalla loro patria e dispersi in terra straniera[…], questo voto l'umanità lo deve alle centinaia di migliaio di persone, le quali, senza veruna colpa propria, talora solo per ragione di nazionalità o di stirpe, sono destinate alla morte o ad un progressivo deperimento. […]